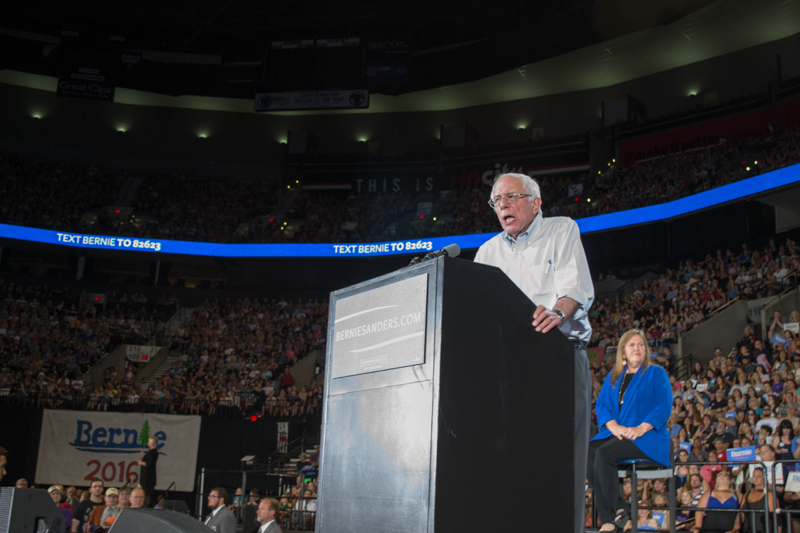La ricetta norvegese
Testo e foto di Piergiorgio Pescali
Da molti anni la Norvegia si situa ai primi posti nella classifica dell’Indice di sviluppo umano. I suoi abitanti – poco più di 5 milioni – hanno un’elevata qualità della vita. Il Fondo sovrano norvegese – che gestisce i corposi proventi del petrolio – è ricchissimo, ma anche attento all’etica dei propri investimenti. Nonostante tutto questo, ci sono questioni aperte. Per esempio, anche a queste latitudini i problemi ambientali sono in rapido aumento. Inoltre, i norvegesi stanno cercando di porre un freno all’immigrazione, anche premiando partiti populisti anti immigrati. La ricetta complessiva rimane buona, ma oggi il paese deve trovare risposte adeguate alle nuove sfide.
«Guarda la mappa della Norvegia: un pugno con un dito indice che si allunga verso nord, quasi come a voler toccare l’inviolabile, le terre ostili che si frammentano nel Finnmark». Morten Andreassen mi mostra la cartina della Norvegia mentre è seduto su un masso addentando con gusto un panino. Sta studiando per ottenere un Master in Scienze della globalizzazione e sviluppo sostenibile all’Ntnu, l’Università norvegese di Scienze e tecnologia di Trondheim, l’istituto scientifico più prestigioso del paese dalle cui aule sono usciti cinque premi Nobel. Ogni anno l’Ntnu organizza il Big Challenge Science Festival, uno dei simposi scientifici più seguiti al mondo in cui, per quattro giorni, scienza e spettacolo si mischiano in una serie di eventi memorabili coinvolgendo moltissimi dei duecentomila abitanti di Trondheim e trasformando questa cittadina in una capitale della cultura scientifica, umanistica e artistica.
L’atmosfera tranquilla, ma al tempo stesso pregna di stimoli intellettuali di Trondheim, associata all’eccellente livello di insegnamento impartito nell’Ntnu ha fatto sì che i suoi ricercatori e studenti siano contesi da compagnie e centri di ricerca di tutto il mondo: «Potenzialmente abbiamo un tasso di disoccupazione inferiore allo zero», scherza Magnhild, la ragazza che viaggia con Morten.
Lei, dopo la laurea, è tornata a Tromso, la cittadina dove è nata, per lavorare in una compagnia che si occupa di energie rinnovabili. Magnhild è andata a Oslo a trovare la famiglia di Morten e quest’anno hanno deciso di tornare a Trondheim percorrendo a piedi i 643 chilometri del «Sentiero di Sant’Olav» (foto alle pagine 41-42), il cammino di pellegrinaggio che, partendo dalla Vecchia Chiesa di Aker ad Oslo termina alla cattedrale di Nidaros, dove nell’XI secolo fu sepolto Olav Haraldsson (995-1030), il Rex Perpetuus Norvegiae e patrono della nazione (nonché santo e martire per la Chiesa cattolica).
«Non siamo credenti, anzi siamo atei convinti, ma abbiamo approfittato di trascorrere quattro settimane a stretto contatto con la natura per raccogliere dati sui cambiamenti climatici per le nostre ricerche».
Il Sentiero di Olav, l’università di Trondheim, la passione di Morten e Magnhild per la natura – espressione del friluftsliv[1] che accomuna i norvegesi – e il rispetto verso l’ambiente sono le basi da cui parto per cercare di comprendere quale possa essere stata la chiave che ha portato, in pochi decenni, un popolo povero e circondato da una natura ostile ad occupare oramai da diversi anni, le prime posizioni nelle statistiche dell’Indice di sviluppo umano[2].

Una tigre in Norvegia: la città contro la natura
La statua della tigre che ruggisce – realizzata da Elena Engelsen e dal 2000 posta fuori dalla stazione ferroviaria di Oslo – è forse l’emblema di una città e una nazione che sta cambiando più velocemente di quanto vorrebbe. L’artista voleva rappresentare la vivacità e lo sviluppo della Tigerstaden, la città della tigre, il soprannome con cui oggi è conosciuta Oslo, ma a molti norvegesi il felino ricorda i versi scritti nel 1870 dal poeta Bjornstjerne Bjornson, premio Nobel nel 1903 e autore delle parole dell’inno norvegese, il quale contrapponeva l’immagine pericolosa, violenta e aggressiva della città a quella bucolica, pacifica e genuina della campagna[3].
Sicuramente ai turisti orientali che sempre più numerosi affollano la capitale norvegese, quella statua ricorderà le «tigri asiatiche», le quattro economie dell’Asia (Singapore, Taiwan, Hong Kong e Corea del Sud) che negli anni Novanta bruciavano le tappe dello sviluppo crescendo a dismisura sino a diventare il simbolo di quella riscossa asiatica che, più tardi, avrebbe trovato nella Cina la sua locomotiva.
L’economia norvegese non viaggia quanto le tigri asiatiche (ormai anch’esse sedate) ma la crescita del Pil continua ad aggirarsi attorno ad un onorevole 2% ed Oslo – con circa 700mila abitanti – è considerata la città che si espande più velocemente tra le capitali dell’Europa[4].
Definire la capitale della Norvegia una bella città è una forzatura e il paragone con le «colleghe» scandinave è impietoso: la sua storia è sempre stata offuscata dalle più regali Copenaghen e Stoccolma, i cui regni si sono succeduti pressoché ininterrottamente alla guida della Norvegia dal IX secolo al 1905, quando la nazione trovò la sua indipendenza. Città prettamente operaia e industriale, Oslo non ha certo la grazia di Bergen o il fascino dell’art nouveau di Alesund. Al contrario, la città, che riacquistò il nome originario solo nel 1925 abbandonando il toponimo di Christiania affibbiatole dal re di Danimarca Cristiano IV, è sempre stata quella descritta, con un misto di sagacia e melanconia, da Luigi Di Ruscio, il poeta-operaio emigrato dall’Italia nel 1957 e morto ad Oslo nel 2011: «Poi ci sono i lunghi inverni gelati con le giornate cortissime e le lunghissime notti, le nevi che persistono per mesi e alla fine da bianche che erano diventano nere ed Oslo diventa la città dalla neve nera»[5].

Eppure, l’amministrazione locale è riuscita a realizzare quello che, sino a pochi anni fa, sembrava impossibile: conferire una fisionomia e una personalità unica alla metropoli. Sapendo di non poter competere sul piano monumentale e storico con altri centri scandinavi ed europei, si sono scelti altri campi per rendere Oslo città appetibile al turismo e alla finanza: l’architettura moderna, la cultura e la natura. Gli amministratori norvegesi, con la collaborazione di architetti provenienti da tutto il mondo, hanno trasformato una città anonima e grigia in un interessante esperimento di design urbanistico quasi senza stravolgerne l’assetto storico e valorizzando gli edifici esistenti. Le gru che si innalzano da numerosi quartieri stanno rivoluzionando lo skyline di Oslo che, dal 2020 si doterà di nuovi spazi abitativi, finanziari e culturali offrendo a turisti e abitanti un nuovo volto, più moderno e accattivante.
Accanto all’Opera House stanno sorgendo centri residenziali e lavorativi hi-tech: il Barcode, il Sorenga, il Museo Munch, la Biblioteca nazionale, mentre nell’Aker Brygge tra pochi mesi verrà inaugurata l’immensa Galleria nazionale che si affiancherà al Nobel Peace Centre. Al tempo stesso i polmoni verdi, vero vanto del rispetto ambientale di cui si fregia la città, sono stati mantenuti. Un efficiente e relativamente poco costoso sistema di mezzi pubblici collega 24 ore su 24, sette giorni su sette, anche i quartieri più periferici. In meno di un’ora è possibile raggiungere piste da sci, rifugi immersi nella natura, sentieri montani lasciando la propria auto nel garage. Oslo non è bella, ma è sicuramente la città ideale in cui vivere.
Le sfide ambientali: cambiamento climatico, petrolio, disboscamento, turismo
Quello norvegese è tradizionalmente un popolo culturalmente coeso, che ha fatto del rispetto per la natura uno dei suoi cavalli di battaglia.
«Se chiedi ad un turista medio cosa vorrebbe vedere andando in Norvegia ti risponderebbe “i fiordi”; un turista un po’ più accorto aggiungerebbe Capo Nord o Lofoten. Pochi si aspettano di vedere città come Oslo o Stavanger» mi spiega Gunn Wadzynski, attivista ambientalista di Greenpeace, che poi continua: «Lo stereotipo della Norvegia è che sia un territorio selvaggio, inesplorato, incontaminato e, soprattutto, non inquinato. Purtroppo, la realtà sta cambiando molto velocemente: l’ambiente soffre sempre di più e non solo per i cambiamenti climatici, ma anche per lo sfruttamento che noi norvegesi operiamo sul nostro territorio».
Ogni anno dieci milioni di turisti arrivano in Norvegia, di cui tre milioni su navi da crociera ed oramai il 4,2% del Pil dipende dal loro[6].
L’aumento del turismo è sicuramente una delle cause del degrado ambientale, ma il danno più evidente è dovuto ad un fattore esterno – i cambiamenti climatici mondiali – e uno interno, il continuo dissanguamento delle risorse naturali, causato in particolare dall’estrazione petrolifera e dal disboscamento.

Nel 2016 la temperatura media nelle Svalbard, il piccolo arcipelago situato più a settentrione del paese, è stata di 6,6°C superiore a quella normale[7]. Anche se i dati relativi a questa statistica sono stati contestati da molti ricercatori in quanto basati su una rilevazione effettuata presso l’aeroporto di Longyearbyen e quindi falsati dal microclima esistente in quella specifica parte dell’isola, è un dato di fatto che la coltre di ghiaccio in tutto il Circolo polare artico si sta assottigliando[8].
Per contrastare l’aumento di temperatura, la Norvegia si è data come obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni di CO2 del 40% rispetto al 2005.
Uno studio preliminare ha individuato che il 74% delle emissioni di gas serra proviene da due settori: trasporti e agricoltura[9]. È quindi in queste due attività che il governo ha cercato di intervenire con più incisività.
Tra il 1990 e il 2013 sono stati disboscati 140mila ettari di foresta, cosa che ha contribuito per il 4-5% dell’emissione della CO2. Il 33% della deforestazione è stato effettuato per costruire nuove strade, ferrovie e abitazioni, l’11% per linee elettriche e impianti sciistici e il 31% per usi agricoli[10].
«Il 21% dell’abbattimento avviene prima che l’albero raggiunga lo stadio V, la fase oltre la quale il fusto ha ormai sorpassato il tasso di massimo assorbimento di anidride carbonica ed è pronto per la sostituzione», specifica Sigurd Sivertsen, del dipartimento di ingegneria ambientale all’Ntnu[11].
Durante il XX secolo la Norvegia ha implementato una politica di rimboschimento e nei prossimi anni le foreste piantate negli anni Cinquanta e Sessanta raggiungeranno la loro completa maturazione con una diminuzione del tasso di assorbimento di CO2. Per ripristinare la fotosintesi clorofilliana necessaria per mantenere l’equilibrio naturale, nel 2013 la Norwegian environment agency ha proposto la riforestazione di 100mila ettari di terreno per i successivi venti anni che, una volta completata, potrebbe rimuovere 1,8 milioni di tonnellate annue di CO2 nel 2050[12].
Per accelerare l’accrescimento del tronco fino ad un 10-15%, i laboratori di ricerca norvegesi hanno sviluppato un programma di modificazione genetica che, sommato alle tecniche di inseminazione, potrebbe permettere di stare al passo con il programma di assorbimento dei gas serra senza aumentare la superficie boschiva del paese.

Naturalmente questa tecnica invasiva ha riscontrato l’ostilità di numerose organizzazioni ambientaliste: Turid, dell’associazione radicale (e per molti versi cospirazionista) Green Warriors di Bergen afferma che «Il 75% dei nuovi semi utilizzati per la sostituzione degli alberi abbattuti in Norvegia sono geneticamente modificati. In questo modo le politiche ambientaliste del nostro paese sono un palliativo per permettere comunque alle compagnie che contribuiscono all’aumento delle temperature mondiali di continuare a operare le loro politiche distruttive». La critica di Turid ha un fondo di verità, ma la realtà norvegese ci offre una visione molto più variegata che è osservata con interesse da molti attori internazionali: nel 2015 le energie rinnovabili rappresentavano il 46% dell’energia totale fornita al mercato norvegese. Certamente la bassa densità di popolazione e la ricchezza del territorio (il 40% dell’energia utilizzata è idroelettrica[13]) gioca un ruolo determinante nel successo del modello Norvegia, che comunque è ancora lontana dall’escludere le fonti fossili dalla sua dipendenza energetica (il petrolio fornisce il 36,8% dell’energia e il gas naturale il 18,2%[14]).
Al tempo stesso l’utilizzo di fonti naturali permette alla nazione di avere un prezzo al consumatore tra i più bassi in Europa nonostante una tassazione del 38%: 38 euro/MWh (megawattora) contro i 54 euro/MWh che paga un italiano[15].
Così, nonostante un norvegese consumi 5,20 «Tonnellate di petrolio equivalente» (Tep) ogni anno contro una media europea di 4,11, l’impatto ambientale diretto è inferiore rispetto ai cittadini del Vecchio continente[16].

Elettrico sì, ma senza incentivi
Una delle principali azioni espresse dal governo di Oslo per contenere e ridurre l’impatto ecologico nella nazione è stata quella di sostenere l’uso dell’auto elettrica (Ev) mediante un programma di incentivi statali, introdotti sin dalla fine degli anni Novanta per aiutare lo sviluppo della Kewet, una macchina elettrica prodotta da una fabbrica danese che nel 1998 era stata venduta alla norvegese Elbil Norge As[17]. Nel 1997 le macchine Ev[18] hanno ottenuto l’esenzione completa dai pedaggi stradali, nel 1999 dal pagamento dei parcheggi (dal 2017 la gratuità è a discrezione di ogni municipalità), dal 2001 l’esenzione dell’Iva e dal 2009 vengono trasportate gratuitamente sui traghetti.
Qualcosa però sta cambiando anche nel paese: nel 2018 il 31,2% delle nuove auto vendute in Norvegia era Ev e Phev (auto ibride)[19], con queste ultime in costante ascesa[20]. Lungi dal rappresentare una coscienza ecologica popolare, le auto Ev vengono comprate per una questione economica più che ambientale: il 63% dei norvegesi che hanno un’auto completamente elettrica ha anche una seconda auto ibrida o a combustibile fossile.
I motivi sono diversi: in primo luogo lo sviluppo del sistema delle colonnine di ricarica che, pur essendo il più capillare d’Europa, è ancora insufficiente per rendere indipendente la circolazione sull’intero territorio. Al 2 aprile 2019 in Norvegia vi erano 12.612 ricariche (di cui 2.361 a carica veloce, 616 dedicate alla Tesla supercharges[21]); un incremento importante rispetto al 2011 (allora c’erano 3mila colonnine), ma che non segue quello delle vendite e questo ha disincentivato l’acquisto di auto esclusivamente Ev[22].
In secondo luogo, gli incentivi funzionano da motore per chi deve usare l’auto su strade a pedaggi e su traghetti: la più alta concentrazione di auto elettriche al mondo la si trova a Finnoy, un’isola di fronte a Stavanger. Qui il pedaggio del tunnel che connette l’isola alla terraferma costa 150 nok sola andata: un sondaggio della Neva (Norwegian Electric Vehicle Association) ha constatato che gli acquirenti hanno comprato le Ev per non pagare il pedaggio (300 nok al giorno).
Tutto questo, però ha un costo che comincia a diventare troppo ingente per l’economia norvegese: l’Istituto per l’Economia dei trasporti nel 2015 ha stimato che i mancati introiti per lo stato erano pari a 4 miliardi di nok, ancora sostenibili per l’economia norvegese, ma dovranno essere ben presto rivisti. Per ora il governo ha stabilito che le agevolazioni per l’acquisto di auto elettriche verranno mantenute fino al 2020 anche per permettere, entro quella data, alla città di Oslo di rispettare il programma di eliminare completamente i trasporti pubblici a carburante fossile utilizzando solo quelli elettrici.
Le prime voci di dissenso verso questa politica si fanno già sentire dagli scranni dell’opposizione parlamentare: «Non possiamo continuare a finanziare le macchine elettriche», dice Andreas Halse, portavoce per l’ambiente del Partito labourista. Anche le compagnie navali hanno cominciato ad alzare i toni della protesta, così come le società che gestiscono le infrastrutture stradali.
Paradossalmente gli stimoli economici hanno avuto un effetto deleterio sulla circolazione: oltre a non eliminare le macchine a combustibile fossile, disincentivano l’uso dei mezzi pubblici.
Oggi, dunque, il governo si trova di fronte al dilemma su come rendere il mercato delle auto elettriche appetibile al consumatore senza dover offrire promozioni.

Socialità e risparmio energetico
La Norvegia sta cercando di far fronte all’emissione di gas serra anche affrontando la questione del costo della vita che rende problematico per le giovani generazioni l’affrancamento dalle famiglie.
L’affitto medio mensile di un monolocale in centro a Oslo costa circa 1.000 euro, mentre l’acquisto varia da 4.000 euro al metro quadro per un appartamento fuori dal centro a 6.000 euro al metro quadro in centro[23]. Un salasso anche per uno stipendio medio norvegese che si aggira sui tremila euro netti al mese[24].
Dal 2020 le nuove costruzioni dovranno essere energeticamente completamente autonome così da risparmiare, entro il 2030, dieci TWh (terawattora) di consumo, mentre verrà vietato l’uso di riscaldamento fossile per tutti i restanti edifici (attualmente solo il 20% del parco immobiliare è dotato di riscaldamento con energia rinnovabile). Queste direttive (costose e impegnative) hanno indotto gli architetti norvegesi a cercare soluzioni alternative trovandole nelle abitazioni collettive, edifici in cui si cerca di coniugare l’indipendenza del nucleo famigliare con il taglio dei costi e la diminuzione dello spreco energetico. Il co-housing o collective-housing non è una novità nei paesi nordici essendo già praticato negli anni Settanta-Ottanta, ma con l’arrivo del benessere e della ricchezza era andato via via scomparendo. L’esigenza di una propria vita privata è stata preservata garantendo ad ogni famiglia un proprio spazio indipendente e riservato, mentre ci si affida alla gestione collettiva per quelle attività prettamente socializzanti, come una stanza comune per la mensa, le attività ricreative, il giardino.

Una trappola per l’anidride carbonica
Il governo, però, non si affida solo ai singoli cittadini per combattere l’effetto serra: dagli anni Ottanta la nazione ha intrapreso un percorso di ricerca e sviluppo nel campo del Ccs (Carbon capture and storage, Cattura e stoccaggio del carbonio), un processo che, dopo aver liquefatto l’anidride carbonica la inietta in una trappola geologica dove viene stoccata per centinaia di anni. È un metodo utilizzato per ridurre la quantità di CO2 liberata nell’aria, tanto che Oslo ha individuato nel Ccs una delle cinque priorità per contenere l’aumento di CO2 entro il 2030, ma il processo ha anche diverse problematiche evidenziate dagli ecologisti: il gas, che viene iniettato in sacche di terreno cavo (spesso dopo avere estratto petrolio o gas naturale), potrebbe liberarsi improvvisamente a seguito di terremoti avvelenando e asfissiando gli esseri viventi che stanno nelle immediate vicinanze.
Gli scienziati e tecnici norvegesi stanno sfruttando due siti offshore adatti al Ccs: Sleipner and Snøhvit, in cui la CO2 è insufflata a migliaia di metri di profondità (800-1.000 metri a Sleipner e 2.000 metri a Snøhvit), mentre un terzo giacimento esaurito (Troll, nel Mare del Nord) ha avuto il benestare del governo per il suo sfruttamento lo scorso gennaio[25]. «Sino ad oggi sono stati immagazzinati 21 milioni di tonnellate di CO2», spiegano alla Gassnova, l’azienda leader nella ricerca e sviluppo del Ccs, la cui esperienza ha permesso di esportare le tecniche Ccs maturate in Norvegia in diversi paesi (Cina, Indonesia, Sud Africa, paesi del Golfo Persico) e iniziare una collaborazione con molte istituzioni internazionali.
I centri di ricerca Ccs sono tre: il Tcm (Technology Centre Mongstad), Climit e il Norwegian Ccs Research Centre (Nccs). Tra questi il Tcm, operativo dal 2012, è il più grande al mondo ed è di proprietà di un consorzio di aziende guidate dalla Gassnova (77,5%), Equinor (7,5%), Shell (7,5%) e Total (7,5%)[26].

Il peso del petrolio sul Pil norvegese
In tutto questo bel programma ambientale il petrolio continua ad occupare una posizione rilevante nell’economia e nelle società norvegesi. Lungi dall’esserne indipendente, la Norvegia è ancora fortemente vincolata alle fonti fossili che contribuiscono per il 12% al Pil, per il 13% agli introiti erariali del governo centrale, per il 37% alle esportazioni e per il 21% agli investimenti nonostante la produzione sia diminuita del 40% rispetto al 2001 (due milioni di barili al giorno nel 2017 rispetto i 3,4 del 2001, ma nel frattempo la produzione di gas naturale è salita a 120 miliardi di metri cubi all’anno)[27]. E con riserve stimate in 90 miliardi di barili l’economia norvegese e i 200mila lavoratori impiegati nel campo petrolifero possono guardare con relativa tranquillità il proprio[28].
L’industria petrolifera norvegese è tra le più efficienti del mondo e viene vista come modello per altre economie.
Ogni anno si concedono licenze per esplorazioni già in atto e ogni due anni vengono messe all’asta licenze per esplorazioni in nuovi giacimenti. Nel maggio 2016 sono state vendute dieci licenze a tredici compagnie. Alla fine del 2015 la Equinor possedeva 259 licenze, mentre altri cinquantatré operatori ne avevano 182[29].
L’obiettivo a medio-lungo termine del governo non è solo quello di evitare il più possibile l’utilizzo delle fonti fossili nell’ambito nazionale, ma anche di rendersi paese trainante verso un programma etico e ambientale che coinvolga tutto il globo che escluda, nel limite del possibile, lo sfruttamento di energie provenienti da combustibili a base di carbonio.
L’industria petrolifera norvegese ha iniziato a decollare nel 1971, quando la Phillips Petroleum Company cominciò a sfruttare il giacimento di Ekofisk, nel Mare del Nord. Da allora l’oro nero ha rappresentato il carburante che ha alimentato lo sviluppo economico e sociale della nazione la quale, sebbene già relativamente più ricca rispetto al resto dell’Europa, ha cominciato letteralmente a essere inondata di denaro.
L’esportazione dell’oro nero frutta ogni anno alle casse di Oslo 210 miliardi di nok, ma la ricchezza derivata dall’estrazione off-shore non è mai stata ostentata dai protagonisti norvegesi che, in questo senso, si distinguono nettamente dai concorrenti arabi e asiatici.
A differenza della pacchianeria e della ridondante esibizione di questi ultimi, le compagnie petrolifere norvegesi si sono sempre distinte per il loro basso profilo comunicativo e la loro propensione sociale. L’esempio più evidente è visibile nell’eleganza e la linearità dell’enorme sede della Equinor, l’ex Statoil[30], la più grande e facoltosa azienda petrolifera del paese con un fatturato di 61 miliardi di dollari. L’edificio, a basso impatto ambientale, sorge a Fornebu, alla periferia di Oslo ed è stato costruito ad un costo di 1,5 miliardi di nok tra il 2009 e il 2012 dallo studio di architettura A-lab, lo stesso che ha realizzato l’avveniristico Barcode che si affaccia sul fiordo di Oslo[31].

Il Fondo pensioni norvegese, potenza finanziaria alla ricerca dell’etica
L’edificio della Statoil è l’esempio con cui la Norvegia ha amministrato i ricavi derivati dall’esportazione del petrolio. Sin dagli anni iniziali dello sfruttamento dei pozzi, il ministero delle Finanze pubblicava il documento «Il ruolo dell’attività petrolifera nella società norvegese» in cui si avanzava la domanda su come dovessero essere utilizzati i proventi dell’estrazione petrolifera[32].
Nel 1990 è stato fondato il Fondo petrolifero e il 1° gennaio 1998 lo stesso ministero ha affidato alla Banca di Norvegia la gestione delle azioni con la clausola che non si dovesse utilizzare una quantità di denaro superiore ai proventi degli investimenti, stimato nel 3% del capitale di 900 miliardi di euro distribuito in 73 paesi e in 9.158 compagnie[33].
Vi sono delle guide etiche che escludono dagli investimenti da parte del Fondo le ditte responsabili di violazioni di diritti umani, produzione di alcuni tipi di armamenti, produzione di tabacco, di carbone, inquinamento[34].
Così sono bocciate ditte come la Philip Morris, la Posco, Rio Tinto, la Loockheed Martin Corp. (ma la Norvegia è partner nella produzione dell’F-35[35]). Nel solo 2018 sono state escluse dal fondo ditte come l’Aecom, la Bae System, la Fluor Corp., l’Huntington Ingalls Industries Inc. (impegnate nella produzione di armi nucleari), la polacca Atal SA, la cinese Luthai Textile (violazione diritti umani), la Evergreen Marine Corp. Taiwan, Korea Line Corp., Precious Shipping Pcl, Thoresen Thai Agencies (violazione diritti umani e inquinamento ambientale), l’Evergy Inc. la PacifiCorp, Tri-State Generation and Transmission Association, Washington H. Soul Pattinson & Co Ltd (produzione di carbone), l’Halcyon Agri Corp. (inquinamento ambientale), la JBS South Africa (corruzione)[36].
Nel 2017 la Banca di Norvegia ha invitato il ministero delle Finanze a rivedere gli investimenti del Fondo pensioni consigliando di escludere azioni derivate da collocamenti petroliferi. Il consiglio del gestore è stato recepito dallo Storting[37] il quale ha deciso di eliminare 134 compagnie che hanno interessi nell’industria di esplorazione e estrazione petrolifera per un totale di settanta miliardi di nok.
Le critiche, però non mancano, a partire dalle organizzazioni anti Nato, che contestano il coinvolgimento norvegese nel progetto F-35, a compagnie private che si occupano di fondi d’investimento, come la Storebrand Asa, la principale agenzia norvegese che amministra 70 miliardi di dollari affidati da 1,2 milioni di norvegesi.

Jan Erik Saugestad, vice presidente della Storebrand Asa, è critico verso il pacchetto di investimenti effettuati dal Fondo nazionale. Secondo lui il Fondo dovrebbe impegnarsi con più incisività a convincere le compagnie petrolifere a promuovere maggiormente le tecnologie per energie rinnovabili escludendo completamente quelle che hanno ancora attività nel settore dei combustibili fossili. Nel suo ultimo rapporto, la Storebrand Asa ha individuato una lista di società su cui ha deciso di non investire[38].
Per la verità la lista è molto simile a quella del Fondo governativo, dato che la stessa Storebrand non esclude a priori queste società, ma solo quelle che, nel loro portafoglio, hanno guadagni provenienti da attività considerate critiche per l’ambiente superiori a una certa percentuale (ad esempio esclude compagnie che hanno entrate superiori al 5% in tabacco, al 25% in attività collegate al carbone, 20% in attività collegate a sabbie bituminose)[39].
La Storebrand, inoltre, ha recentemente accusato alcune compagnie petrolifere di boicottare le politiche di energie rinnovabili investendo milioni di dollari per impedire o rallentare la successione delle energie alternative da quelle petrolifere. Tra le società accusate vi sono la Bp (53 milioni di Usd – dollari Usa – annui per boicottare queste politiche), la Shell (49 milioni Usd), Exxon Mobil (41 milioni Usd), Chevron (29 milioni Usd), Total (29 milioni Usd). I metodi utilizzati dalle imprese includerebbero pressioni su politici, amministrazioni locali e sull’opinione pubblica[40].
Il rapporto della Storebrand, però, contrasta nettamente con quello di altre agenzie. La Reuter ha recentemente pubblicato una ricerca da cui si evince che le compagnie petrolifere, con in testa la Shell, hanno investito circa tre miliardi di dollari in acquisizioni di energie rinnovabili negli ultimi cinque anni, mentre uno studio della WoodMackenzie, una società di ricerca e consulenza energetica, ha evidenziato che Total, Shell e Equinor sono tra le compagnie petrolifere che investono maggiormente in energie rinnovabili. La sola Equinor investirà in questo settore entro il 2020, il 25% del suo budget di ricerca[41]41.
È stata ancora la Equinor ad aver sviluppato l’Hywind Scotland Pilot Park, il primo centro di produzione eolica mobile off-shore che si trova a venticinque chilometri dalle coste scozzesi di Peterhead, nell’Aberndeenshire. L’Hywind è un complesso di sei turbine eoliche con una capacità energetica di 30 MW (megawatt). Secondo la Windeurope, la Equinor fornisce con i suoi impianti eolici il 7% dell’intera capacità energetica eolica prodotta in Europa nel 2018[42].

La Norvegia e l’ondata migratoria: l’affermazione dei partiti populisti
Con la scoperta del petrolio in Norvegia sono iniziati ad arrivare immigrati estranei alla cultura scandinava: erano pachistani, iugoslavi, maghrebini che non hanno fatto fatica a essere assorbiti nella nascente industria petrolifera. Al tempo stesso, però, la caduta del Muro di Berlino, le crisi politiche ed economiche dell’Europa dell’Est, accompagnate dagli sconvolgimenti militari ed etnici del Centro Asia, Vicino Oriente e Africa hanno messo la Norvegia di fronte a un’ondata migratoria che ha contribuito a sviluppare scetticismo nei confronti all’Unione europea e sospetto verso i nuovi arrivati.
All’inizio del 2018 su 5.400.000 abitanti 746.700 erano immigrati stranieri a cui vanno aggiunti 170mila nati da genitori stranieri[43]43. In totale gli immigrati sono il 17,3% della popolazione e contribuiscono per il 58% all’incremento demografico della nazione[44].
«Il petrolio è stata la fortuna e, al tempo stesso, la sfortuna della Norvegia», sentenzia Bente, una ragazza di Tromso la quale ritiene, come molti suoi connazionali, che il paese dovrebbe porre un freno all’immigrazione.
Questa percezione è stata cavalcata con successo dai partiti populisti di destra e antieuropeisti, in particolare dal Partito del progresso (FrP, Fremskrittspartiet)[45] che, nato nel 1973 come movimento liberista per l’alleggerimento della tassazione con il nome di Anders Lange’s Party for a Drastic Reduction in Taxes, Fees and Public Intervention («Partito di Anders Lange per una drastica riduzione delle tasse e dell’intervento pubblico»), nel 1989, sotto la guida di Carl Hagen si è trasformato in partito anti-immigrati. Dal 2013 l’FrP, oggi capeggiato da Siv Jensen[46], è entrato a far parte della coalizione di governo guidata da Erna Solberg, del Partito conservatore (chiamato «Høyre», destra).
Da allora l’FrP, che nelle ultime elezioni parlamentari del 2017 ha ottenuto un consenso del 15,2%, ha sempre guidato il ministero della Giustizia, pubblica sicurezza e immigrazione (Mgpsi) gestendo la politica migratoria della Norvegia. Tutti i sondaggi effettuati dagli anni Novanta che chiedevano quale partito avesse la migliore politica migratoria, hanno visto la netta prevalenza del Partito del progresso. Uno dei politici più popolari nel paese è Sylvi Listhaug, ministro dell’Immigrazione fino al 2018, la quale ha dato una svolta alla politica norvegese definendo «tirannia del buonismo» l’approccio europeo verso l’immigrazione e dichiarando che sarebbe stato più cristiano e ragionevole aiutare più gente possibile nei loro paesi attraverso programmi di aiuto.
Per la verità la stretta sulla migrazione non è prerogativa solo della destra: il primo passo in questo senso è stato fatto dal governo laburista di Gro Harlem Brundtland che con l’Immigration Act del 1988 ha gettato le basi per un maggiore controllo frontaliero, facili respingimenti e rimpatri forzati.
Dove nasce la strage di Utoya
 L’attentato di Anders Breivik del 22 luglio 2011, che colpì gli uffici del governo e poi portò alla strage di Utoya, non attenuò l’ondata di risentimento anti immigrati che, anzi, si andò rafforzando anche con l’aiuto di una classe intellettuale aggressiva e critica nei confronti della politica nazionale ed europea. Le idee di Peder Are «Fjordman» Nostvold Jensen che avevano nutrito la mente di Breivik sono oggi rappresentate da scrittori come Kent Andersen, che nel 2011 tacciò il Partito laburista di kulturquislinger («traditore della cultura norvegese») affermando che il governo aveva trasformato la Norvegia in una «Disneyland multiculturale»[47].
L’attentato di Anders Breivik del 22 luglio 2011, che colpì gli uffici del governo e poi portò alla strage di Utoya, non attenuò l’ondata di risentimento anti immigrati che, anzi, si andò rafforzando anche con l’aiuto di una classe intellettuale aggressiva e critica nei confronti della politica nazionale ed europea. Le idee di Peder Are «Fjordman» Nostvold Jensen che avevano nutrito la mente di Breivik sono oggi rappresentate da scrittori come Kent Andersen, che nel 2011 tacciò il Partito laburista di kulturquislinger («traditore della cultura norvegese») affermando che il governo aveva trasformato la Norvegia in una «Disneyland multiculturale»[47].
Tra i politici di destra si è fatto largo anche il concetto di Eurabia, mutuato dai libri di Bat Ye’Or (soprannome di Gisèle Littman) e di Bruce Bawer[48]. Secondo questa teoria l’Europa sarebbe al centro di una manovra islamico-progressista-comunista il cui fine ultimo sarebbe quello di trasformare il continente in una colonia islamica con l’aiuto della stessa Unione europea. Nel 2009 Per-Willy Amundsen, ministro della Giustizia tra il dicembre 2016 e il gennaio 2018, dichiarò che i musulmani sarebbero diventati la maggioranza in Norvegia entro un ventennio.
Nonostante la Norvegia non abbia aderito all’Unione europea, il paese ha comunque condiviso la Convenzione di Dublino generando critiche da parte di quella fetta di popolazione che vorrebbe un isolamento maggiore della propria nazione.

L’immigrazione: numeri e problemi
La Norvegia di oggi è dunque molto distante da quella che nel 1921 ha visto l’esploratore Fridtjof Nansen diventare il primo Alto Commissario per i rifugiati nella Lega delle Nazioni. Dall’inizio del nuovo secolo i governi che si sono succeduti alla guida del paese (qualunque fosse il loro orientamento) hanno adottato la politica della qualità piuttosto che della quantità accettando solo un determinato numero di migranti economici in base alle proprie esigenze e disponibilità di mercato del lavoro, scolastico e abitativo. Il parlamento ogni anno stabilisce un numero massimo di rifugiati che possono essere accolti nel paese, mentre il ministero della Giustizia, pubblica sicurezza e immigrazione (Mgpsi) identifica i paesi di provenienza e la tipologia di rifugiati escludendo a priori coloro che hanno comportamenti e attitudini indesiderate o problemi di tossicodipendenza.
Così nel 2018 il 28% delle domande d’asilo politico è stato respinto (in totale gli immigrati nello stesso periodo sono stati 49.800[49]) mentre 6mila persone senza permesso legale sono state espulse, di cui 5.400 costretti a rientrare a forza nei loro paesi d’origine (4mila per aver commesso un crimine[50]).
Una politica che rigetta l’idea che molti hanno di una Norvegia come paese aperto e accogliente verso chi cerca asilo. L’atteggiamento oggi prevalente è quello utilitaristico mischiato alla retorica dell’«aiutiamoli a casa loro». I migranti economici sono accuratamente scelti tra coloro che dimostrano di essere professionalmente preparati a svolgere determinati lavori perché, come ha detto nel giugno 2018 l’allora ministro dell’Immigrazione Tor Mikkel Wara: «L’immigrazione va a beneficio della comunità solo sino a certi livelli e certe composizioni. Lavoratori con competenze professionali, provenienti da società con valori moderni e liberali, con competenze che sono richieste dal nostro mercato del lavoro sono utili. Ma i benefici si tramutano in danni per i loro stessi paesi, se questi lavoratori professionalmente validi lasciano la loro terra, privando la loro stessa società di elementi validi»[51].
«La vita di famiglia perde ogni libertà e bellezza quando si fonda sul principio dell’io ti do e tu mi dai», scriveva il norvegese Henrik Ibsen[52].
Così la politica migratoria norvegese è dettata da due fattori: la consapevolezza che il welfare ha risorse limitate, ma al tempo stesso il diritto degli immigrati di godere degli stessi diritti e opportunità dei cittadini norvegesi. «Questo è il punto che ci distanzia da altri paesi dell’Europa», spiega Roger Jensen, teologo e direttore del Centro di pellegrinaggio del sentiero di Sant’Olav, a Oslo. «A differenza della Svezia e della Danimarca, che hanno ghettizzato gli immigrati, noi li abbiamo accolti e li abbiamo aiutati a inserirsi nella società diminuendo i fattori di rischio criminalità».
Un’affermazione, quella di Jensen, che non incontra l’appoggio di parte degli abitanti delle periferie cittadine.
In effetti, visitando alcuni quartieri di Oslo, sembra di sentire il già citato Luigi di Ruscio quando scriveva «Ovunque l’ultimo / per questa razza orribile di primi / ultimo nella sua terra a mille lire a giornata / ultimo in questa nuova terra / per la sua voce italiana / ultimo ad odiare / e l’odio di quest’uomo vi marca tutti / schiodato e crocifisso in ogni ora / dannato per un mondo di dannati»[53].
Nel sito document.no, uno dei tanti critici nei confronti dell’immigrazione e che raccoglie le idee degli intellettuali vicini al FrP, sono apparsi diversi articoli sulle baby gang. Un’area particolarmente critica è Drammen, un quartiere dormitorio alla periferia di Oslo dove opererebbero sette bande giovanili in cui «la maggior parte dei componenti è immigrata»[54].
È stato anche criticato il logo stilizzato di Oslo, dove, secondo il sito document.no, «non rimane molto né di St. Hallvard né del simbolismo cristiano (…) così i nostri nuovi connazionali (immigrati e musulmani, ndr) possono identificarsi con il nuovo simbolo. Nessuno si potrà offendere per un logo così anonimo»[55].

Per chi rimane: integrazione e diritti
Dalla fine degli anni Novanta si è introdotto l’obbligatorietà di partecipare a programmi di insegnamento della lingua e della conoscenza culturale, storica e sociale della Norvegia e nel dicembre 2018 il governo ha lanciato il programma Integration through education and competence il cui principale obiettivo è inserire gli immigrati nel mondo del lavoro e nella società attraverso l’istruzione pubblica, il lavoro, l’integrazione sociale e l’educazione civica.
Le nuove regole implementate dal governo impongono agli immigrati dei doveri tra cui la frequenza gratuita a 175 ore di scuola di lingua norvegese e a 50 ore di studi sociali, mentre ai rifugiati politici in possesso di un diploma scientifico e tecnologico dei corsi professionali che li indirizzino verso il mercato del lavoro. A tutti gli immigrati, dopo la schedatura e il test obbligatorio Tbc viene offerto un alloggio temporaneo (nel settembre 2018 c’erano circa 4mila residenti, nel 2016, 13.400). Una persona che aiuta uno straniero a entrare illegalmente in Norvegia rischia fino a tre anni di prigione, mentre chi sfrutta l’immigrazione per profitto rischia fino a sei anni. In cambio agli stranieri vengono garantiti gli stessi diritti dei norvegesi.
Ognuna delle 422 municipalità della Norvegia ha diritto di decidere il numero di rifugiati che ritiene di poter accogliere ogni anno. Nel 2018 meno di 250 municipalità hanno offerto la loro disponibilità (136 in meno rispetto al 2017). Il governo concede ai comuni una somma di denaro per ogni rifugiato accolto per 5 anni (nel 2018 era di circa 80.000 euro per ogni adulto e 75.000 per altri adulti famigliari[56]).
Dopo tre anni di soggiorno nel paese senza aver commesso crimini, dopo aver passato un test di lingua A1 (che richiede tra le 300 e le 600 ore di lezione a carico dell’utente) e uno di storia e legislazione norvegese, il candidato può ottenere la residenza permanente, mentre per la cittadinanza occorre risiedere ininterrottamente nel paese per sette anni senza aver commesso reati gravi e passare il test di lingua A2.
Le politiche di integrazione, da qualunque parte le si guardi, sembra comunque stiano funzionando: nonostante quello che molti esponenti della destra xenofoba vanno dicendo e scrivendo, il rispetto tributato dalla società norvegese verso culture provenienti dall’esterno è contraccambiato dall’amore per la nuova patria da parte degli immigrati. Lo dimostra anche un recente rapporto compilato da Statistics Norway in cui si evidenzia che il 76% dei figli di immigrati che sono nati in Norvegia parlano il norvegese oltre alla lingua dei genitori, ma la quasi totalità degli immigrati di seconda generazione sente come propria nazione e cultura più la Norvegia che il paese dei loro padri.
La lezione che la Norvegia può darci è quella di un paese che, in cambio del rispetto reciproco, è possibile che culture tanto diverse in ambito storico, politico, geografico, religioso possano convivere e progredire per lo sviluppo di una sola comunità dalle mille sfaccettature.
Piergiorgio Pescali

Note
[1] Il friluftsliv è l’abitudine dei norvegesi a spendere il proprio tempo libero all’aria aperta.
[2] Undp, Human Development Indices and Indicator, 2018 Statistical Update: Table 1, pag. 22 e Table 2, 1990-2017 pag. 26.
I versi di Bjornstjerne Bjornson sono tratti da Sidste Sang (L’ultima canzone): «Una volta ho sentito di una festa in Spagna: / Un cavallo brado venne lasciato libero nell’arena, / poi una tigre fuori dalla sua gabbia / si aggirò un po’ intorno di soppiatto, / poi si pose sulla pancia».
[4] Statistics Norway, Economic Survey 2019/1 – Economic Development in Norway, Main economic indicators 2007-2022, pag. 31.
[5] Luigi Di Ruscio (Fermo 1930 – Oslo 2011), La neve nera.
[6] Innovation Norway, Key Figures for Norwegian Tourism 2017, The importance of tourism for Norway, pag 6; pag 10; pag. 30.
[7] Nordli et al. (2014). Long-term temperature trends and variability on Spitsbergen: The extended Svalbard Airport temperature series, 1898-2012, Polar Research (http:// dx.doi.org/10.3402/polar.v33.21349).
[8] Norwegian Polar Institute, SvalGlac: Sensitivity of Svalbard glaciers to climate change, 2010-2016.
[9] Statistics Norway, citato. Vedi anche:
https://www.pre-sustainability.com/news/updated-carbon-footprint-calculation-factors.
[10] Norwegian Ministry of Climate and Environment, Norway’s Climate Strategy for 2030: a transformational approach within a European cooperation framework (2016-2017), 16 giugno 2017, pag. 104.
[11] In Norvegia gli alberi sono suddivisi in cinque categorie dalla I alla V. Solo quando le piante raggiungono la V categoria l’assorbimento di gas serra diminuisce repentinamente e sarebbe quindi necessaria la sostituzione.
[12] Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Nibio (2013) Planting av skog på nye arealer som klimatiltak [Afforestation of new areas as a climate mitigation measure], M26-2013.
[13] International Energy Agency, Energy Policies of IEA Countries, Norway 2017 Review, 2017, Capitolo 8. Renewable Energy, §Supply and Demand – Renewable energy in the TPES, pag. 126.
[14] International Energy Agency, Energy Policies of IEA Countries, Norway 2017 Review, 2017, 1. General Energy Policy, §Key data (2015 estimates) pag. 15.
[15] European Commission, Directorate General for Energy, Quarterly Report on European Electricity Markets, DG Energy, Vol 11, issue 1, first quarter of 2018, Capitolo 2, pag.7.
[16] International Energy Agency, Key world energy statistics 2018, Selected indicators for 2016, pp. 29-33.
[17] Oggi la Kewet e la sua successiva evoluzione, la Buddy, sono scomparse dal mercato. Avevano un’autonomia massima di 150 km, erano piccole, ospitavano al massimo tre adulti, non avevano bagagliaio e somigliavano ad un Sulky, una minicar squadrata degli anni Ottanta.
[18] Ev, «Electric vehicle», veicolo completamente elettrico che si differenza dal Phev, «Plug-in Hybrid Electric Vehicle», veicoli elettrici ibridi.
[19] https://ofv.no/bilsalget/bilsalget-i-2018
[20] International Energy Agency, Energy Policies of IEA Countries, Norway 2017 Review, 2017, citata, pp. 52-53.
L’ibrido (Phev) rappresenta il 40% delle auto elettriche vendute nel 2018, nel 2016 era il 35%.
[21] https://info.nobil.no/eng
[22] La direttiva europea consiglia una colonnina di ricarica ogni 10 Ev; in Norvegia la proporzione è di 0,65 colonnine/Ev.
[23] https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Norway
[24] https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Norway
[25] https://www.gassnova.no/en/the-government-has-granted-permission-for-co2-storage-in-the-north-sea
[26] http://www.tcmda.com/en/About-TCM/Owners/
[27] International Energy Agency, Energy Policies of IEA Countries, Norway 2017 Review, 2017, pag. 9
[28] Il Mar del Nord ha il 51% delle riserve petrolifere, il Mar di Norvegia il 23% e il Mar di Barents il 26%. Dal 2009 l’estrazione di petrolio del Mare del Nord è diminuita del 7%, mentre nel Mare di Barents è aumentata del 7%. La Norvegia aveva nel 2016 80 campi di produzione petrolifera off-shore: 62 nel Mare del Nord, 16 nel Mare di Norvegia e 2 nel Mare di Barents.
[29] International Energy Agency, Energy Policies of IEA Countries, Norway 2017 Review, 2017, pag. 66.
[30] Statoil è diventata Equinor il 15 maggio 2018 con la fusione della Statoil con la Norsk Hydro. Il principale azionista è il governo norvegese (67,0%).
[31] A-lab, Statoil Regional and International Offices, §Fakta.
[32] Hillmar Rommetvedt, The Rise of the Norwegian Parliament, Ed. Frank Cass and Company Limited, Londra, 2003, pp. 189-190.
[33] https://www.nbim.no/en/
[34] Guidelines for observation and exclusion of companies from the Government Pension Fund Global.
[35] https://www.f35.com/global/participation/norway
[36] Norge Bank Investment Management, Responsible Investment Government Pension Fund Global, 2018 – Divestments, §Ethical exclusions, p. 113.
[37] Il parlamento norvegese.
[38] Storebrand, Sustainable investments in Storebrand Q4 2018, Companies that Storebrand does not invest in.
[39] https://www.storebrand.no/en/sustainability/exclusions
[40] Niall McCarthy, Oil And Gas Giants Spend Millions Lobbying To Block Climate Change Policies [Infographic], Forbes, 25/03/2019
[41] https://www.reuters.com/article/us-shell-m-a/shell-buying-spree-cranks-up-race-for-clean-energy-idUSKBN1FF1A8; vedi anche:
• https://www.theguardian.com/business/2017/nov/28/ shell-doubles-green-spending-vo ws-halve-carbon-footprint
• https://energypost.eu/how-attractive-are-renewables-for-oil-companies/
[42] Windeurope, Offshore Wind in Europe-Key and trend statistics 2018, Capitolo 3 – Industry Activity and Supply Chain, §3.2 Wind Farm Owner, febbraio 2019.
[43] worldpopulationreview.com/countries/norway-population/
[44] Espen Thorud, membro OECD, Expert Group on Migration on Norway, Immigration and Integration 2017-2018, 2018, pag. 38 e pag. 6. – Al 31 dicembre 2017, in Italia la popolazione straniera residente era di 5.144.440 su un totale di 60.483.973 abitanti pari all’8,50% (fonte Istat).
[45] Il FrP rifiuta l’etichetta di partito populista.
[46] Siv Jensen è anche ministro delle Finanze nell’attuale governo Solberg
[47] http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Drom-fra-Disneyland-6270375.html
[48] Ye’or Bat, Eurabia. Come l’Europa è diventata anticristiana, antioccidentale, antiamericana, antisemita, Lindau, Torino 2007. Vedi anche: Bruce Bawer, While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within, Random House, 2006.
[49] Espen Thorud, citato, pag. 10.
[50] Espen Thorud, citato, pag. 7.
[51] EMN Norway Conference, Challenges – introduction by Tor Mikkel Wara, Oslo, 21 giugno 2018.
[52] Henrik Ibsen, Casa di bambola.
[53] Luigi di Ruscio, Ovunque l’ultimo.
[54] https://www.document.no/2019/03/30/gjenger-gjor-drammen-til-et-helvete-pa-jord/
[55] https://www.document.no/2019/03/31/ny-logo-for-oslo-kommune/
[56] Espen Thorud, citato, pag. 32.