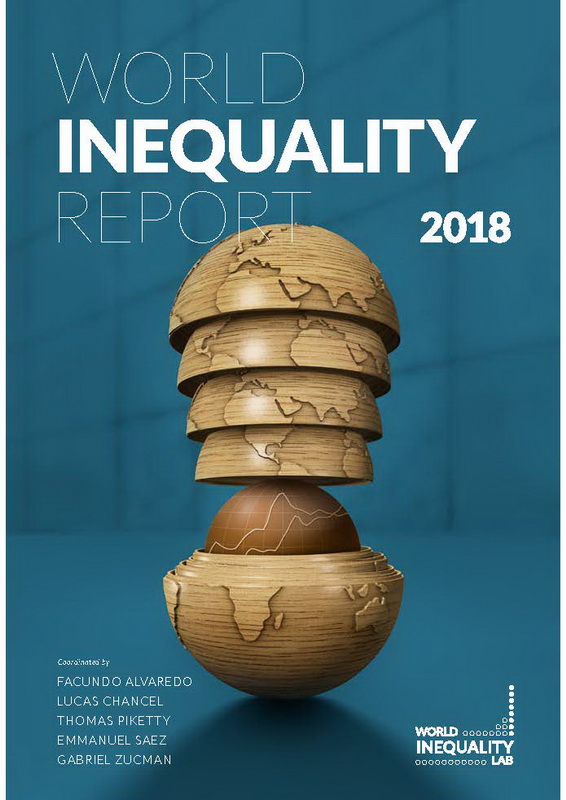Kinshasa è un paese nel paese. Vi si trovano grandi bidonville e città super lusso. Case di latta e grattacieli. Aumenta al ritmo 390mila abitanti all’anno. Mentre mancano i servizi di base, come l’acqua potabile e le fogne. Viaggio nei quartieri simbolo della capitale congolese.
Kinshasa. Da oltre 25 anni, Christian si prende cura sia dei vivi che dei morti. Ai primi taglia i capelli, ai secondi scava la fossa. La sua sede di lavoro è sempre la stessa: il cimitero di Kinsuka, all’estrema periferia occidentale di Kinshasa, la capitale della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Kinsuka in lingala, la principale lingua del paese, significa letteralmente «la fine di Kinshasa»: un nome apparentemente calzante per un quartiere noto per il suo cimitero.
Le donne stendono i panni tra i rami degli alberi del cimitero, o trascinano i secchi colmi d’acqua raccolta dai pozzi. Dicono che quell’acqua abbia un sapore stranamente acido. Eppure a ispirare ansia non è né il rischio di contaminazione della falda acquifera né lo spirito dei morti. Ben più oscura e minacciosa è la burocrazia congolese. Soprattutto in uno spazio conteso come il cimitero di Kinsuka.
Baracche di lamiera spuntano accanto alle tombe. Alcune sono fantasmi di case in muratura che esistevano a poca distanza. I proprietari conservano gelosamente gli atti di proprietà, per i quali hanno pagato i funzionari locali. Il likasu è un piccolo frutto dal sapore dolciastro, ma anche il nome usato in Congo per il denaro fatto scivolare furtivamente nelle mani di ufficiali e amministratori per aprire porte o ottenere permessi.
È così che centinaia di famiglie hanno avuto l’autorizzazione per costruire nel cimitero. Ma con nuovi arrivi ogni giorno, il valore dello spazio del cimitero continua a salire e i likasu non sono mai abbastanza. Delle case vengono demolite, altre vengono erette, mentre nuove tombe si aggiungono alle precedenti.
Il cimitero di Kinsuka è lo specchio di una città in cui la crescita vertiginosa di popolazione travolge anche i muri tra i vivi e i morti.
Inurbamento selvaggio
I nuovi kinois, come sono chiamati gli abitanti di Kinshasa, arrivano dalle province orientali lacerate da una miriade di guerriglie, dalle province centrali, dove le miniere traboccanti di diamanti sono ormai solo un ricordo, dal Nord, dove il recente conflitto nella Repubblica Centrafricana ha costretto alla fuga i profughi di guerre precedenti. Dal Kivu, dal Kasai, dall’Equateur: in migliaia, ogni settimana, discendono la corrente del fiume Congo viaggiando per giorni su barconi che assomigliano a villaggi galleggianti, finché il corso d’acqua si allarga in un’ansa e, sulla riva meridionale, appaiono, velati da un sipario di vapore acqueo, gli svettanti edifici di Gombe, il distretto degli affari che nell’era coloniale era interdetto ai nativi.
Secondo le stime di Un-Habitat, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di sviluppo urbano sostenibile, 390mila persone, ogni anno, si riversano a Kinshasa, per sfuggire alla guerra o alla povertà, ma anche per studiare o inseguire una speranza.
È come se, ogni anno, la capitale congolese fagocitasse una città di medie dimensioni, digerendola nel suo tessuto urbano che pulsa al momento di oltre 12 milioni di anime.
Nell’annuale rapporto The State of African Cities, Kinshasa è entrata proprio quest’anno nella tea delle megacittà africane, dopo il Cairo (Egitto) e Lagos (Nigeria), al di sopra della media di un continente che pure rappresenta la regione al mondo col maggior tasso di urbanizzazione. Secondo le previsioni, entro il 2035 la metà della popolazione africana vivrà in aree urbane. Eppure, ancora oggi, nelle città africane due abitanti su tre vivono in baraccopoli. Una situazione a cui l’agenda d’azione redatta nella conferenza di Addis Abeba per i finanziamenti allo sviluppo del 2015 dedica ampio spazio: un boom demografico troppo rapido può avere effetti devastanti su spazi urbani particolarmente fragili, soprattutto sulle infrastrutture idriche e i servizi di gestione dei rifiuti, aumentando il rischio di epidemie.
Nel 2012, WaterAid, una Ong britannica che si occupa di progetti sull’acqua, ha avviato un programma per studiare soluzioni sostenibili per le infrastrutture idriche di Maputo, in Mozambico, Lusaka, in Zambia, Lagos, in Nigeria, e, per l’appunto, Kinshasa. Secondo John Garrett, analista di WaterAid che si occupa dell’iniziativa, il caso di Kinshasa è particolarmente drammatico. «La città manca di una rete fognaria pubblica e solo i quartieri benestanti dispongono di fosse settiche», dice. «In alcune zone esistono latrine comuni di cui si occupa la Ratpk, la società pubblica che gestisce la distribuzione idrica, alcune Ong e operatori privati. Ma la massa di rifiuti organici prodotti quotidianamente è talmente elevata che la maggior parte viene dispersa nell’ambiente».
Un grande immondezzaio
Un tempo la chiamavano Kin la Belle; oggi, per i kinois, è Kin la Poubelle, ovvero l’immondizia in francese, per l’enorme quantità di rifiuti prodotti e l’incapacità del governo di gestirli.
L’Unione europea, l’agenzia statunitense per la cooperazione Usaid e alcune altre, soprattutto francese e giapponese, hanno avviato dei programmi d’intervento sulle infrastrutture urbane. Ma per la maggior parte delle organizzazioni inteazionali Kinshasa è solo una base d’appoggio per le operazioni nell’Est del paese, dove la guerra civile continua ad uccidere.
I maggiori partner economici della Repubblica democratica del Congo, la Cina su tutti, hanno rimesso in sesto le principali strade della capitale in cambio di concessioni minerarie, ma rimangono ampie zone d’ombra anche a pochi chilometri dal palazzo in cui il presidente Joseph Kabila governa dal 2001, e dal quale sembra di non volersene andare (vedi Box).
Assenti all’interno delle baraccopoli, le forze di sicurezza ne controllano però l’accesso. «Gli stranieri potrebbero dare un’immagine negativa del paese», ci dice un funzionario di polizia, riferendosi a Pakadjuma, un insediamento illegale che si snoda lungo la ferrovia che unisce Kinshasa a Matadi, il maggiore porto fluviale del sud del Congo, a ridosso del bacino in cui vengono riversati gli scarichi delle fosse settiche della città.
Il torrente Kaluma taglia la baraccopoli, attraversa il bacino e prosegue oltre per affluire nel fiume Congo. Pur essendo un agglomerato di baracche, Pakadjuma è una delle aree di Kinshasa abitate ininterrottamente da più tempo.
La posizione strategica lungo la ferrovia e a poca distanza dalle rive del fiume ne ha fatto fin dall’inizio del ventesimo secolo uno snodo cruciale per i sudditi del Congo belga prima, e quindi per i cittadini dello Zaire e della Rdc che confluivano nella capitale per lavorare e commerciare, anche nel mercato del sesso. Fattori scatenanti, secondo uno studio delle università di Oxford e di Lovanio, della «tempesta perfetta» da cui probabilmente prese il via negli anni ‘20 l’epidema globale di Hiv esplosa poi negli anni ‘80.
Quando si riesce ad accedere al quartiere, ci si rende conto che la situazione non è molto diversa da quella di un secolo fa. Pakadjuma resta il distretto della prostituzione a basso costo, praticata nei cosiddetti kuzu, postriboli dove ci si prostituisce anche per mezzo dollaro o in cambio del pesce che i pescatori del quartiere non riescono a vendere al mercato.
Come racconta Nicolas Muembe, l’infermiere che gestisce l’unico presidio sanitario della baraccopoli, un terzo degli utenti dell’ambulatorio è sieropositivo. La maggior parte dei suoi pazienti sono donne. Il virus si propaga rapidamente in corpi già debilitati. «Molti dei sieropositivi che abbiamo in cura hanno già avuto il colera in passato e sono esposti a dissenteria cronica e a nuove infezioni che si diffondono a causa delle condizioni igieniche precarie».
Ci sono solo due latrine in muratura per una popolazione di diverse migliaia di abitanti. Le fogne sono un reticolato di rivoli d’acqua nera che strabordano nella stagione delle piogge, facilitando la diffusione di diarrea e vermi intestinali. Sui pochi letti dell’ambulatorio creato da Nicolas con l’aiuto dei Caschi Blu tunisini del contingente internazionale Monusco (Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Congo, nrd) si alternano partorienti e malati gravi. Il materiale sanitario è fornito da una Ong statunitense. Solo dopo l’epidemia di colera che nel 2013 ha fatto centinaia di vittime, il ministero della Salute congolese ha stabilito un altro presidio sanitario nella zona. Al momento, però, la struttura è dedicata alle decine di migliaia di nuovi arrivati nell’ultimo anno dal vicino Congo Brazzaville: anche loro congolesi, ma rifugiati di un conflitto mai finito.
I veterani di Pakadjuma arrivarono a Kinshasa dalla provincia settentrionale di Equateur lungo il fiume ai tempi dell’ex dittatore Mobuto Sese Seko, salito al potere con un colpo di stato nel 1965 e deposto solo nel 1997 da Laurent-Désiré Kabila, padre dell’attuale presidente. I nuovi arrivano perché l’Equateur continua a essere una delle province più emarginate del paese. Molti abitanti di Pakadjuma sono Ngbandi, il gruppo etnico maggioritario nel Nord della Rdc, da dove proveniva Mobuto, e leggono la mancanza di infrastrutture attraverso una lente politica: l’abbandono da parte dello stato sarebbe una punizione verso i sostenitori del regime precedente, dicono in tanti.
Un’enorme disuguaglianza
Non esistono dati certi sulla popolazione delle baraccopoli, gli unici spazi in cui i nuovi arrivati possono permettersi un tetto in una megalopoli che, secondo Mercer, un’agenzia di consulting, è la 13ª città più cara del mondo, subito dopo Londra. È un paradosso nel paradosso, quello di un paese in cui lo stato, come ha detto recentemente l’esperto di Congo Pierre Englebert, è troppo debole per fornire servizi ai propri cittadini ma abbastanza forte per tenerli soggiogati. L’élite congolese e i dipendenti stranieri di multinazionali godono di servizi di standard internazionale in quartieri fortificati che si stanno moltiplicando qui come in altre aree urbane in Africa e America Latina, prefigurando un futuro di disuguaglianze crescenti.
A Kinshasa, questa distopia sta prendendo forma sulle rive del fiume che ha plasmato la storia del paese. Cité du Fleuve, quartiere di lusso, è la vetrina della Kinshasa di domani, un’area residenziale tuttora in fase di completamento su una penisola affacciata sul Congo. Dietro il progetto c’è la Hawkwood Properties, una società d’investimenti con sede a Lusaka, in Zambia, che ha dato forma ai sogni di un’alta borghesia che si ritrova alla «settimana della moda di Kinshasa» o nei ristoranti di lusso di Gombe. Condomini e case unifamiliari dagli stili più diversi si affacciano su ampi viali con lampioni. Un Hummer limousine bianco è parcheggiato in uno dei viali principali. Affittarlo per un’ora costa 350 dollari e un meccanico che ne sta revisionando il motore ci informa che le prenotazioni sono complete per i mesi a venire. Molte abitazioni sono ancora vuote, ma le previsioni sono rosee, e presto apriranno anche negozi e supermercati. L’idea alla base di Citè du Fleuve è fae una comunità autonoma dal resto di Kinshasa, un frammento di Europa sul fiume Congo, lontano dalle immagini stereotipate di miseria e malattie del paese.
Eppure queste immagini incombono a poche centinaia di metri, al di là della ringhiera di protezione e di un ramo del fiume su cui le piroghe scivolano lentamente. Migliaia di pescatori risiedono in un agglomerato di baracche concentrate in un fazzoletto di terra sul livello dell’acqua, esposto alle periodiche esondazioni. Non possono allontanarsi perché dalla pesca ricavano l’unica forma di sostentamento ma, dicono, dall’inizio della costruzione di Cité du Fleuve, nel 2008, la loro situazione è peggiorata: «I sistemi di sbarramento per proteggere il quartiere residenziale impediscono il riflusso del fiume», dice Vincent, un leader comunitario del villaggio dei pescatori. «L’acqua ristagna. E così il colera ritorna regolarmente».
Il sito web di Cité du Fleuve specifica che la costruzione del quartiere è stata preceduta da un accurato studio idrogeologico, ma la nostra richiesta alla società finanziatrice di un commento alle accuse dei pescatori non ha ricevuto risposta. Intanto, gli abitanti del villaggio si proteggono dalle esondazioni del fiume come possono, costruendo su palafitte o creando degli argini. Non abbastanza, secondo Florence, una madre di quattro figli che ha sistemato sacchi di sabbia attorno alla propria abitazione, per impedire che l’acqua entri in casa, trasportando con sé feci e rifiuti organici. Lei è uno dei pochi abitanti ad avere costruito una latrina, e spera che altri seguano il suo esempio. La latrina sorge proprio sulla sponda del fiume, sul lato opposto di Cité du Fleuve, la Kinshasa del futuro.
Ma, a Kinshasa, il futuro, come i servizi igienici, è un lusso che non tutti possono permettersi.
Gianluca Iazzolino
Questo reportage è parte del progetto «Toilet for all» realizzato con il contributo dell’Innovation in Development Reporting Grant programme dello European Joualism Centre. La prima parte «India. A mani nude», è stato pubblicato su MC marzo 2016.
Il presidente Kabila tenta di mantenersi al potere
Per seguire le orme di Mobutu
Si preannuncia un autunno caldo per la Repubblica democratica del Congo. Il secondo, e ultimo, secondo la Costituzione congolese, mandato del presidente Joseph Kabila termina quest’anno, ma la situazione politica in atto sembra ricalcare tristemente un copione comune a tanti stati africani: il tentativo del presidente in carica di estendere il proprio mandato, cambiando la Costituzione o rinviando le elezioni a data da destinarsi. Joseph Kabila ha preso in mano le redini del Congo nel 2001, subito dopo l’assassinio del padre, Laurent-Désiré, il leader guerrigliero d’ispirazione marxista (negli anni Sessanta ricevette anche l’aiuto di Che Guevara, che però, nei sui scritti, ne lascia un ricordo poco lusinghiero1) che, nel 1997, mise fine al governo trentennale di Mobutu Sese Seko per poi replicarne gli aspetti più autoritari, incluso il culto della personalità. Secondo le teorie più accreditate, dietro l’assassinio di Kabila padre, organizzato da uomini d’affari libanesi e portato a termine da una delle sue guardie del corpo, ci sarebbe stato il Rwanda, piccola ma aggressiva potenza regionale e precedente sponsor della scalata al potere dello stesso Désiré Kabila.
Il figlio ereditò un paese impelagato in una guerra sanguinosa, la cosiddetta «seconda guerra del Congo», o anche «guerra mondiale africana», che almeno nove stati e diverse decine di gruppi guerriglieri contribuirono a rendere il conflitto il più sanguinoso dalla fine della Seconda guerra mondiale, facendo oltre cinque milioni di morti. A capo del governo di transizione Joseph negoziò la ritirata, perlomeno ufficiale, delle truppe ruandesi di Paul Kagame dalle regioni dell’Est e fece incetta di voti alle elezioni del 2006, la prima consultazione elettorale nel paese in 41 anni. Replicò il successo nel 2011, nonostante le numerose accuse di brogli da parte sia di oppositori interni che di osservatori inteazionali, e puntellò il suo governo comprando la fedeltà delle élite locali grazie al boom delle esportazioni di materie prime. Ma la fame di minerali della Cina ha rimpinguato i conti personali, più che le casse dello stato, e i risultati sono evidenti a Kinshasa.
Alleato chiave di Joseph Kabila, in questo periodo di crescita tumultuosa, è stato Moïse Katumbi Chapwe, uomo d’affari nel settore minerario e soprattutto a lungo governatore del Katanga, la regione più ricca del paese grazie alle abbondanti riserve di rame e uranio. Figlio di un ebreo greco e di una congolese, e proprietario del TP Mazembe, la principale squadra di calcio congolese e una delle più premiate d’Africa, questo politico e imprenditore ha abilmente usato i proventi delle concessioni minerarie per dotare il Katanga di infrastrutture inesistenti nel resto del Congo, e così costruire il proprio consenso tra la popolazione e conquistarsi le simpatie delle compagnie straniere nella zona.
Il rallentamento della domanda cinese e la flessione nel prezzo delle materie prime, però, ha coinciso con la fine dell’alleanza tra Kabila e Katumbi. Il primo ha fatto capire sempre più chiaramente di non avere alcuna intenzione di lasciare il suo posto, tagliando i fondi alla commissione elettorale, e così rendendo inevitabile che la Corte suprema giudicasse irrealistica la prospettiva di andare alle ue a novembre 2016, come precedentemente stabilito, e inasprendo la repressione dell’opposizione. Il secondo è ufficialmente entrato nell’agone politico nazionale a marzo, assurgendo immediatamente a leader incontrastato dell’opposizione e perciò finendo nel mirino del presidente. La risposta di Kabila non si è fatta attendere: a maggio, Katumbi è stato accusato di aver assunto dei mercenari per organizzare un colpo di stato. Pochi giorni dopo, Katumbi è stato ricoverato in un ospedale di Lumunbashi, la capitale del Katanga, e da lì è fuggito in Sudafrica. L’ultimo colpo di scena in una saga che si annuncia lunga e complessa.
Gianluca Iazzolino
- 1. «L’anno in cui non siamo stati da nessuna parte. Il diario di Eesto “Che” Guevara in Africa», P. I. Taibo II, F. Escobar, F. Guerra, Il ponte delle Grazie, 1994.