Colombia-Perù. La forma della felicità
Testo e foto di Paolo Moiola |
Non ci sono né acquedotto né acqua potabile. Non ci sono fognature e strade. L’elettricità arriva per quattro ore al giorno. La malaria è la norma. Eppure, a Soplín Vargas, piccolo villaggio di 700 persone (tra indigeni e meticci) sulla riva peruviana del rio Putumayo, si può essere felici. È il sumak kawsay, la forma indigena della felicità. Confermata dai missionari.
Verso Soplín Vargas. Ci imbarchiamo al porticciolo di Puerto Leguízamo. Qui non esiste un servizio di trasporto pubblico. I passaggi sul rio Putumayo dipendono dall’intraprendenza dei singoli. Come fa la signora Teresa, una donna imprenditrice che ha coinvolto nell’attività anche i propri figli. Due volte a settimana la sua vecchia lancia in legno percorre il tragitto tra Puerto Leguízamo e Soplín Vargas, in terra peruviana. Ci accomodiamo tra sacchi di cemento marca San Marcos, scatole e borse della spesa. È stato imbarcato pure un mobile di medie dimensioni. I passeggeri – uomini e donne con bambini – sono tutti peruviani che vengono a fare acquisti sul lato colombiano del fiume, dove i prodotti si trovano più facilmente e più a buon mercato. «Teresa, come va il business?», chiedo mentre lei è ancora sul molo in attesa di altre persone. «Più o meno», risponde lei con una risata. Non esistono orari. L’unica regola è evitare di muoversi con il buio. Raggiunti i 14 passeggeri, Teresa molla la cima e Angelo, uno dei suoi figli, accende il motore. «Ci vorranno poco più di due ore», spiega padre Fernando Flórez, che a Soplín Vargas ha la sua missione.
A pochi minuti dalla partenza passiamo davanti alla base della «Forza navale del Sud» dell’Armada colombiana, che qui ha una presenza di rilievo vista la zona di confine (con Perú ed Ecuador) e la situazione di conflitto armato con le Farc che vigeva fino agli accordi di pace del novembre 2016.
La navigazione procede tranquilla. L’acqua del fiume ha un colore opaco, tra il verde e il marrone, come si notava dall’aereo. Sulle rive la vegetazione è continua ma quasi non ci sono alberi ad alto fusto. Ogni tanto, seminascosta dalla boscaglia, s’intravvede qualche abitazione su palafitte. Le rare imbarcazioni che s’incontrano sono soprattutto peke-peke (il nome deriva dal tipico rumore del motore) appartenenti a pescatori o a famiglie che si spostano lungo il fiume.
![]()
Dopo un paio di ore di viaggio, sulla riva peruviana compare un grande cartellone della Marina da guerra del Perú – sul Putumayo ha alcune guarnigioni stabili (come la controparte colombiana) – che annuncia l’arrivo a Soplín Vargas. «Sia Puerto Leguizamo che Soplín Vargas debbono i loro nomi a soldati caduti durante la guerra tra Colombia e Perú che ebbe luogo tra il 1932 e il 1933», mi spiega padre Fernando.
La lancia di Teresa riduce la velocità e si dirige verso un piccolo molo sul quale sono indaffarate parecchie persone. Man mano che ci avviciniamo capisco il motivo di tanto trambusto. Qualcuno sta squartando una vacca e vari dei presenti se ne portano via un pezzo, chi più grande, chi più piccolo. La maggior parte di loro se lo carica sulle spalle per fare più comodamente la ripida scalinata in legno che dal fiume conduce al promontorio dove sta Soplín Vargas. Per questa sua posizione il villaggio è considerato in «altura», che significa non inondabile dal Putumayo.
Noi scendiamo poco più avanti in un posto più scomodo e sconnesso. Gli stivali sono indispensabili per muoversi su un terreno reso fangoso e viscido dalle piogge.
Dopo una camminata in leggera salita su sentieri in terra battuta, arriviamo alla missione. Ad accoglierci è il volto sornione di padre Moonjoung Kim, missionario della Consolata coreano che con padre Fernando opera a Soplín Vargas.
La missione è una piccola casa in muratura posta su un unico piano.
L’entrata dà su un salone dove si svolgono tutte le attività (incontri, messe, feste, celebrazioni). Al fondo dello stesso ci sono quattro porte corrispondenti alle stanze da letto dei due padri, al cucinino e al piccolo bagno.
![]()
«Sumak kawsay»
Padre Fernando e padre Kim operano su tutto il distretto denominato Teniente Manuel Clavero, che si estende su un territorio amazzonico molto vasto (circa 9.107 km2). C’è Soplín Vargas, il capoluogo con circa 700 abitanti e una comunità mista di meticci e indigeni. Ci sono due altre comunità meticce e poi 28 comunità indigene: Kichwa soprattutto (21), ma anche Secoya (6) e Huitoto (1). La più piccola, Peneyta, conta soltanto 36 abitanti.
Vista l’ampiezza del territorio, i due missionari sono sempre in viaggio, muovendosi in barca e a piedi. Però, a dispetto di fatica e difficoltà, sembrano in totale armonia con l’ambiente naturale, umano e culturale in cui sono immersi. «La chiesa cattolica – spiega padre Fernando – dovrebbe evangelizzare e il vangelo – anche dal punto di vista etimologico – significa “buona notizia”. In questo pezzetto di Amazzonia noi dovremmo portare buone notizie. Ciò si traduce nel sumak kawsay, tradotto come buen vivir. Tutto ciò che sta a favore della vita è Vangelo, tutto ciò che sta contro la vita va denunciato. Anche per questo io e padre Kim stiamo percorrendo il Putumayo in lungo e in largo: per formare líderes e líderesas che possano essere gestori del buen vivir».
Il sumak kawsay-buen vivir è un concetto affascinante: vivere privilegiando la comunità in un contesto di rispetto dell’ambiente naturale. Affascinante ma difficile, soprattutto per un bianco che, per capirlo ed eventualmente attuarlo, deve spogliarsi di molti preconcetti, di strutture mentali sedimentate, di comodità date per acquisite. Ad esempio, vivere nella foresta amazzonica è un’esistenza unica in ogni aspetto della quotidianità.
«Di acqua ne abbiamo molta – racconta padre Fernando -. Il problema è che spesso non è potabile. È un paradosso, lo so. Siamo sulle sponde del fiume Putumayo, ma il fiume è inquinato. In primis, dall’immondizia: tutto ciò che le comunità producono come immondizia, viene buttato nel fiume. Va detto che l’indigeno è passato in poco tempo da uno scarto naturale (gusci, cortecce, legno) alla plastica. Con la differenza che il primo non inquina, il secondo sì. A Soplín Vargas parte dell’immondizia si raccoglie, ma si butta in un terreno senza alcun trattamento. Non esiste il concetto di riciclaggio. E poi ci sono i reflui umani che anch’essi vanno a finire nel fiume. Qui in pochissimi hanno un gabinetto con una fossa biologica».
![]()
Dunque, come ci si procura l’acqua?, chiedo da straniero abituato alle comodità dei bianchi. «Normalmente la gente raccoglie l’acqua piovana in un contenitore, ma altrettanta prende l’acqua da bere direttamente dal fiume. Noi portiamo l’acqua (trattata) in bottiglioni dalla Colombia e, quando la gente sulla barca ci vede, ride di noi. “Fernando, l’acqua del Putumayo non si prosciuga, perché vai a comprarla?”».
Domando della vita quotidiana. «Se non lavorano nella municipalità – spiega padre Fernando -, le persone al mattino vanno a collocare le loro reti nel rio Putumayo per pescare. Durante la notte possono andare a caccia per procurarsi la carne, che poi salano dato che qui non c’è possibilità di congelare i prodotti». Dunque, pesca, caccia, ma anche un’agricoltura di tipo familiare.
«Nelle chagras (o chacras, piccoli appezzamenti di terra) si coltivano – spiega padre Kim – riso, frutta amazzonica e yuca. Quest’ultima è molto usata dagli indigeni, anche per produrre bevande tipiche come la chicha e il masato». Chiedo della coca. «E tristemente si coltiva anche coca – conferma il missionario -. Però, la si coltiverebbe meno, se in altre parti del mondo non si consumasse. Senza dimenticare che gli indigeni la utilizzano anche in alcuni loro rituali tradizionali».
Dopo la cena, nel salone multiuso rimontiamo la tenda sotto la quale dormirò. Occorre approfittare della luce: a Soplín Vargas la corrente elettrica viene erogata per 4 ore giornaliere, dalle 18,00 alle 22,00. La missione non ha un generatore autonomo. Non c’è televisione né collegamento internet. «Però – dicono quasi all’unisono i due missionari – abbiamo vegetazione, tranquillità, persone con le quali si può parlare faccia a faccia senza un telefono che suoni».
![]()
Amazzonia, cuore del mondo
Ogni mattino mi alzo anchilosato, ma senza punture. Anche la scorsa notte le zanzare (zancudos o mosquitos) non sono passate dalla mia tenda. Esco subito per approfittare della temperatura sopportabile. Percorro il sentiero – sono poche centinaia di metri – che porta verso il centro del villaggio. Passo davanti alla scuola primaria e secondaria e a un piccolo campo da gioco in cemento. Ancora pochi passi e sono sulla Plaza de Armas di Soplín Vargas. È uno spazio erboso circondato da una stradina pavimentata con lastroni di cemento. Tutt’attorno ci sono il posto di polizia (una baracca in legno di colore verde pallido), il municipio e anche un ufficio del Banco de la Nación.
Incrocio il direttore del collegio. La scuola di Soplín Vargas – chiamata Teniente Luis García Ruiz – conta 108 alunni in primaria e 78 in secondaria. Secondo il direttore, i problemi principali sono quelli della mobilità (degli insegnanti e degli studenti) e i bassi salari. «Non stiamo tanto bene, però stiamo migliorando», conclude. In piazza incontro anche il medico, il dottor Francisco José Rosas Pro, che mi invita a casa sua. Sposato con Rina, infermiera, hanno una bambina. Sono qui dal 2012, ma in attesa di trasferimento.
«Manca molto – racconta il medico – l’appoggio dello stato, soprattutto per quanto concerne i medicinali. Non danno neppure quelli di base come amoxicillina e paracetamolo. Non rispondono alle nostre richieste. Oppure inviano medicinali non richiesti in quantità quando vedono che stanno per scadere».
![]()
Gli chiedo delle patologie più diffuse. «A parte la diarrea e problemi respiratori tipici, c’è la malaria, sempre presente. Ogni giorno ci sono pazienti. Spesso scelgo di dare loro i medicamenti anche se l’analisi del sangue è negativa, perché vengono da molto lontano. Qui a Soplín Vargas si tratta principalmente di malaria vivax, ma nei caserios (i villaggi più piccoli) c’è una prevalenza del falciparum» (sulla malaria vedi MC ottobre 2018 pag. 62).
Siamo interrotti per un’emergenza. Lo seguo al puesto de salud (consultorio medico) che dista un centinaio di metri. È una struttura in muratura relativamente grande ma triste e spoglia. Pare abbandonata. Le stanze non mancano, ma sono quasi tutte chiuse e vuote. L’unica aperta e attrezzata è quella sulla cui porta c’è il cartello «Tópico de emergencia». All’interno un paziente, sdraiato sul lettino, lamenta forti dolori al basso ventre. Francisco lo visita. Esce poco dopo. «Probabili calcoli renali. Ho dato dei medicinali e ordinato (all’unica addetta, ndr) una fleboclisi».
Al puesto de salud di Soplín Vargas l’umidità percorre muri e scalini, ma non c’è l’acqua per gli usi normali. «Una delle tante ragioni per cui ho chiesto di essere trasferito», chiosa il medico.
Alla sera racconto della mia visita all’ambulatorio. «Sì, è vero. Qui ci sono molte necessità – ammette padre Fernando -. I governi non si preoccupano della gente di questi territori. Sono interessati soltanto ad accaparrarsi le ricchezze della regione: per queste persone l’Amazzonia è sinonimo di denaro. Per me invece è il cuore del mondo».
Paolo Moiola
![]()
Nella comunità kichwa di Nueva Angusilla
«Sì, io sono il cacique»
Sul fiume Putumayo, come su tanti altri fiumi amazzonici, vivono varie comunità indigene. Spesso dimenticate dallo stato centrale.
Verso Nueva Angusilla. Da Soplín Vargas navighiamo lungo il rio Putumayo verso Sud per 140 chilometri. Quando il fiume incontra il rio Angusilla, suo affluente, siamo arrivati alla comunità kichwa di Nueva Angusilla.
L’avamposto militare – qualche casupola dipinta di verde e un’insegna posta sul terreno antistante – sta su un promontorio senza alberi. Ma la posizione è perfetta: all’intersezione tra i due fiumi. Poco più avanti, sul pontile un gruppo di adulti e bambini sono in attesa della nostra lancia. I cartelli di benvenuto tenuti dai piccoli sono per mons. José Javier Travieso Martín: è un’occasione unica perché il vescovo risiede a San Antonio del Estrecho, molto lontano da Nueva Angusilla.
Il villaggio è stato costruito con una struttura rettangolare: il lato libero guarda verso il fiume, sugli altri tre sono sorte le abitazioni. Le case – fatte di assi di legno e tetto di lamiera o di frasche – sono rialzate dal terreno di circa mezzo metro. Al centro, sproporzionata rispetto al resto, c’è la costruzione più moderna, chiamata Centro de Servicio de Apoyo al Hábitat Rural, ma da tutti conosciuta come «tambo». È un progetto del governo peruviano per ospitare – nei luoghi più disagiati – i principali servizi pubblici: registro civile, credito e appoggio tecnico ai contadini, consultorio medico, asilo nido per bambini, consulenza giuridica e altro ancora. Però, a Nueva Angusilla come altrove, c’è solo il contenitore fisico, mentre i servizi mancano o sono molto carenti.
«Qui ci sono circa 120 abitanti. Si vive di agricoltura e pesca. E poi lavoriamo con il legno con cui facciamo assi vendute in Colombia», mi dice gentile ma forse un po’ a disagio Eliseo, un abitante che si sta dirigendo verso il locale comunale – una struttura in legno aperta e con un tetto di frasche – dove il vescovo impartirà battesimi e comunioni.
![]()
Cerco il capo, il responsabile della comunità: il cacique, ma meglio sarebbe dire apu o curaca. Eccolo. Statura piccola e volto da giovanissimo, risponde volentieri alle domande anche se con visibile timidezza. «Sì, sono il cacique. Mi chiamo Jackson Kenide Mashacuri Andi e ho 24 anni. La popolazione mi ha eletto come autorità di qui. Mi piace molto stare con la gente per aiutarla a organizzarsi». E con orgoglio aggiunge: «Ho fatto il quinto grado della scuola secondaria e dunque sono capace di difendermi». Precisa che gli abitanti sono 117 che vivono coltivando yuca e platano (banane da cuocere, ndr) e pescando per il proprio consumo. Spiega che, come cacique, fa parte di una organizzazione chiamata Fikapir – Federación Indígena Kichwa Alto Putumayo Inti Runa -, la quale funge da intermediario con le autorità statali.
Chiedo dei problemi che ci sono. «Per la salute non c’è quasi appoggio. Per l’educazione stiamo cercando di avere professori bilingue. Adesso abbiamo soltanto insegnanti meticci che non parlano la nostra lingua. Qui la popolazione parla kichwa». Anche i giovani?, chiedo. «Sì, anche loro. Lo parlano in casa ma non a scuola».
Ci sono problemi di malaria? Fa una smorfia prima di rispondere: «Eh, sì. Soltanto un mese fa c’erano 20-25 persone contemporaneamente con la malaria. Malaria vivax». E c’è la posta medica?, intervengo. «Sì, ma non abbiamo il tecnico».
Oggi è una giornata di festa. Bisogna andare a mangiare. Pollo, riso, platano fritto. Prima di risalire sulla lancia, Jackson mi presenta la sua famiglia per un’ultima foto.
Paolo Moiola
![]()
Indigeni e bianchi
Una ciotola di «masato» (per un ipocondriaco)
Tra un indigeno e un bianco le diversità sono evidenti. Soprattutto quelle culturali. L’importante è accettarle, magari con un arricchimento reciproco. Racconto di un piccolo episodio di vita quotidiana.
Nueva Angusilla. Una semplicissima casa in legno rialzata da terra di circa un metro. Nessun mobile, un paio di secchielli (di plastica) con dell’acqua, qualche indumento appeso a fili volanti. Una famiglia numerosa e allargata (genitori, figli, nipoti) accoglie padre Fernando. In quanto amico del missionario, io sono un ospite da onorare come meglio si possa. E il meglio per una famiglia kichwa è offrire una ciotola colma di masato. È – lo confesso – un momento che temevo e che inevitabilmente si presenta. Tremo all’idea di dover ingerire quella bevanda tanto gradita dagli indigeni quanto indigesta per i non-indigeni, soprattutto se occidentali. Bere è un atto dovuto, segno di rispetto, riconoscenza, amicizia. Bere è però anche un rischio certo di avere conseguenze fisiche immediate e sicuramente poco piacevoli. Anni di esperienze negative mi vengono immediatamente alla memoria. Non c’è speranza di farla franca. È quasi matematico.
Il masato (aswa, in kichwa) è il nome di una bevanda molto comune in tutto il bacino amazzonico. È ottenuta a partire dalla yuca dolce (o manioca), una pianta con una radice a forma di tubero, commestibile e ricca di amidi. La sua preparazione è compito delle donne indigene. I tuberi vengono prima pestati e poi bolliti. La pasta ottenuta è quindi masticata dalle donne per provocarne la fermentazione. Da ultimo si diluisce la massa in acqua (quasi sempre di dubbia potabilità) e il masato è pronto per essere bevuto.
![]()
Prendo la ciotola di… plastica tra le mani. Appoggio le mie labbra incerte sul bordo. È come se quella bevanda biancastra e veramente poco attraente quasi mi guardasse e mi dicesse: «Bevimi!».
La decisione è repentina ed improvvisa. In un decimo di secondo passo la ciotola nelle mani compassionevoli di padre Fernando. Labbra appena inumidite, ma no, non ce l’ho fatta a bere. Però almeno sono arrivato lì, lì a pochissimo dalla temuta meta.
Cerco nella mia testa due paroline in lingua kichwa: «Yapa alli» (muy bueno, molto buono), dico con un sorriso tanto largo quanto bugiardo a tutti i presenti che sono lì davanti, con gli sguardi fissi su di me. E subito cerco di sviare l’attenzione. Una foto, una foto di tutti con padre Fernando. Sì, mi vergogno, ma il mio stomaco e probabilmente la mia salute sono salvi. Spero sia salva anche la mia reputazione presso quella famiglia kichwa di Nueva Angusilla. Sentendomi come colpevole di un reato, prometto loro che farò arrivare le foto cartacee di quella visita. Temo però che il masato tornerà ancora a materializzarsi davanti a me. Negli incubi notturni o nella realtà.
Paolo Moiola
















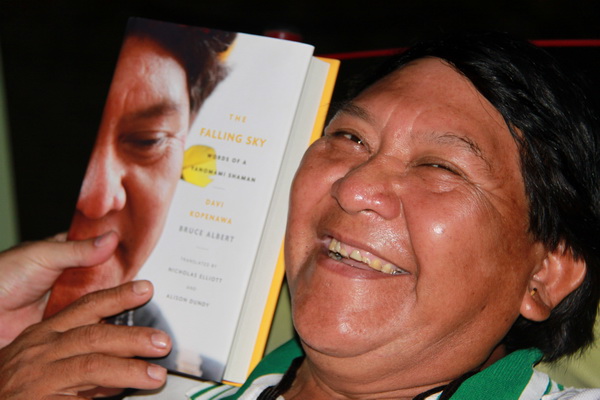 Boa Vista. La sede dell’associazione si trova in una via tranquilla. La si nota
Boa Vista. La sede dell’associazione si trova in una via tranquilla. La si nota copia.JPG)