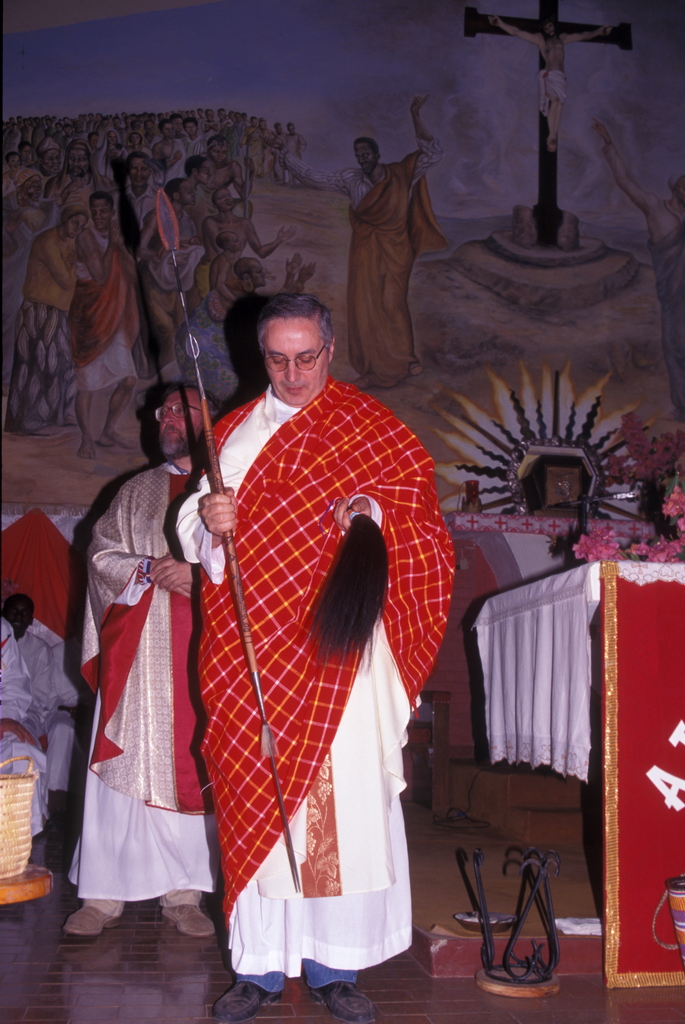Mondo. Morire di parto nel Sud globale
Tra il 2000 e il 2023 la mortalità materna è diminuita del 40% a livello mondiale.
Una buona notizia che, però, va tenuta insieme a un’altra: nel 2023 le donne che hanno perso la vita per cause legate alla gravidanza e al parto sono state 260mila. Il tasso di mortalità registrato (197 decessi ogni 100mila nati vivi) è ancora troppo alto per raggiungere l’obiettivo stabilito dall’Agenda 2030 (70 ogni 100mila).
Infine, anche tramite i dati sulla mortalità materna, si può certificare il divario che divide i paesi ricchi da quelli poveri. Due decessi su tre, infatti, sono avvenuti in Paesi fragili o colpiti da conflitti, il 70% in Africa subsahariana.
«Non si dimentica mai l’esperienza di quando una donna ti sta scivolando via tra le mani e sai che è troppo tardi», dice all’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) la dottoressa Hadiza Galadanci, docente di ostetricia e ginecologia all’Università Bayero di Kano, in Nigeria.
Parla di una donna che muore di emorragia mentre partorisce un bambino. Muore, cioè, a causa di una complicazione del parto che è frequente, ma, quando affrontata in modo adeguato, non mortale.
Tuttavia, i decessi per emorragia rappresentano il 27% dei casi di mortalità materna, e avvengono quasi tutti in Africa subsahariana, dove persistono numerose sfide, tra cui la mancanza di accesso all’assistenza prenatale, ad assistenti al parto qualificati, a farmaci e a strutture sanitarie.
Nel 2023 sono state 260mila le donne che nel mondo hanno perso la vita per cause legate alla gravidanza e al parto, un tasso di mortalità pari a 197 ogni 100mila nati vivi, troppo alto per raggiungere nel 2030 l’obiettivo di 70 ogni 100mila stabilito dall’Agenda 2030.
Il 92% di tutti i decessi si sono verificati nei Paesi a basso e medio reddito, e la maggior parte di essi si sarebbero potuti prevenire. Il 70% del totale è avvenuto in Africa subsahariana.
Il Paese della dottoressa Galadanci, la Nigeria, è stato nel 2023 il Paese «peggiore» nel quale diventare madre. Il tasso di mortalità materna e il numero assoluto di decessi sono stati i più alti al mondo (993 ogni 100mila nati vivi: circa 75mila donne, 205 ogni giorno).
Dopo la Nigeria, il tasso più alto si è registrato in Ciad (748, per 6mila decessi), poi in Sud Sudan e in Centrafrica (entrambi con un tasso di 692, per 2.300 e 1.700 decessi).
Il primo paese non africano per tasso era l’Afghanistan, con 521 donne morte ogni 100mila nati vivi. Il primo per numeri assoluti era, invece, l’India, con 19mila decessi (e un tasso, inferiore alla media mondiale, pari a 80).
Per fare un confronto: in Italia i decessi per cause correlate alla gravidanza e al parto sono stati 25 nel 2023, per un tasso pari a 6 ogni 100mila nati vivi.
Il nuovo rapporto delle Nazioni Unite, Trends in maternal mortality, lanciato il 7 aprile in occasione della Giornata mondiale della salute, mette sul piatto questi dati.
Lo fa sottolineando che, grazie al miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari essenziali in molti Paesi, tra il 2000 e il 2023 il tasso di mortalità materna è diminuito del 40%. Ma lo fa soprattutto denunciando la riduzione graduale dei fondi globali che hanno fatto registrare un notevole rallentamento nei progressi dal 2016 in poi, e che, secondo Unicef Italia, anche alla luce dei recenti tagli agli aiuti, «minacciano i fragili progressi nel porre fine alle morti materne».
La Giornata mondiale della salute ha dato il via a una campagna annuale intitolata «Inizi sani, futuri di speranza», per spronare i governi e la comunità sanitaria a intensificare gli sforzi per porre fine alle morti materne e neonatali prevenibili, e a dare priorità alla salute e al benessere a lungo termine delle donne.
Leggendo il rapporto Onu sono molti i dati interessanti che offrono un’immagine plastica delle disuguaglianze tra paesi ad alto reddito e quelli a basso reddito, e tra quelli con istituzioni stabili, e quelli coinvolti in conflitti di vario genere.
«Tra il 2000 e il 2023 – si legge sul sito dell’Organizzazione mondiale della sanità -, l’Europa orientale e l’Asia meridionale hanno ottenuto la maggiore riduzione complessiva del tasso di mortalità materna: un calo, rispettivamente, del 75% (da 38 a 9) e del 71% (da 405 a 117). […] La maggiore riduzione del rischio di mortalità materna durante questo periodo si è verificata nella regione dell’Asia centrale e meridionale, con un calo dell’83%, da 1 donna su 71 nel 2000 a 1 su 410 nel 2023. […].
L’elevato numero di morti materne in alcune aree del mondo riflette le disuguaglianze nell’accesso a servizi sanitari di qualità ed evidenzia il divario tra ricchi e poveri. Nel 2023, il tasso di mortalità materna nei Paesi a basso reddito era di 346 su 100mila nati vivi, contro 10 su 100mila nati vivi nei Paesi ad alto reddito.
Nel 2023, 37 Paesi sono stati classificati come in conflitto o in fragilità istituzionale/sociale, e rappresentavano il 61% delle morti materne globali, nonostante rappresentassero solo il 25% dei nati vivi.
Il tasso di mortalità materna è significativamente più alto nelle aree colpite da conflitti (504 decessi ogni 100mila nati vivi) rispetto ai contesti fragili (368) e ai contesti non in conflitto né fragili (99)».
Le donne nei Paesi a basso reddito hanno un rischio di mortalità materna più elevato: 1 su 66 contro 1 su 7. 933 nei Paesi ad alto reddito. «Le donne povere nelle aree remote – prosegue l’Oms – hanno meno probabilità di ricevere un’assistenza sanitaria adeguata. Questo è particolarmente vero per le regioni a basso reddito con un numero troppo piccolo di operatori sanitari qualificati […]. Gli ultimi dati disponibili suggeriscono che, nella maggior parte dei Paesi ad alto e medio reddito, circa il 99% di tutte le nascite beneficia della presenza di un’ostetrica, un medico o un’infermiera qualificata, mentre solo il 73% nei Paesi a basso reddito, e l’84% in quelli a reddito medio-basso».
La maggior parte delle morti materne è prevenibile, poiché le soluzioni sanitarie sono ben note. La salute materna e quella del neonato sono strettamente collegate. Per quanto riguarda le morti neonatali, si stima che ogni anno siano oltre 2 milioni i bambini che muoiono nel primo mese di vita, e circa altri 2 milioni che nascono morti. Per questo «è importante – dice l’Oms – che tutti i parti siano assistiti da operatori sanitari qualificati, poiché una gestione e un trattamento tempestivi possono fare la differenza tra la vita e la morte delle donne e dei neonati».
«Nel contesto degli Obiettivi di sviluppo sostenibile – conclude l’Oms -, i Paesi si sono uniti sull’obiettivo di accelerare il declino della mortalità materna entro il 2030. […] “ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per 100mila nascite […]”. Il tasso globale nel 2023 era di 197 per 100mila nati vivi […]. Tuttavia, le conoscenze scientifiche e mediche sono disponibili per prevenire la maggior parte delle morti. […] è il momento di intensificare gli sforzi coordinati e di mobilitare e rinvigorire gli impegni a livello globale, regionale, nazionale e comunitario […]».
Luca Lorusso