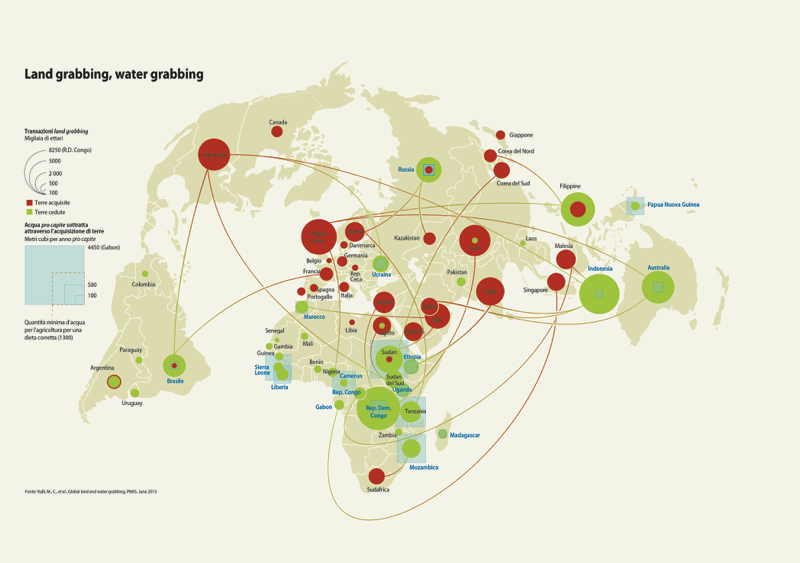Nel segno del Mekong
testo e foto di Piergiorgio Pescali |
Il nuovo Laos
Un’apertura made in China
Vientiane (gennaio 2020, poco prima che il mondo si fermi per la pandemia). Il mercato notturno lungo il Mekong è affollato di turisti che, dopo aver fatto la rituale foto del tramonto sul fiume, si riversano tra le bancarelle spulciando tra magliette, borse, ciabatte e souvenir vari. I ristorantini lavorano a pieno ritmo offrendo piatti locali e internazionali, mentre i motorini sfrecciano fendendo nubi di fumo liberate delle griglie su cui vengono abbrustoliti pesci, cotiche di maiale, polli e salsicce. Sul Quai Fa Ngum, il lungofiume, i centri di massaggi – la maggior parte dei quali (è bene rimarcarlo) non offrono supplementi sessuali – fanno a gara per accaparrarsi i clienti.
La capitale del Laos, relativamente assopita durante il giorno, di notte si trasforma in un formicaio di brulicanti attività, ma rispetto alle città vietnamite, thailandesi e cambogiane, Vientiane rimane, comunque, un grande villaggio di frontiera.
L’isolamento della nazione dovuto alla sua posizione geografica, alla conformazione del territorio e all’esiguità della popolazione ha permesso al Laos di mantenere un fascino particolare nell’immaginario collettivo del viaggiatore. Scenari spettacolari immersi in una natura incontaminata, viaggi lungo i fiumi, minoranze etniche ancora relativamente isolate dall’infezione del turismo di massa e dei tour operator, sono stati per decenni le cornici ideali entro cui si organizzava una vacanza in questo paese del Sud Est asiatico.
Tutto, però, sta per cambiare in un modo così veloce che, probabilmente già nei prossimi anni, il Laos descritto oggi sarà una memoria relegata nei libri e nelle fotografie rimaste nei cassetti o nei nostri computer.

Strade e ferrovie: l’attivismo cinese
Viaggiando per la nazione non si può fare a meno di notare i numerosi cantieri che stanno lavorando a quel progetto colossale voluto dalla Cina inserito in quel fronte di espansione economica denominato One belt, One road, da noi meglio conosciuto come «nuova Via della Seta». L’idea, è noto, è quella di collegare il cuore produttivo cinese con il resto del mondo (Asia, Europa, Africa, America Latina) attraverso la costruzione di una rete di infrastrutture che si diramano principalmente verso Sud e verso Ovest; un piano miliardario (si parla di mille miliardi) che vede la partecipazione di una sessantina di stati, tra cui anche l’Italia. Nonostante l’economia laotiana non sia sviluppata quanto quelle dei vicini, la nazione è entrata nel mirino di Pechino essenzialmente per la sua posizione geografica che la pone come crocevia obbligato sulla linea di passaggio delle grandi arterie di comunicazione tra la Cina, il Mar Cinese meridionale e lo Stretto di Malacca.
I grandi progetti di comunicazione che collegheranno Singapore a Kunming si sviluppano attraverso la costruzione di una superstrada a quattro corsie e di una ferrovia ad alta velocità, la Pan-asiatica, lungo sei paesi (Singapore, Malesia, Thailandia, Laos, Myanmar e Cina). Il tratto laotiano si dipanerà tra Vientiane e Boten per un totale di 414 km di cui il 47% nascosti in settantacinque tunnel. Iniziata nel dicembre 2016, l’intera opera dovrebbe essere terminata (Covid-19 permettendo) a tempo di record nel 2021 (a dicembre 2019 l’80% del tratto era già stato completato), mentre nel 2023 la ferrovia sarà collegata alla rete thailandese attraverso un nuovo ponte in fase di costruzione tra Thanaleng (all’altezza di Vientiane) e Nong Khai, in Thailandia1.
Il programma è tenacemente appoggiato dal governo tramite la figura di Lattanamany Khounnyvong che, oltre ad essere viceministro dei Lavori pubblici e dei Trasporti, occupa anche la posizione di presidente del Comitato di direzione della Laos-China Railway Construction Project, l’azienda statale (30% del governo laotiano e 70% del governo cinese) che sta costruendo la ferrovia e ne gestirà l’operatività.

La popolazione laotiana ha accolto tutto sommato favorevolmente il progetto, non solo perché nella nazione ogni forma di opposizione politica e sociale alle decisioni dell’Assemblea nazionale dominata dal Partito rivoluzionario popolare è ostacolata dal governo, ma anche per il fatto che sarà facilitato lo spostamento di persone e merci garantendo, almeno sulla carta, un miglioramento delle condizioni di vita. Nella novella Thi Pak Chai («Il rifugio del cuore»), lo scrittore Thongbay Photisane descrive bene l’atteggiamento che ho riscontrato nei villaggi toccati dal progetto sinolaotiano: «La notizia dell’arrivo dei lavoratori che costruivano la strada si sparse di bocca in bocca e in ogni casa del villaggio. I più anziani apprezzarono e furono contenti che l’unica strada esistente, ormai da diversi anni polverosa, sporca, fangosa e cosparsa di buche, sarebbe finalmente stata riparata e migliorata».
Del resto, già in questi anni le reti di comunicazione laotiane sono state oggetto di ampi investimenti che si sono favorevolmente ripercossi sull’economia. Le vie, oltre ad essere state potenziate, possono contare su una buona qualità del manto stradale tanto che il 65% dei villaggi ha un accesso carrozzabile per tutto l’anno e solo il 7,9% della popolazione vive in villaggi completamente isolati (nel 2005 era il 21%). I tempi di percorrenza si sono accorciati e anche il parco dei veicoli dei trasporti pubblici è sensibilmente migliorato rendendo i trasferimenti più confortevoli. Solo vent’anni fa, spostarsi da un luogo all’altro del paese era insicuro a causa del banditismo e della guerriglia etnica; agli occidentali veniva sconsigliato di viaggiare in strada da Vientiane a Luang Prabang o nelle aree abitate da minoranze etniche meno presidiate dall’esercito. I mezzi pubblici erano rari e affollati e molti passeggeri erano costretti a spostarsi pigiati all’interno di abitacoli fatiscenti o affrontare il viaggio fermamente aggrappati sui portapacchi posti sul tetto.
È ancora Thongbay Photisane a darci uno spaccato della nuova vita nei villaggi dopo l’arrivo delle strade: «Nel villaggio i lavori per la costruzione della nuova strada continuavano. Da mattina a sera si sentiva il rumore dei trattori, dei camion e delle ruspe. La strada, prima fangosa e piena di buche, divenne liscia e larga come mai prima d’allora. Gli abitanti del villaggio strinsero amicizia con i lavoratori e la strada, in precedenza silenziosa e polverosa, prese nuova vita nel modo più straordinario. La sera i lavoratori si riunivano e si rilassavano mangiando e bevendo la tradizionale bevanda alcolica laotiana. Le ragazze, che prima d’allora non si erano mai truccate, iniziarono a farsi belle dipingendo le loro labbra con rossetti».
È al di fuori del confini del Laos, invece, che il programma di sviluppo delle infrastrutture dei trasporti incontra una maggiore opposizione.
Per finanziare il progetto ferroviario, che costerà 6,7 miliardi di dollari, Vientiane ha dovuto chiedere un prestito di 480 milioni di dollari (2,8% del Pil) alla Eximbank cinese destando la preoccupazione degli istituti finanziari internazionali per l’aumento del debito pubblico, oggi pari al 65% del Pil.
Il governo è, inoltre, accusato di aver costretto 4.400 famiglie di 167 villaggi ad abbandonare le loro case confiscando 3.830 ettari di terreno, superiori alle reali esigenze richieste per la costruzione delle infrastrutture2 e contribuendo alla deforestazione del paese (se nel 1940 la superficie forestale del paese era il 70% del totale, e nel 1995 il 47%, oggi è solo il 40%)3. Lattanamany Khounnyvong ha dichiarato che gli appezzamenti espropriati saranno risarciti, ma i proprietari lamentano che i rimborsi ottenuti, 595-715 Usd (dollari Usa) per ettaro, sono di gran lunga inferiori al prezzo di mercato, valutato attorno ai 1.420 Usd4.

Turismo, tra idealismo e devastazione
Poi ci sono i turisti che, dai finestrini dei bus con l’aria condizionata, osservano perplessi l’avanzare dei lavori temendo che sia sfregiata quella parte di mondo che invece vorrebbero mantenere intatta per portare a casa selfie con gente rigorosamente vestita in abiti tradizionali. Mantenere il Laos, al pari di qualunque altra realtà classificata come «esotica», immutabile come un dipinto naïf e idolatrare modi di vita di popolazioni indigene è una costante presente in molte realtà del turismo sui generis.
Sono tanti gli occidentali imbevuti di un ecologismo new age che idealizzano le comunità etniche elevandole a modello di sviluppo alternativo da seguire per vivere in simbiosi con l’ambiente. Poco importa se, nella realtà, la maggioranza di queste comunità vede la natura in una doppia valenza, foriera di vita e di morte. Ben lontano dalle loro menti è il concetto proprio delle società industrializzate che identifica la natura unicamente come una «madre benigna». Quando si deve lottare ogni giorno per sopravvivere non si ha il tempo, la voglia e la forza di rispettare qualcosa che si ritiene, nel migliore dei casi, indifferente al futuro e al benessere della propria famiglia e della comunità.
Viaggiando in Laos tra queste popolazioni e con i mezzi locali è chiaramente visibile la mancanza di un concetto di rispetto dell’ecosistema secondo la nostra concezione occidentale. Dai finestrini dei bus, dalle barche che solcano i fiumi o dalle verande delle case in cui abitano queste popolazioni, viene gettato nell’ambiente di tutto: sacchetti di plastica, bottiglie di vetro, abiti consunti, copertoni, carcasse di moto, auto o addirittura tuc-tuc o minibus. Strade e fiumi sono costellati di rifiuti. E sono ancora queste popolazioni che cacciano o aiutano i bracconieri a stanare e uccidere animali le cui parti anatomiche sono ritenute miracolose per la medicina tradizionale. Insomma, l’idealismo proprio di alcuni movimenti primitivisti cozza violentemente contro una realtà ben differente da quella ingenuamente proposta.

Vang Vieng è forse l’esempio più eclatante di questa doppia visione. Fino al 2012 era una cittadina devastata dal turismo giovanile: centinaia di migliaia di ragazzi muniti di zaino si riversavano nel villaggio facendo uso di stupefacenti e alcool per poi ridiscendere il fiume Nam Song a bordo di camere d’aria, tuffarsi nelle acque del fiume, lanciarsi lungo le zip-lines (speciali teleferiche a scopo ludico, ndr). I bar mettevano a disposizione le droghe più varie: da funghi allucinogeni all’oppio, dalle metamfetamine alla marijuana che, mescolate alla grande quantità di liquori offerti, formavano pericolosi cocktails.
La popolazione della cittadina non ne poteva più: il turismo e la presenza di questi backpackers, dopo aver distrutto la tranquillità e l’armonia sociale metteva a rischio lo stesso ecosistema. I rifiuti non si riuscivano a smaltire, i campi erano cosparsi di bottiglie, sacchetti di plastica, vestiti, cartacce. Il sistema sanitario locale era al collasso e il piccolo ospedale lavorava solo per salvare turisti in stato di coma alcolico, in overdose o che si erano feriti durante le loro bravate. Nei periodi di alta stagione le strutture ospedaliere dovevano curare tra i cinque e dieci turisti al giorno.
Nell’agosto 2012 le autorità laotiane decisero finalmente di dare un taglio a tutto questo: furono chiusi i bar più problematici e imposero direttive più stringenti per regolare la vita notturna ed escursionistica. Le zip-line più pericolose, quelle non in regola e i trampolini lungo il fiume vennero distrutti. Il tutto però sembra non sia bastato: ancora oggi ci sono siti5, che danno indicazioni su come sfruttare il turismo sessuale specificando in quali bar è possibile comprare droga.

Governo e Ong impegnati nello sviluppo
Al tempo stesso, però, c’è un’altra fetta, seppur minoritaria, di occidentali che prestano opera di volontariato per avviare programmi di sviluppo rurale. Uno di questi è Sae Lao6, un progetto fondato nel 2008 da Sengkeo Frichitthavong che cerca di aiutare la sostenibilità sociale e ambientale della zona di Vang Vieng, mentre un altro è l’Eefa (Equal education for all), progetto di una Ong che ha permesso a cinquecento ragazzi laotiani di frequentare classi di lingua inglese e ha avviato programmi di igiene dentale7.
In tutto il Laos diverse Ong lavorano per aiutare piccole comunità, ma non è un compito facile: il governo vuole avere sotto stretto controllo ogni attività connessa con enti stranieri e ogni visita ai luoghi dove operano le diverse organizzazioni deve essere approvata attraverso un lungo ed estenuante iter burocratico. È comunque anche grazie a questa cooperazione e a un’oculata selezione delle agenzie interessate a interventi nel paese, che l’«indice di sviluppo umano» è salito da 0,399 nel 1990 a 0,604 nel 20198.

Un indicatore ancora basso (secondo l’Onu il Laos si pone al 140° posto nella classifica mondiale), ma i successi della politica adottata dai governi succedutisi alla guida del paese dal 1975 a oggi sono evidenti. Tra il 1992 e il 2013 la fetta di laotiani sotto la linea di povertà è dimezzata passando dal 46 al 23,2% della popolazione9 e oggi l’economia è la tredicesima al mondo come ritmo di crescita10. Siamo comunque lontani dallo sradicamento di povertà e malnutrizione: il traguardo di un Pil che raggiungesse i 3.100 dollari pro capite prospettato qualche anno orsono, si è rivelato irraggiungibile. Secondo il computo della Banca mondiale, nel 2018 ogni laotiano contribuiva per 2.460 dollari alla ricchezza nazionale11. Inoltre, il benessere è estremamente segmentato sulla base di una rigida frammentazione etnica: due terzi di quella fetta di popolazione che sta sotto il livello di povertà appartengono alle minoranze nazionali e, tra queste, Mon-Khmer e Hmong sono le più colpite.
Come spesso accade nei paesi in via di sviluppo in questa parte del mondo, l’industria tessile è la calamita con cui si cercano di attirare investimenti stranieri: un centinaio di aziende, concentrate principalmente a Vientiane e Savannakhet, occupano circa trentamila persone, la maggioranza delle quali ragazze sotto i 25 anni12. Le condizioni di lavoro a cui esse sono sottoposte non raggiungono le devastanti realtà cambogiane e, a differenza di quanto accade nel vicino paese, un recente rapporto dell’International labour office (Ilo) delle Nazioni unite afferma che si sta assistendo a un lento, ma costante miglioramento nel trattamento all’interno dei reparti produttivi13. Insomma, contrariamente al liberismo economico selvaggio scelto dalla Cambogia, qui in Laos la presenza dello stato sembra farsi sentire.

La spinta e i costi delle dighe
Il motore principale con cui il presidente Bounnhang Vorachit vuole trainare l’economia nei prossimi decenni è quello energetico. Il Laos, assieme a Myanmar, Thailandia, Cambogia e Vietnam fa parte del basso bacino del Mekong14, un’area ricca di oro, metano, piombo, zinco, fosfato, potassio, gas, pietre preziose e abitata da sessantacinque milioni di persone, l’80% delle quali vive nelle campagne15.
Il territorio laotiano è una potenziale fonte di enorme ricchezza, soprattutto di energia idroelettrica. I milleottocento chilometri del Mekong che scorrono entro e lungo i confini del paese e le decine di altri affluenti potrebbero liberare milioni di watt di energia, un tesoro immenso che viene sempre più sfruttato in nome di uno sviluppo nazionale.
Secondo uno studio della Mekong River Commission16, nel 2020 lo sviluppo degli impianti idroelettrici sul fiume Mekong porterà alle casse dell’economia laotiana 21,1 miliardi di dollari che saliranno a 36,0 miliardi nel 204017,18. Queste cifre, però, non includono i costi che la nazione dovrà sostenere per fronteggiare i danni all’ambiente e alle microeconomie derivati da questa politica.
Lo sviluppo delle stazioni idroelettriche sta causando la veloce erosione degli argini dovuti sia alle innumerevoli cave, più o meno abusive, che sorgono lungo il corso dei fiumi, sia all’aumento dei sedimenti che, trattenuti dalle dighe, non riescono a scendere a valle. All’altezza di Pakse, nel Laos meridionale, i sedimenti portati a valle dal Mekong sono scesi da una media di 147 tonnellate per anno alle attuali 6619. Per fronteggiare il problema, il paese dovrà intervenire con progetti che, nel solo 2020, costeranno 228 milioni di dollari per salire a 990 milioni nel 204020. Il problema emerge in tutta la sua drammatica evidenza viaggiando lungo le vie idriche ancora percorribili dai battelli e dalle barche pubbliche o private21. I nuovi cantieri, per lo più cinesi, che innalzano dighe e centrali idroelettriche, sollevano le proteste di molti abitanti contro la dissennata politica del governo. La costruzione di sbarramenti idrici influisce pesantemente sulla vita quotidiana dei laotiani, e le tradizionali vie fluviali, solcate ogni giorno da centinaia di imbarcazioni, sono ormai interrotte o costringono ad allungare i tempi di trasferimento per aggirare gli sbarramenti. Decine di migliaia di contadini e pescatori sono stati costretti ad abbandonare i villaggi inondati dai bacini artificiali.

Sono proprio le microeconomie che si sviluppano attorno alle dighe quelle che subiranno i danni maggiori. Il governo ha affermato che il 70,8% dell’energia prodotta in Laos viene esportata22, diretta per il 44% alla Thailandia, il 10% in Cambogia e il 15% in Vietnam23. I proventi di tale operazione non andranno però a beneficiare le comunità interessate e i danni economici e ambientali saranno immensi, specialmente nel lungo periodo.
![]() La maggioranza della popolazione che vive lungo il bacino del Mekong è impiegata nell’agricoltura, in particolare nella coltivazione del riso24. I funzionari governativi, nel tentativo di rassicurare la popolazione che imbrigliare le acque dei fiumi consentirà di regolare piene e siccità stagionali così da avere più sicurezza nei raccolti e aumentare la produzione, si sono «dimenticati» di aggiungere che, a lungo andare, il suolo rischierà di inaridirsi a causa della mancanza di ricambio naturale dei sedimenti. Tra il 2007 e il 2020 il gettito dell’agricoltura sull’economia laotiana è aumentato del 7,5% (45,7 miliardi Usd nel 2020 contro i 42,5 nel 2007), molto meno rispetto a quello cambogiano e vietnamita nello stesso periodo (rispettivamente +105% e +21,2%)25.
La maggioranza della popolazione che vive lungo il bacino del Mekong è impiegata nell’agricoltura, in particolare nella coltivazione del riso24. I funzionari governativi, nel tentativo di rassicurare la popolazione che imbrigliare le acque dei fiumi consentirà di regolare piene e siccità stagionali così da avere più sicurezza nei raccolti e aumentare la produzione, si sono «dimenticati» di aggiungere che, a lungo andare, il suolo rischierà di inaridirsi a causa della mancanza di ricambio naturale dei sedimenti. Tra il 2007 e il 2020 il gettito dell’agricoltura sull’economia laotiana è aumentato del 7,5% (45,7 miliardi Usd nel 2020 contro i 42,5 nel 2007), molto meno rispetto a quello cambogiano e vietnamita nello stesso periodo (rispettivamente +105% e +21,2%)25.
Anche l’industria ittica, la seconda fonte di approvvigionamento alimentare ed economico delle popolazioni rivierasche, è in pericolo a causa delle chiuse. Il gettito economico di questa attività si è dimezzato rispetto al 2007, scendendo da 8,3 miliardi di dollari ai 4,7 attuali26. Le ditte costruttrici delle dighe non hanno approntato sistemi che consentano alla fauna di passare da un tratto all’altro dei fiumi interessati dagli sbarramenti, isolandone i diversi corsi e aumentando così il rischio di estinzione. L’intera popolazione degli ottantacinque delfini dell’Irrawaddy (Orcaella brevirostris) nell’arcipelago fluviale di Si Phan Don è minacciata dalla costruzione della diga di Don Sahong27, a un chilometro e mezzo dal confine cambogiano. Entro il 2040 la quantità di pesce nel Mekong diminuirà del 50% in Laos e questo, oltre a essere un problema economico per molte famiglie, aggraverà la malnutrizione visto che il pesce è il principale alimento che garantisce un’apporto proteico alle popolazioni insediatesi lungo i fiumi laotiani.
Infine, vi è anche un problema di sicurezza, di cui numerose agenzie internazionali da tempo hanno avvertito il governo centrale, senza successo. Il disastro di Xe Pian-Xe Namnoy, nella provincia di Champasak è stato solo il più grave (e neppure l’ultimo) di una serie di incidenti succedutisi negli anni. Il 23 luglio 2018 una delle otto dighe del complesso, formato da tre dighe principali e altre cinque ausiliarie che avrebbero plasmato un bacino artificiale alto 73 metri e lungo 1.600 metri, è crollata riversando migliaia di metri cubi di acqua su diciannove villaggi, uccidendo settantuno persone e colpendo anche quindicimila cambogiani della provincia di Stung Treng. Cinquemila persone vivono ancora in campi temporanei e il governo di Vientiane ha già avvisato che occorreranno almeno quattro o cinque anni prima che si possa trovare loro una sistemazione definitiva. Nel frattempo, alle famiglie delle settantuno vittime è stato dato un indennizzo una tantum di diecimila dollari e una fornitura di venti chilogrammi di riso al mese; a tutti gli altri, oltre alle derrate alimentari, vengono consegnati 60-75 dollari mensili28.

Le responsabilità dell’accaduto vengono rimpallate da una parte all’altra. L’impianto di Xe Pian-Xe Namnoy, data la sua complessità e l’elevato costo (1,02 miliardi di dollari), è stato costruito da una cordata di imprese: le sudcoreane SK Engineering & Construction (azionaria al 26%), la Korea Western Power (azionaria al 25%), la thailandese Ratchaburi Electricity Generating Holding (azionaria al 25%) e la laotiana Lao State Holding Enterprise (azionaria al 24%).
La commissione indipendente incaricata dal governo di far luce sul motivo dell’incidente ha concluso che il crollo è stato dovuto a un difetto di costruzione29, ma le aziende coinvolte ed appoggiate dalle quattro banche thailandesi finanziatrici del progetto30, hanno rigettato l’argomentazione finale riuscendo a riprendere i lavori e a concluderli alla fine del 2019.
Di fronte a tali situazioni l’atteggiamento del governo è decisamente ambiguo: al World Economic Forum of Asean, tenutosi nel settembre 2018, il primo ministro laotiano Thongloun Sisoulith, dopo aver affermato che il «Laos non potrà diventare la batteria dell’Asia perché la nostra capacità di sviluppo energetico è molto limitata rispetto alla richiesta dei paesi Asean nostri vicini», ha subito dopo specificato che la nazione «ha la capacità di aumentare il suo potenziale in termini di risorse idriche. Possiamo produrre una quantità di energia sufficiente per il Laos e che può essere esportata nei paesi limitrofi»31.
In linea con questo schema, la mappa delle centrali idroelettriche già presenti o programmate sui fiumi laotiani è impressionante: nel 2005 c’erano undici dighe con nove stazioni idroelettriche per una capacità installata di 679 megawatt32, nel 2015 la capacità aveva raggiunto i 3.894 MW33. Nel maggio 2019 sessantatré stazioni idroelettriche fornivano 7.213 MW; altre 112 centrali erano in costruzione. A queste entro il 2040 se ne dovrebbero aggiungere 340, con un totale produttivo di 19.494 MW34.
L’alternativa, secondo il governo di Vientiane, è un ritorno al carbone più di quanto stia facendo oggi. Nel 2015 è entrata in funzione la centrale di Hongsa che ha quadruplicato la produzione di energia elettrica da carbone (da 1.055 chilotonnellate nel 2013 a 4.793 nel 2015)35.
Oggi l’energia prodotta dal paese è per il 14,9% derivata dal carbone e per l’85,1% dalle centrali idroelettriche, ma nel 2040 il divario diminuirà in un rapporto di 22 a 8836.

Il nuovo «Triangolo d’oro»
Ridiscendere i fiumi laotiani non è solo un modo per accorgersi dei cambiamenti che andranno ad influire sulla vita di sette milioni di persone, ma anche fare un tuffo nel passato. Sebbene oggi si usino ben altri canali, il Mekong è stato per decenni il punto di transito della droga proveniente dal leggendario «Triangolo d’oro». Oggi questa regione è più un retaggio per turisti, un punto geografico che riunisce in un unico vertice tre paesi: Thailandia, Laos e Myanmar. Il Laos ha creato una zona a economia speciale nella speranza di attirare miliardari cinesi con la costruzione di un casino e di alcuni hotel che si affacciano sul Mekong. Le uniche monete accettate, oltre ai dollari, sono il bath e lo yuan. I campi di oppio sono scomparsi da decenni spostandosi verso l’interno oppure, più semplicemente, sostituiti da fabbriche di metamfetamine, più facili da mimetizzare, preparare e da smerciare. Secondo un rapporto dell’Unodc (United Nations Office on Drugs and Crime) tra il 2013 e il 2018 la quantità d’oppio prodotta dal Myanmar si è ridotta del 40%, ma al tempo stesso sono aumentati i laboratori di produzione chimica artificiale di stupefacenti37.
Nei soli due mesi di febbraio e marzo 2018 nello stato Shan del Myanmar sono stati scoperti e distrutti sei laboratori di produzione di droghe sintetiche38, mentre nel 2018 in Asia Orientale e nel Sudest asiatico sono state sequestrate 116 tonnellate di metamfetamine, in aumento rispetto alle 82 tonnellate confiscate l’anno precedente39.
Il Laos è diventato terra di transito non solo delle droghe sintetiche dirette per la maggior parte verso la Thailandia, ma anche di prodotti usati per la sintesi di metamfetamine nei laboratori del Myanmar e della Cina e per il loro smercio. Efedrina, pseudoefedrina, 1-fenil-2-propanone (P-2-P) sono i reagenti più comunemente usati dai produttori. Dato che risulta sempre più difficile commerciare queste merci, i boss della droga hanno iniziato a produrle direttamente in Laos partendo da prodotti sino ad oggi non sorvegliati dalle squadre antidroga, come il 2-bromo-1-fenil-1-propanone (2-bromopropiofenone) o cianuro di sodio (NaCN).
Le metamfetamine stanno soppiantando le altre droghe: una pastiglia in Laos viene venduta sul mercato a due dollari. Non proprio conveniente, ma sicuramente meno costosa rispetto all’eroina (24 dollari al grammo). I sequestri di metamfetamine, dopo aver avuto un minimo storico nel 2016 (meno di tre milioni di pastiglie sequestrate), nel 2018 hanno raggiunto il massimo con 21 milioni di pillole intercettate40.

L’oppio e la guerra del Vietnam
Il commercio di droga nell’area del Sudest asiatico è un’attività storicamente utilizzata nel bilancio economico delle popolazioni locali. Fino agli anni Sessanta la coltivazione dell’oppio era limitata al solo consumo interno, ma l’avvento al potere di Mao Zedong nel 1949 rivoluzionò involontariamente per sempre questo equilibrio. I ribelli del Kuomintang si rifugiarono in Birmania (oggi Myanmar) e, per finanziare la loro rivolta contro i comunisti, iniziarono a coltivare oppio aiutati dalla Cia. Il commercio si rivelò così redditizio che i servizi segreti statunitensi continuarono a incentivare la coltivazione sia nel Triangolo d’oro, ma soprattutto tra le popolazioni Hmong del Laos41.
Ben presto queste minoranze e la loro abilità nel lavorare il papavero da cui si ricavava l’oppio divennero una colonna portante nella guerra contro il Vietnam. Tra il 1964 e il 1973 l’Us Air Force condusse una serie di incursioni aeree, tenute segrete al Congresso, in appoggio al governo monarchico e in opposizione al Pathet Lao, il movimento di guerriglia di ispirazione socialista. In meno di dieci anni, un paese formalmente neutrale come il Laos fu squassato da 270 milioni di bombe lanciate durante l’arco di 580mila missioni42. Queste bombe lasciano ancora oggi un segno nella società laotiana, ma pochi se ne accorgono. Sembra quasi che il Laos non sia stato scalfito dalla storia che ha plasmato l’ex Indocina. Una storia drammatica, ma al tempo stesso affascinante perché fatta non solo di eccidi, guerre, colonialismo, ma anche di popoli che hanno saputo tenere testa a potenze mondiali politicamente e militarmente soverchianti. Chi va in Cambogia sarà avvolto dai ricordi e dalle testimonianze del periodo di Kampuchea Democratica; chi cammina in Vietnam troverà ovunque memorie della guerra che, fino al 1975, ha sconvolto il paese. Chi arriva in Laos, invece, non ha la sensazione di respirare il passato più recente, nonostante il paese sia stato pesantemente coinvolto nella guerra del Sudest asiatico sin dal 1964. Sembra che la storia, qui sia stata dimenticata.
I turisti passeggiano allegramente lungo le vie delle cittadine e dei villaggi, quasi non accorgendosi delle innumerevoli bandiere con la falce e martello che ricordano di essere, pur sempre, in un paese retto da un governo socialista.
Per percepire la storia del Laos bisogna abbandonare le tradizionali vie del turismo, deviando dalle rotte principali, e cercare nelle periferie delle città o nei villaggi più isolati. È allora che si incrociano le vicende più atroci, quelle fatte di bombardamenti segreti, di mine ancora inesplose che continuano a mietere vittime, di fabbriche di protesi, di sminatori che per 240 dollari al mese rischiano ogni giorno la loro vita.
Consiglio sempre a chi si reca in Laos, di visitare la Piana delle Giare prendendo, in partenza o in arrivo, un volo aereo. È dall’alto che si ha la chiara visione di cosa abbia significato, per questa nazione essere stata costantemente martellata da bombardamenti. La provincia di Xiangkhoang è una delle aree più colpite dalle incursioni e i crateri sono ancora ben visibili nella conformazione del territorio nonostante siano passati ormai quasi cinquant’anni dalla fine delle ostilità.

I pericolosi «ricordini» della guerra
Se il Vietnam ha ereditato il dramma dell’agente arancio e la Cambogia quello delle mine, il Laos sta ancora lottando contro gli ordigni che, raggiungendo inesplosi il terreno, oggi costituiscono un pericolo per la vita di migliaia di persone. Si stima che il 30% delle bombe lanciate durante le missioni aeree non abbia detonato; il che significa che il terreno, alla fine della guerra, era cosparso da almeno 80 milioni di ordigni pronti ad esplodere.
La situazione oggi non è molto più rosea: il governo laotiano ha valutato che 8.470 chilometri quadrati di superficie del paese sarebbero contaminati da bombe a grappolo (Cluster munition remnamnts, Cmr) e 87.000 da Uxo (Unexploded ordnance)43,44, ma solo nel 2021, al termine di un lavoro di ricerca che sta effettuando il Mag (Mines advisory group), si saprà nel dettaglio quanta superficie di territorio laotiano sia ancora contaminata. A oggi, meno dell’1% delle munizioni sono state distrutte. Gli ordigni causano danni non solo all’economia del paese, ma dissestano anche la pace e la convivenza sociale. Ampie aree agricole non possono essere coltivate a causa della probabile presenza di Uxo, quindi i contadini si trovano a dover dividere terreni con conseguenti discussioni e diatribe. Inoltre, vivere con la costante paura di incappare in una bomba inesplosa innalza la tensione sociale.
La bonifica del territorio è costosa e richiede sforzi immani sia da parte del governo laotiano che da parte della popolazione. Gli Stati Uniti, principali responsabili di questa devastazione, dal 1995 al 2016 hanno donato un totale di 169 milioni di dollari per programmi di bonifica e attività correlate45 a cui si sono aggiunti 90 milioni di dollari promessi da Obama durante la sua visita effettuata nel 201646. L’allora presidente Usa era stato particolarmente colpito dalla situazione laotiana affermando che «in nove anni, tra il 1964 e il 1973, gli Stati Uniti hanno lanciato più di due milioni di tonnellate di bombe sul Laos, più di quanto ne abbiamo lanciate su Germania e Giappone assieme nella Seconda guerra mondiale. Questo ha reso il Laos il paese più bombardato nella storia. Penso quindi che gli Stati Uniti hanno un obbligo morale nell’aiutare il Laos a guarire»47.
Tremila operatori suddivisi in nove organizzazioni internazionali e due battaglioni dell’esercito laotiano lavorano nel campo della bonifica del territorio e nei programmi di prevenzione e cura traumatica della popolazione48.

La minaccia degli Uxo è data dal fatto che ognuno di essi ha un grado di pericolosità differente dovuto non solo al tipo e alla quantità di esplosivo contenuto (ci sono 186 diversi tipologie di Uxo in Laos)49, ma anche al grado di corrosione, alla profondità in cui si trovano nel terreno, alla condizione del dispositivo di innesco. Basta accendere un fuoco affinché un ordigno posto a meno di venticinque centimetri di profondità possa detonare50. È quindi indispensabile, oltre al lavoro di ricerca e disinnesco, programmare un’intensa opera di informazione presso scuole, villaggi, centri di aggregazione sociale. Nel 2012 Vientiane ha avviato Safe path forward 2 (Avanzamento del cammino di sicurezza 2), un programma che terminerà nel 2022 e che ha come obiettivo quello di ridurre le vittime (morti e feriti) da 300 a 75 mediante la bonifica di 200 chilometri quadrati di territorio all’anno51. Grazie a queste campagne e alla bonifica di terreni, gli incidenti e i morti avvenuti nel Laos tra il 2008 e il 2018 a causa degli Uxo è drasticamente diminuito passando da 302 vittime (di cui 99 morti) nel 2008 a 24 (di cui 3 morti) nel 201852.
Tutto questo, però ha un costo enorme: contro una stima di circa 50 milioni di dollari all’anno per bonificare la nazione, assistere e curare le vittime, garantire loro la sopravvivenza, il governo laotiano ne fornisce 15 milioni, contando per il rimanente sugli aiuti internazionali i quali, oltre che dagli Stati Uniti, arrivano da Irlanda, Unione Europea, Nuova Zelanda, Lussemburgo, Canada, Corea del Sud53.
La guerra, nel Sudest asiatico, non è ancora finita.
Piergiorgio Pescali

Note al testo
- (1) https://laotiantimes.com/2017/02/20/everything-you-need-to-know-laos-china-railway/
- (2) http://www.asianews.eu/content/compensation-payments-laos-china-railway-slated-completion-2019-85946
- (3) World Bank Group, Lao People’s Democratic Republic Systematic Country Diagnostic, Priorities for Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity – Capitolo 2. The nature of Lao Pdr’s growth and its constraints, pag. 11, 9 marzo 2017.
- (4) Radio Free Asia, Families in Oudomxay province first to receive compensation from Lao-China Railway, 14 maggio 2018.
- (5) https://adventureprime.com/vang-vieng-vice-guide-nightlife-drugs-girls/#Drugs
- (6) https://www.saelaoproject.com/
- (7) http://www.eefalaos.org/
- (8) Human Development Report 2019, Inequalities in Human Development in the 21st Century – Lao People’s Democratic Republic, Capitolo 2 – Human Development Index (HDI) § 2.1 Lao People’s Democratic Republic’s HDI value and rank, pag. 3.
- (9) World Bank Group, Lao People’s Democratic Republic Systematic Country Diagnostic, Priorities for Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity – Capitolo 1, Country context, Box 1: MDG attainment and LDC graduation criteria, pag. 2, 9 marzo 2017.
- (10) ibidem, Executive summary, pag. I, 9 marzo 2017.
- (11) https://www.worldbank.org/en/country/lao/overview
- (12) https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_358225/lang–en/index.htm
- (13) International Labour Office (ILO), Improving the garment sector in Lao PDR: Compliance through inspection and dialogue – Independent final evaluation, giugno 2017.
- (14) Il corso del Mekong è stato diviso in due bacini: l’Alto e il Basso bacino che complessivamente occupano una regione di 795mila chilometri quadrati. L’Alto bacino è l’area del fiume che scorre solo in territorio cinese per 1.995 km in tre diverse regioni: Tibet, i Tre Fiumi e il Bacino di Lancang e occupa il 25% dell’intero bacino.
- (15) Jorge Soutullo, The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment, Capitolo 4 – Geographical relevance and natural resources of the Mekong River, European Parliament – Policy Department for External Relations, Novembre 2019, pag. 18.
- (16) La Mekong River Commission (Commissione sul fiume Mekong) è un organismo transnazionale che comprende i governi di Laos, Thailandia, Cambogia e Vietnam per coordinare e promuovere uno sviluppo sostenibile del Mekong.
- (17) Mekong River Commission, The Council Study, The Study on the Sustainable Management and Development of the Mekong River Basin, including Impacts of Mainstream Hydropower Projects, Capitolo 7-Main scenario impact assessment results, § Assessment tier 1: Sector-specific assessment, 26 dicembre 2017, pag. 21.
- (18) Secondo la stessa ricerca, in Thailandia lo sviluppo sarà di 28,7 nel 2020 e di 81,1 nel 2040; in Cambogia di 6,6 miliardi USD nel 2020 e di 12,0 nel 2040; in Vietnam di 16,0 miliardi USD nel 2020 e di 31,7 nel 2040.
- (19) Mekong River Commission, Integrated Water Resources Management-based – Basin Development Strategy 2016-2020 for the Lower Mekong Basin, Capitolo 2 – Development trends and long-termoutlook, §2.3 – Economic, social and environmental trends and outlook, pag. 30.
- (20) The Council Study, The Study on the Sustainable Management and Development of the Mekong River Basin, including Impacts of Mainstream Hydropower Projects, Capitolo 7 – Main scenario impact assessment results, § Cross-sector comparison, 26 dicembre 2017, pag. 25.

- (21) A causa delle dighe numerose tratte fluviali oggi non sono più coperte dai barconi.
- (22) Lao Department of Energy Policy and Planning Ministry of Energy and Mines, Lao PDR Energy Statistics 2018, ERIA Research Project Report 2018, Maggio 2018, Capitolo 2 – Energy Balance Table § Electricity, n. 19, Febbraio 2020, pag. 31.
- (23) The Council Study, The Study on the Sustainable Management and Development of the Mekong River Basin, including Impacts of Mainstream Hydropower Projects, Capitolo 7-Main scenario impact assessment results, § Assessment tier 1: Sector-specific assessment, 26 dicembre 2017, pag. 21.
- (24) Il 15% del riso prodotto nel mondo proviene dal bacino del basso Mekong.
- (25) The Council Study, The Study on the Sustainable Management and Development of the Mekong River Basin, including Impacts of Mainstream Hydropower Projects, Capitolo 7-Main scenario impact assessment results, § Assessment tier 1: Sector-specific assessment, 26 dicembre 2017, pag. 23.
- (26) Ibidem, pag. 22.
- (27) La diga di Don Sahong è costruita dalla malese MegaFirst in joint venture con il governo laotiano.
- (28) Pratch Rujivanarom, Special Report: Compensation talks begin for dam disaster victims, The Nation, 18 February 2019.
- (29) Vientiane Times, Investigators: Dam collapse not a «force majeure» event, 29 May 2019.
- (30) Le banche, tutte thailandesi, sono la Krung Thai Bank, l’Ayudhya Bank, la Thanachart Bank e la Export-Import Bank of Thailand.
- (31) https://laotiantimes.com/2018/09/13/laos-pm-thongloun-confirms-hydropower-generation-policy/
- (32) Lao News Agency, Laos Expects to Have100 Hydropower Plants by 2020, 6 Luglio 2017.
- (33) Lao Department of Energy Policy and Planning Ministry of Energy and Mines, Lao PDR Energy Outlook 2020, ERIA Research Project Report 2018 – Capitolo 1 – Introduction §1.2 Energy Supply – Demand Situation No 19, Febbraio 2020, pag. 3.
- (34) Songxay Sengdara, Govt. hydro developers pave way for safe dam management, Vientiane Times, 19 June 2019.
- (35) Lao Department of Energy Policy and Planning Ministry of Energy and Mines, Lao PDR Energy Statistics 2018, ERIA Research Project Report 2018, Capitolo 1 – Primary Energy Data § Coal, Maggio 2018, pag. 2.
- (36) ibidem, Capitolo 5 – Model Assumptions §5.3 Electricity Generation Technologies, No 19, Febbraio 2020, pag. 54.
- (37) United Nations Office on Drugs and Crime (Unodc), Synthetic Drugs in East and South-East Asia – Trends and Patterns od Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive Substances, § Regional trends: East and South-East Asia, Marzo 2019, pag. 3.

- (38) Central Committee for Drug Abuse Control (Myanmar) – CCDAC, Synthetic drug situation in Myanmar, rapporto al Global SMART Programme Regional Workshop, Chiang Rai, Thailandia, Agosto 2018.
- (39) Ibidem, Synthetic Drugs in East and South-East Asia – Trends and Patterns od Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive Substances, § Regional trends: East and South-East Asia, Marzo 2019, pag. 1.
- (40) Lao National Commission for Drugs Control and Supervision (Lcdc), Report of illicit drug seizures for 2018 and corresponding reports from previous years.
- (41) «Triangolo d’oro» è il nome in codice dato dalla Cia alla regione a cavallo tra Thailandia, Birmania (oggi Myanmar) e Laos dove era concentrata la coltivazione e la produzione di oppio.
- (42) Legacies of War, Unexploded Ordnance (UXO) in Laos: Background and Recommendation, pag. 1.
- (43) Phoukhieo Chanthasomboune, Direttore del National Regulatory Authority, CCM intersessional meetings (Clearance and Risk Reduction session), Ginevra, 7 aprile 2014.
- (44) Le bombe a grappolo, o CMR, erano lanciate per la loro capacità di penetrare tra il fogliame della giungla ed esplodere lanciando detriti in una vasta area colpendo il maggior numero possibile di nemici.
- (45) U.S. Department of State, To Walk the Earth in Safety, 17th Edition, 18 dicembre 2018.
- (46) I finanziamenti Usa sono principalmente diretti alle seguenti organizzazioni: Mines Advisory Group, HALO Trust, Norwegian People’s Aid, World Education, Health Leadership International, Spirit of Soccer, Geneva International Center for Humanitarian Demining, Janus Global Operations.
- (47) Casa Bianca, Remarks by President Obama to the People of Laos, 6 settembre 2016.
- (48) National Regulatory Authority for UXO/Mine Action in Lao PDR, Unexploded Ordnance Sector Annual Report 2018, 2018, Sector Achievements: The Numbers, pag. 7.
- (49) Landmine Action, Explosive remnants of war and mines other than anti-personnel mines, Global Survey 2003-2004, Marzo 2005, pag. 104.
- (50) National Regulatory Authority for UXO/Mine Action in Lao PDR, Unexploded Ordnance Sector Annual Report 2018, 2018, Sector Achievements: The Numbers, pag. 5.
- (51) National Regulatory Authority, Safe Path Forward – II, 22 giugno 2012.
- (52) National Regulatory Authority for UXO/Mine Action in Lao PDR, Unexploded Ordnance Sector Annual Report 2018, 2018, Sector Achievements: The Numbers, pag. 5.
- (53) Ibidem, pag. 14.

Ha firmato questo dossier:
PIERGIORGIO PESCALI
Ricercatore scientifico, il suo lavoro lo porta a viaggiare per il mondo collaborando come giornalista con radio, riviste, quotidiani in Europa e in Asia. Sudest asiatico, penisola coreana e Giappone sono le zone che segue con più interesse. È uno dei maggiori conoscitori della Corea del Nord che frequenta con regolarità dal 1996. Sul paese ha recentemente pubblicato La nuova Corea del Nord, come Kim Jong Un sta cambiando il paese (Castelvecchi, 2019). Ha inoltre scritto: Indocina (Emil, 2010), Il custode di Terrasanta. A colloquio con Pierbattista Pizzaballa (Add, 2014), S-21, nella prigione di Pol Pot (La Ponga, 2015). Da anni è fedele collaboratore di MC.
A cura di Paolo Moiola, giornalista redazione MC.