Bangladesh. La sceicca si conferma al potere
Lo scorso 7 gennaio si sono svolte in Bangladesh le prime elezioni del 2024. Nessuna sorpresa dalle urne: ha stravinto l’«Awami League» (222 seggi parlamentari su 300), il partito della premier Sheikh Hasina Wazed, giunta al quinto mandato, il quarto consecutivo. Una vittoria scontata anche perché ottenuta dopo che il «Bangladesh nationalist party» (Bnp, guidato da un’altra donna, Khaleda Zia), il principale partito d’opposizione, si era ritirato dalla competizione elettorale, giudicandola – con molte ragioni – gravemente viziata.
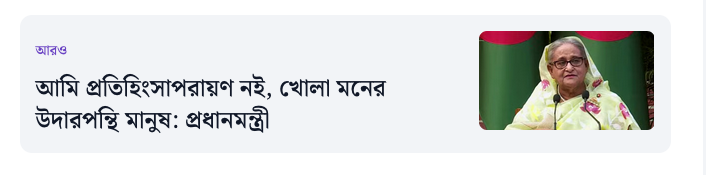
La leader Sheikh Hasina, 76 anni, viene da lontano. Nel 1971, suo padre, Sheikh Mujibur Rahman, era stato l’artefice della separazione del paese (già Pakistan orientale o Bengala orientale) dal Pakistan, dopo una guerra con almeno 3 milioni di morti.
Nel corso degli ultimi 15 anni il potere della premier e del suo partito si è però trasformato in autoritarismo. Molti membri dell’opposizione sono stati arrestati o processati, e la libertà di parola è stata soffocata.
Altri due fatti di rilievo hanno caratterizzato i governi di Hasina: l’accoglienza di quasi un milione di profughi di etnia rohingya, popolazione islamica perseguitata nel confinante Myanmar; i pessimi rapporti con l’economista Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace 2006, fondatore della Grameen Bank, probabilmente il più noto bangladese al mondo.
Anche alle ultime elezioni non sono mancate le violenze. Il 9 gennaio The Daily Star, il principale quotidiano in lingua inglese del Paese, riportava due notizie contrapposte, molto significative: da una parte la reazione degli Stati Uniti che hanno giudicato le elezioni non libere e non giuste, dall’altra quella della Cina che si è congratulata con i vincitori per il successo elettorale.
Il Bangladesh conta oltre 171 milioni di abitanti, al 90 per cento di religione islamica (e un 9 per cento di induisti). Con i suoi 1.315,1 abitanti per chilometro quadrato, possiede una delle più alte densità demografiche al mondo. Nonostante l’impetuosa crescita economica degli ultimi anni (più 6-7 per cento all’anno, incremento dovuto soprattutto all’industria dell’abbigliamento), il Paese rimane una nazione povera, diseguale e con un alto tasso di emigrazione. Vivono all’estero 7,5 milioni di bangladesi. In Italia, ce ne sono oltre 150mila (secondo i dati ministeriali), formando la più numerosa comunità del Paese asiatico in Europa.
Dalle elezioni in Bangladesh si possono trarre alcune lezioni di carattere generale: l’autoritarismo e e la trasformazione dei governi in principati (nel senso descritto da Machiavelli) sono tendenze mondiali sempre più diffuse; la contrapposizione tra i paesi a democrazia occidentale e gli altri è destinata ad acuirsi sotto la spinta di Cina e Russia; non basta essere donna per rendere la politica migliore.
Paolo Moiola