Dopo il disastro dell’11 marzo 2011: l’incubo durerà a lungo. Si dice che la bonifica durerà 40 anni. Intanto, nella centrale devastata dallo tsunami del marzo 2011, gli allarmi continuano. Acqua radioattiva è arrivata fino in Califoia. Nonostante gli evidenti problemi, il premier Abe ha confermato la scelta nucleare del paese. E l’ottimismo viene alimentato anche con l’assegnazione al Giappone delle Olimpiadi del 2020. A Fukushima abbiamo camminato tra le rovine e parlato con i sopravvissuti. Queste sono le loro storie.
.JPG)
Il semaforo giallo continua a lampeggiare ritmicamente. Incessantemente. È l’unico segnale di presenza umana rimasto nella cittadina di Futaba, meno di tre chilometri in linea d’aria dalla centrale di Fukushima Daiichi, l’impianto nucleare colpito dallo tsunami del marzo 2011 e da cui continuano a fuoriuscire notevoli quantità di isotopi radioattivi. La statale numero 6, l’importante arteria stradale che segue la costa verso nord, è improvvisamente interrotta: un cartello spiega che oltre è impossibile proseguire, ma non ne indica il motivo, del resto troppo facile da intuire. La ferrovia è completamente avvolta nella fiorente vegetazione.
Parcheggio l’auto lungo quella che era la via principale del nucleo abitato: il silenzio penetra fin dentro le ossa. Improvvisamente un grugnito: dietro me un maiale, a una decina di metri di distanza, mi scruta immobile e titubante prima di riprendere la sua strada e immergersi nel giardino incolto di una casa privata. A Minamisoma, l’ultima città prima di entrare nella zona proibita, mi avevano avvertito della presenza di animali domestici inselvatichiti: maiali, cani, gatti, mucche che si aggirano indisturbati tra i campi abbandonati alimentandosi di prodotti di un suolo dove il Cesio 137 è decine di volte superiore alla norma. Animali destinati a morire nel giro di qualche anno, uccisi da invisibili atomi che rilasciano particelle ad alta energia danneggiando il loro Dna.
Poco più avanti, a Tomioka, i segni dello tsunami sono ancora evidenti: la stazione del treno è distrutta e l’intero paese, anch’esso disabitato, è devastato. Qui il tempo si è fermato a quell’11 marzo del 2011. Nel piccolo ristorante di fronte al porticciolo i piatti sono impilati uno sull’altro in attesa di clienti che ormai non arriveranno più, mentre nelle case sventrate si intravedono giocattoli, quadri, giornali. Un calendario magnetico ha ancora il cerchietto centrato sulla casella dell’11 marzo. Da allora nessuno lo aggiorna, così come nessuno fa ripartire le lancette di un orologio fermo all’ora del disastro. Tutto intorno, per chilometri e chilometri, case distrutte, elettrodomestici accatastati, carcasse di auto, negozi sbarrati da fogli di compensato.

Della «Tepco», ovvero del crollo del mito giapponese.
Se Chernobyl è stata una sciagura, Fukushima continua a essere un cataclisma. Gli incidenti nella centrale giapponese non sono mai cessati e la popolazione si è sentita ingannata da una compagnia elettrica – la Tepco, gestore dell’impianto – inetta e pasticciona appoggiata da un governo bugiardo e infingardo. A tutto questo si aggiunga anche l’incompetenza dei tecnici, e ci troviamo di fronte a un quadro assolutamente desolante e raccapricciante.
Per evitare la bancarotta, Tokyo ha deciso di nazionalizzare, almeno in parte, la Tepco: 22 miliardi di euro che andranno ad aggiungersi ai 190 miliardi di euro (rispetto ai 75 preventivati solo qualche mese fa) necessari per la bonifica dell’area che, secondo l’ultimo rapporto della Commissione per la Sicurezza Nucleare giapponese durerà all’incirca quarant’anni. Nonostante la centrale di Fukushima sia divenuta una divoratrice di denaro pubblico, i problemi che continuano a nascere uno dopo l’altro senza interruzione pongono una seria incognita sul futuro dell’intera regione e sulla sorte dei suoi abitanti.
Lo sversamento in mare di centinaia di tonnellate d’acqua radioattiva utilizzata per il raffreddamento dei reattori fusi è solo l’ultimo di una impressionante catena di incidenti causati, per la maggior parte, dall’imperizia e dalla superficialità con cui la Tepco e il governo hanno affrontato l’incidente. Ora si è aggiunta la paura del cedimento della struttura che ingloba il reattore numero 4, sprofondata per una ventina di centimetri nel terreno reso fradicio dalle perdite di acqua.
La situazione rischia di non essere più controllabile, come dimostra la continua oscillazione delle misure di radioattività che vengono continuamente monitorate nei vari punti della prefettura di Fukushima.
Il passaggio di consegne dello scettro di primo ministro da Yoshihiko Noda, esponente del Partito Democratico (Pd) a Shinzo Abe, del Partito Liberaldemocratico (Pld), avvenuto il 26 dicembre 2012, ha ulteriormente ingarbugliato la matassa politica ribaltando, per l’ennesima volta, l’agenda energetica del paese. Dopo lo tsunami del 2011, infatti, i democratici, allora al governo, avevano deciso di varare un programma che azzerasse, entro il 2040, la produzione di energia nucleare nell’arcipelago dando il via alla nascita di una serie di proposte per l’utilizzo di fonti energetiche alternative a quelle tradizionali. Il più prolifico e concreto tra gli scienziati è Tetsunari Iida, fondatore e direttore dell’Isep (Institute for Sustainable Energy Policies): «Il nostro obiettivo è quello di creare una società che possa essere alimentata per il 100% da energie rinnovabili» afferma il ricercatore con un passato da ingegnere nucleare alle spalle. L’idea, per raggiungere tale traguardo, è esattamente l’opposto di quello che è accaduto in Italia fino a qualche anno fa: anziché tappezzare vaste superfici di terreno con pannelli solari sottraendole alla produzione agricola o di creare megacentrali idroelettriche costruendo dighe ed enormi bacini artificiali, Iida, e con lui molti altri ricercatori giapponesi, propongono piccoli impianti a livello domestico e comunale. «In questo modo l’impatto ambientale sarebbe minimo e competerebbe alla stessa comunità provvedere al suo mantenimento, abbattendo i costi di gestione». Secondo uno studio del ministero dell’Ambiente giapponese, l’introduzione di piccole e medie centrali idroelettriche, l’energia eolica (da potenziarsi principalmente lungo le coste del Tohoku e di Hokkaido), l’energia geotermica potrebbero fornire un contributo energetico importante. Secondo un rapporto del Wwf, il divario tra energia prodotta e energia consumata potrebbe essere colmato entro il 2050 affiancando un aumento dell’efficienza e del risparmio energetico alle fonti rinnovabili (oggi solo il 3,79% dell’energia totale consumata in Giappone proviene da queste ultime).
.JPG)
Le certezze di Shinzo Abe
Di diverso avviso è, invece, l’attuale primo ministro Shinzo Abe il quale, dopo essere salito al governo ha confermato l’opzione nucleare adducendo come giustificazione il fatto che la tecnologia delle energie rinnovabili, con la loro stretta dipendenza dagli eventi naturali, non è ancora pronta a sostituire la continuità produttiva che garantisce la fissione dell’atomo.
Così, dopo anni di sospensione, è ripresa la costruzione di due nuove centrali: quella di Ohma-1, nella provincia settentrionale di Aomori, e Shimane-3, sulla costa meridionale del Mar del Giappone.
A Wakinosawa, nella penisola di Shimokita, Takayuki Isoyama oltre a gestire un ostello è anche membro della Commissione ambientale della Riserva naturale della regione. A lui chiedo se, dopo Fukushima, si sono levate voci contro il completamento della centrale di Ohma-1: «Ben poche» è la sua risposta; «La costruzione della centrale offre opportunità di lavoro a migliaia di locali e, visto che questa è una delle regioni più povere del Giappone, le opzioni sono due: o si emigra o si sfruttano le possibilità che si vengono a creare».
Questa scelta obbligata è uno dei principali motivi per cui il movimento antinucleare trova ostilità anche tra gli stessi abitanti della provincia di Fukushima. Nelle ultime elezioni, tenutesi nel luglio 2013, il Partito Liberaldemocratico ha ottenuto più del doppio dei voti del Partito Democratico. «Merito dei posti di lavoro che l’incidente della centrale ha creato» spiega Sachiko Goto, un membro del movimento antinucleare che, assieme alla sua famiglia, gestisce una tenuta agricola proprio alla periferia della città di Fukushima, ad una cinquantina di chilometri dalla centrale atomica. Ma non è solo questa la motivazione: un impiegato della prefettura (l’equivalente della nostra provincia), che si occupa di misurare la radioattività nel terreno, aggiunge che la vera ragione per cui le ue hanno decretato il trionfo del Pld «non è un premio alla sua politica pro-nucleare, ma un modo per spronare il premier, Shinzo Abe, a varare piani di recupero e di salvaguardia per far rientrare la situazione di emergenza creatasi dopo lo tsunami del 2011». Abe, infatti, ha sempre imputato la scarsa incisività del governo per risolvere la questione di Fukushima, alla divisione del parlamento giapponese. La camera bassa, a maggioranza liberaldemocratica, avrebbe varato leggi e decreti che sarebbero poi stati ostacolati nella loro attuazione dalla camera alta, in mano democratica. Tutti, in realtà, sanno che la vera spiegazione dell’indecisione politica è da ricercarsi nella divisione interna del Pld e nelle sue correnti, che fanno a gara per favorire questa o quella parte industriale nell’accaparramento dei lucrosi appalti. «Ora, però, che il Pld ha la maggioranza assoluta in entrambe le camere, Abe non ha più scuse» conclude l’impiegato prefettizio.
Gli interessi sono enormi, non solo a livello locale, ma anche su scala nazionale e internazionale, visto che la Abeconomy deve passare necessariamente dallo sviluppo nucleare per poter decollare.
Il Giappone ha già concluso contratti miliardari per foiture di impianti e macchinari atomici con Turchia (17 miliardi di euro) ed Emirati Arabi, mentre sta siglando accordi con India, Brasile, Arabia Saudita, Vietnam per un totale di 200 miliardi di euro.
La stessa Keidanren, l’equivalente giapponese della Confindustria, si è apertamente schierata a favore del nucleare, bollando di irresponsabilità la proposta di chiusura definitiva delle centrali atomiche lanciata dall’Enecan, l’Energy & Environment Council giapponese recentemente sciolta dal governo. Gli stessi principali conglomerati nipponici sono pesantemente coinvolti nell’industria della fissione nucleare: la Mitsubishi e l’Hitachi hanno partecipazioni nell’Areva e nella General Electric, mentre la Westinghouse è stata assorbita dalla Toshiba.
Per dimostrare che Fukushima è stato un incidente isolato, i centri di pubbliche relazioni delle centrali nucleari più esposte a eventuali tsunami, hanno aggiunto nuovi pannelli che illustrano le misure di sicurezza intraprese per fronteggiare eventi simili a quelli accaduti nel marzo 2011. Con l’assegnazione delle Olimpiadi 2020 a Tokyo, anche la comunità internazionale ha voluto dare fiducia agli sforzi che si stanno conducendo per tamponare la critica situazione che si è venuta a creare in Giappone.
Nella sua tragedia umana e ambientale, l’incidente di Fukushima ha, però, avuto il merito da una parte di sollevare il problema della sicurezza e dall’altra di rinvigorire lo stremato movimento antinucleare dell’arcipelago.
Così, le stesse industrie impegnate nel nucleare come Mitsubishi e Toshiba, oggi stanno guardando con maggior interesse alle energie rinnovabili. Con un giro di affari che si aggira, nel 2013, sui 20 miliardi di euro, l’industria dell’energia «verde» è appena agli inizi ed è ancora poco competitiva, in fatto di prezzi e di tecnologie, rispetto alle fonti tradizionali, ma la ricerca sta continuamente implementando nuove soluzioni più redditizie.
È comunque la stessa Enecan (quella tacciata di irresponsabilità dalla Keidanren) ad aver indicato che l’attuale costo per kWh dell’energia nucleare in Giappone è di 8,9 yen (0,068 centesimi di euro; in questo conteggio sono compresi i costi di gestione per il rafforzamento della sicurezza), contro i 23-58 yen/kWh (0,176-0,441 Euro) delle energie rinnovabili, a seconda del tipo di energia utilizzata e della potenza dell’impianto.
Stili di vita insostenibili
«Se vogliamo dare un futuro ai nostri figli, dobbiamo deciderci ad abbandonare l’atomo» mi dice Iwasa Miko, accesa sostenitrice del movimento antinucleare che vive ad Hippo, nella prefettura di Miyagi.
Il problema è che, per riuscire a raggiungere l’obiettivo proposto dalle associazioni ambientaliste, non basta aumentare decisamente la produzione di energia «verde»; occorre convincere milioni di giapponesi a modificare radicalmente il loro stile di vita.
Le case, ad esempio, sono un insulto al risparmio energetico: caldissime d’estate e gelide d’inverno, sono estremamente energivore. Solo in questi ultimi anni si è cominciato a costruire appartamenti secondo criteri più consoni all’economia del risparmio. Gli stessi giapponesi hanno scoperto da poco che esiste, nel loro vocabolario, la parola setsuden, «risparmio di energia», ma ci vorrà del tempo per educare un’intera fetta di popolazione a rispettare anche le più elementari regole dell’avvedutezza.
E se, nella prefettura di Tokyo, rispetto agli anni precedenti, ho riscontrato un uso più oculato dell’aria condizionata nei luoghi pubblici, al di fuori delle cinture metropolitane si continuano ad utilizzare condizionatori a temperature inaccettabilmente basse.
«È possibile che il Giappone passi a energie alternative al nucleare, ma tutti dobbiamo impegnarci a raggiungere questo traguardo» mi dice Sachiko Goto.
Lei, assieme ad altri contadini, ha subito le conseguenze del fallout radioattivo perdendo circa il 20% dei suoi clienti: «Tra gli agricoltori della nostra zona siamo stati fortunati. La maggior parte ha subito contrazioni anche del 40%. Noi ci siamo salvati grazie alla scelta di vendere direttamente ai privati, senza passare attraverso cooperative o grandi catene alimentari».
La prospettiva di Sachiko è stata profetica, così come profetica (purtroppo) è stata la sua campagna antinucleare, pressoché solitaria, iniziata all’indomani dell’incidente di Cheobyl.
.JPG)
.JPG)
Problemi e paure di chi è rimasto
Oggi le aziende agricole, per dimostrare che i loro prodotti non contengono isotopi radioattivi, controllano i raccolti con un contatore Geiger. «È un lavoro lungo e faticoso, oltreché costoso, ma, anche se nessuna legge ci obbliga a farlo, preferiamo effettuare le analisi per una questione di sicurezza sociale» afferma Shigeki Oota, marito della già citata Iwasa Miko. Una ventina d’anni fa hanno lasciato Tokyo per trasferirsi tra le montagne di Hippo. Qui hanno iniziato a produrre miso, la salsa usata sulle tavole giapponesi per insaporire la verdura. A differenza degli agricoltori della prefettura di Fukushima, Shigeki e Miko, che vivono nella contigua prefettura di Miyagi, non hanno diritto ad alcun rimborso per le perdite subite a causa del fallout. Le strette vallate e le coltivazioni che si arrampicano sulle pendici dei monti, rendono la vita particolarmente difficile e dura, ma la famiglia Oota, assieme ai loro quattro figli, non si lamenta. «Molti se ne sono andati dopo l’incidente alla centrale nucleare» spiega Miko. «Noi, dopo qualche settimana di trasferimento a Tokyo aspettando che i livelli di radioattività si abbassassero, abbiamo preferito tornare». Una scelta coraggiosa, oltreché difficile, e non solo per l’asprezza della vita. L’impegno antinucleare di Shigeki e Miko non è stato accolto benevolmente dalla comunità montana: «Esiste sempre il timore che prendere precauzioni per controllare i livelli di radioattività, significhi ammettere che si ha un problema di inquinamento atomico, allontanando ancora più i consumatori e incancrenendo la crisi».
Naturalmente non è così, ma il costante martellamento dei media abbinato agli allarmi, molte volte scientificamente infondati, lanciati da alcune associazioni ambientaliste e antinucleari dell’ultima ora, non fanno altro che alzare il livello di guardia dell’opinione pubblica, aggravando le tensioni sociali. Così, la popolazione di Hippo si è divisa tra chi voleva monitorare costantemente il territorio e chi, invece, avrebbe preferito non intervenire. Alla fine molti abitanti antinucleari (per lo più famiglie di recente immigrazione provenienti dalla città), si sono arresi e hanno deciso di trasferirsi. Shigeki e Miko, invece, hanno continuato a combattere per le loro idee trovando, alla fine, un felice compromesso: «Tutti hanno capito che controllare il territorio e i suoi prodotti avrebbe confortato non solo i consumatori, ma gli abitanti stessi».
Meno conflittuale, ma altrettanto drammatica, è stata la vicenda di un altro piccolo produttore locale: Yasuhiko Niida, presidente della Kinpou, una ditta che, dal 1711 produce sake secondo il metodo tradizionale utilizzando solo riso coltivato biologicamente. La nube radioattiva è arrivata anche qui, nella regione di Koriyama, ad una sessantina di chilometri di distanza dalla centrale. «A causa della radioattività il fatturato è crollato del 30%» dichiara Yasuhido. Ma per la famiglia Niida, oltre al danno si è aggiunta anche la beffa: «Nel 2011 la Kinpou avrebbe compiuto trecento anni di vita ed eravamo tutti pronti a festeggiare il traguardo con un anno di eventi già organizzati. Invece ci siamo trovati a lottare per la sopravvivenza dell’azienda».
L’attaccamento alla tradizione famigliare abbinato al carattere tenace di Yasuhido, ha permesso alla ditta di superare il periodo più buio della sua lunga storia e a guardare, oggi, a un futuro più roseo: «Pur tra mille difficoltà siamo riusciti a non licenziare nessuno dei nostri venti dipendenti». Il segreto di tanta costanza sta nell’alta qualità dei prodotti: nel minuscolo ufficio condiviso con i suoi collaboratori più stretti, Yasuhido mostra orgoglioso la lista dei premi nazionali assegnati alla sua azienda. Mentre degustiamo il suo sake mi confida il suo ultimo sogno: «Convincere, entro il 2025, quando varcherò la soglia dei sessant’anni, tutti i contadini del villaggio in cui sorge la fabbrica a coltivare esclusivamente riso biologico». Un desiderio, questo, che manifesta la volontà di riscatto lasciandosi il passato alle spalle.
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
Quel che resta del mare
Non per tutti, però, è possibile dimenticare ciò che è successo quel terribile 11 marzo 2011. A Ishinomaki, un grosso centro peschereccio a nord della centrale di Fukushima, i pescatori continuano a lottare contro la radioattività. Questa volta proveniente dal mare.
Nonostante la ricostruzione abbia rinnovato la cittadina, le rovine ancora presenti lungo la costa continuano a ricordare agli abitanti che l’oceano è sempre lì, pronto a dare la vita, ma anche a riprendersela.
Prima del 2011 Ishinomaki era il principale punto di rifornimento di prodotti marini di Tokyo. Le perdite nelle acque costiere di sostanze radioattive dalla vicina centrale di Fukushima, hanno convinto gli acquirenti della capitale a rifoirsi più a nord, ad Hokkaido, mettendo in ginocchio l’intera industria ittica della regione. Alle cinque di mattina vado a osservare i primi pescherecci che scaricano il pescato sulle banchine del porto. Alle sei i compratori cominciano ad arrivare: sono tutti locali che riforniscono ristoranti o piccoli centri commerciali della zona. Nessuno di loro manderà i prodotti acquistati a Tokyo. «Una volta che il mercato ha segnato le proprie rotte commerciali, è pressoché impossibile cambiarle» spiega un ricercatore dell’Università di Tokyo che al problema di Ishinomaki ha dedicato uno studio approfondito. Ma forse il luogo che più di tutti rappresenta il dramma che stanno vivendo i giapponesi attorno alla centrale nucleare, è Iitate. Nonostante il paesino non sia stato colpito né dal terremoto né tantomeno dallo tsunami trovandosi ad una sessantina di chilometri dalla costa, nessuno dei suoi duemila abitanti è rimasto a risiedervi. I venti che soffiano dal mare continuano a trasportare atomi di Cesio 137 e Stronzio 90, assieme a finissime particelle di Uranio liberatisi dai tre reattori fusi, che si depositano sul terreno. Le montagne che delimitano le splendide vallate di questa regione sono state una delle cause della sua rovina, incanalando le correnti provenienti direttamente dalla centrale nucleare. Così, mentre attraverso le strade di Iitate, non vedo altro che desolazione ed abbandono: case chiuse, negozi vuoti, pali della luce arrugginiti, cartelloni pubblicitari avvolti nella vegetazione. E al posto delle mandrie di mucche la cui carne era famosa in tutto il Giappone, oggi vedo solo ruspe che scavano il suolo sino a venti centimetri di profondità nella speranza di estirpare la radioattività.
Tutta la terra dragata viene poi raccolta in grossi sacchi neri numerati e stoccata in appositi siti in attesa di trovare un modo sicuro per decontaminarla.
Questo immane lavoro dovrà essere fatto su tutta la superficie colpita dal fallout, vale a dire una striscia di territorio lunga una cinquantina di chilometri e larga dai cinque ai venti. È la lingua lungo la quale gli elementi che fuoriescono dalla centrale si disperdono nell’aria prima di depositarsi a terra. Migliaia di metri cubi di suolo sono già stati raschiati, ma è solo una piccolissima parte di ciò che si deve ancora completare.
Per snellire il lavoro ed evitare di saturare i centri di raccolta, nelle zone meno colpite ci si è limitati a sotterrare il terreno radioattivo coprendolo con suolo incontaminato. Nessuno, però, è in grado di promettere che l’emergenza sia terminata: il Cesio 137 potrebbe trovare il modo di giungere in superficie o, viceversa, penetrare più profondamente trasportato dalle piogge sino ad incontrare falde acquifere inquinandole.
Lontani da Fukushima
Al termine del mio viaggio visito uno dei tanti centri temporanei in cui sono stati smistati circa centocinquantamila abitanti della zona evacuata. Le abitazioni sono state ricavate in container ed ogni famiglia ha diritto ad una o due camere da letto, un minuscolo bagno, una cucina. La difficoltà maggiore è rappresentata dalla totale mancanza di privacy: gli «appartamenti» sono separati da sottili pareti da cui trapela tutto, e la convivenza diviene molto difficile, specialmente per coloro erano abituati a vivere in grandi case coloniche separate le une dalle altre da distese di campi.
Così, per mitigare la disperazione, molti contadini, appena possono, durante il giorno ritornano nelle loro dimore con la scusa di dover accudire al giardino o di prendere qualche vestito.
Per aiutarli il Centro di Volontari per la Ricostruzione di Minamisoma, in collaborazione con la Caritas locale, organizza giornalmente alcuni campi lavoro. Partecipo a uno di questi: ripulire dalle sterpaglie il giardino di una casa appartenente a un vecchio contadino. Un lavoro «a perdita», nel senso che tutti i partecipanti sanno che la zona non sarà abitabile per anni (se non per decenni), ma «oltre all’aspetto pratico dobbiamo valutare quello psicologico», chiarisce il coordinatore del gruppo. «Il solo fatto di sapere che c’è gente che ti aiuta, che non sei solo a lottare, infonde quella speranza di cui molti hanno estrema necessità per poter continuare a vivere».
La speranza che molti giovani hanno già perduto, abbandonando una terra ormai sterile e cercando di rifarsi una vita. Lontani da Fukushima.
Gli Eventi
- 11 marzo 2011, ore 14.46: un forte terremoto fa tremare la terra della provincia del Tohoku, nel Nord del Giappone. Con l’interruzione di energia elettrica, i generatori di emergenza della centrale nucleare di Fukushima entrano in funzione.
- Ore 15.27: arriva la prima onda dello tsunami causando lo spegnimento della pompa di raffreddamento del reattore numero 1.
- Ore 15.46: la situazione si aggrava con l’arrivo della seconda onda, la cui altezza (circa 14 metri) supera il muro di sbarramento a difesa della centrale, costruito per fronteggiare tsunami di massimo 10 metri.
- Ore 19.30: i sistemi di raffreddamento si sono interrotti e il combustibile del reattore numero 1, senza liquido di raffreddamento, inizia a fondere.
- Ore 21.00: la situazione è compromessa, tanto da indurre il governo a dare l’ordine di evacuazione di tutti coloro che vivono entro un raggio di 3 km dalla centrale.
- 12 marzo 2011, ore 04.15: le barre di combustibile del reattore numero 3 iniziano a fondere.
- 12 marzo 2011, ore 21.00: l’ordine di evacuazione viene esteso a 20 chilometri dalla centrale.
- 14 marzo: è la volta del reattore numero 2 (la Tepco ammetterà soltanto nel maggio 2011 la fusione dei reattori).
- settembre 2013: i problemi continuano. Acque radioattive vengono riscontrate dall’altra parte dell’oceano, in California.
PER APPROFONDIRE
• Nicola Armaroli – Vincenzo Balzani, Energia per l’astronave Terra, Zanichelli, Bologna 2011 (il saggio ha vinto il Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica).
• Mirco Elena, Cheobyl e il Trentino. La paura atomica nel piatto, Trento 2007 (l’ultimo capitolo è dedicato a come i media dell’epoca trattarono l’evento, sottolineando anche errori e imprecisioni). Per eventuali richieste: elena@science.unitn.it.
GLI AUTORI
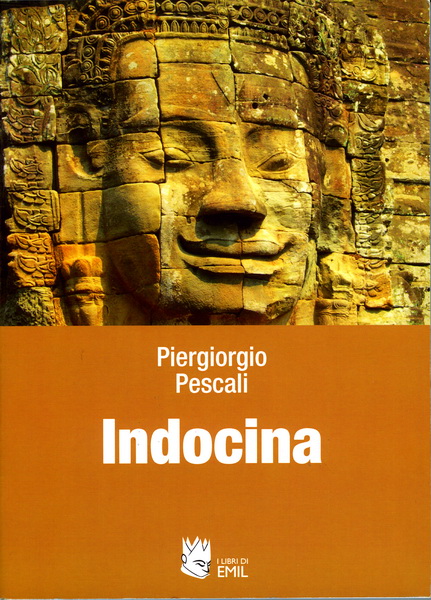 • Piergiorgio Pescali – Gioalista e scrittore, si occupa di Estremo Oriente, in particolare di Sud Est Asiatico, penisola coreana e Giappone. Suoi articoli e foto sono stati pubblicati da Bbc, Cnn, Avvenire, Il Manifesto, Panorama e riviste specializzate. Dal 2010, cura per Asia Maior (www.asiamaior.org) il capitolo sul Myanmar. Ha scritto il saggio Indocina, Edizioni Emil, Bologna 2010.
• Piergiorgio Pescali – Gioalista e scrittore, si occupa di Estremo Oriente, in particolare di Sud Est Asiatico, penisola coreana e Giappone. Suoi articoli e foto sono stati pubblicati da Bbc, Cnn, Avvenire, Il Manifesto, Panorama e riviste specializzate. Dal 2010, cura per Asia Maior (www.asiamaior.org) il capitolo sul Myanmar. Ha scritto il saggio Indocina, Edizioni Emil, Bologna 2010.
Il suo blog: www.pescali.blogspot.com.
• Mirco Elena – Fisico e ricercatore trentino, lavora da anni come divulgatore scientifico. Si occupa in particolare di pace e disarmo, di rapporti tra scienza e società e di energia nucleare.
• Tiziano Tosolini – Missionario saveriano. Vive a Osaka, in Giappone, e dirige il Centro Studi Asiatico. Oltre che di cultura e religioni (si veda il suo Inteo giapponese. Tracce di un dialogo tra Oriente e Occidente, Emi, Bologna 2009), si occupa anche di filosofia giapponese (Scuola di Kyoto), e ha ultimamente tradotto il
volume di Tanabe Hajime, Il nulla e la croce. Due saggi filosofici su Buddhismo e Cristianesimo, Mimesis editore, Milano 2013.
• Paolo Moiola – Redattore MC, per il coordinamento giornalistico del dossier.
Piergiorgio Pescali





.JPG)

.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
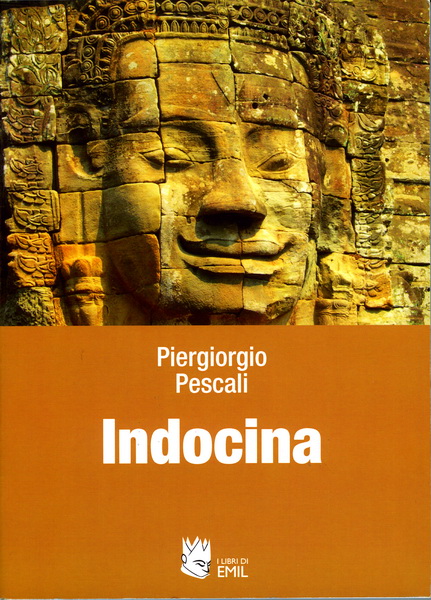 • Piergiorgio Pescali – Gioalista e scrittore, si occupa di Estremo Oriente, in particolare di Sud Est Asiatico, penisola coreana e Giappone. Suoi articoli e foto sono stati pubblicati da Bbc, Cnn, Avvenire, Il Manifesto, Panorama e riviste specializzate. Dal 2010, cura per Asia Maior (www.asiamaior.org) il capitolo sul Myanmar. Ha scritto il saggio Indocina, Edizioni Emil, Bologna 2010.
• Piergiorgio Pescali – Gioalista e scrittore, si occupa di Estremo Oriente, in particolare di Sud Est Asiatico, penisola coreana e Giappone. Suoi articoli e foto sono stati pubblicati da Bbc, Cnn, Avvenire, Il Manifesto, Panorama e riviste specializzate. Dal 2010, cura per Asia Maior (www.asiamaior.org) il capitolo sul Myanmar. Ha scritto il saggio Indocina, Edizioni Emil, Bologna 2010.