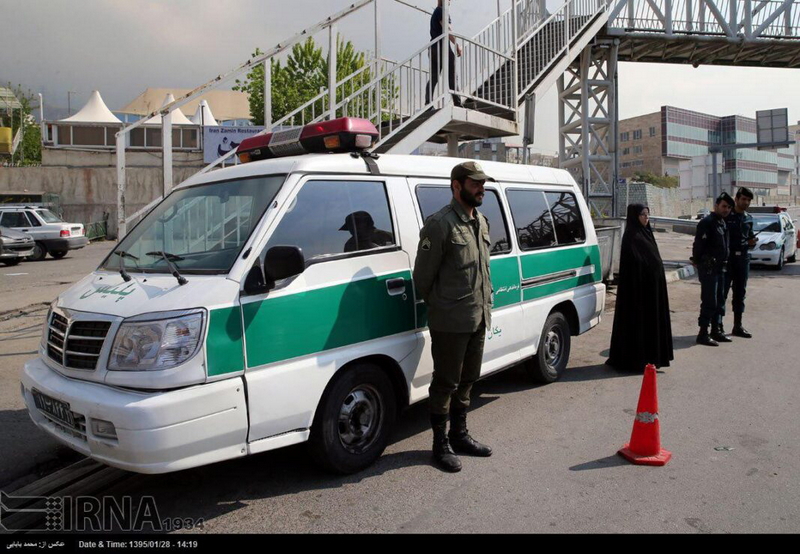Donne. Perseguitate due volte
Le donne delle minoranze religiose sono la fascia più colpita dalle persecuzioni. La maggior parte sono cristiane, ma non mancano altri casi, come quello delle musulmane rohingya o delle yazide. Rapite, convertite forzosamente, picchiate, violentate, tenute segregate.
Rapite, violentate, schiavizzate. Le donne delle minoranze religiose sono spesso perseguitate due volte: innanzitutto perché appartenenti a gruppi tenuti ai margini della società, poi perché, appunto, donne.
Accade in Pakistan, Nigeria, Burkina Faso, Egitto, solo per fare qualche esempio, e per la gran parte si tratta di donne cristiane.
Non mancano, però, casi che riguardano altri gruppi religiosi.
In Myanmar, per esempio, Paese a maggioranza buddhista nel quale da anni viene perseguitata la minoranza musulmana dei Rohingya, una donna non può sposare un musulmano se non a rischio della vita.
Qualche anno fa a Pegu, una delle più grandi città del Paese, una folla impazzita incendiò l’intero quartiere di una ragazza buddhista per punirla della sua relazione con un musulmano.
Stesso destino di discriminazione spetta alle donne rohingya. «Nascere donna ed essere di origine rohingya significa, molto probabilmente, essere destinata a una vita fatta di privazioni e discriminazioni di natura etnica, religiosa e sessuale», sottolinea Amnesty international.

Cristiane, le più perseguitate
Tornando alle donne cristiane che vivono in paesi nei quali la loro fede è in minoranza, come in molte zone dell’Asia, del Medio Oriente o dell’Africa, esse «sono le prime vittime», afferma la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) in un rapporto di novembre 2022: «Se credere in Gesù Cristo implica seri rischi in molte parti del mondo, essere una donna cristiana è ancora più difficile. In molti paesi in cui vige la persecuzione religiosa, la violenza contro le donne è spesso usata come arma di discriminazione».
Sulla stessa linea sono i dati emersi nella ricerca The 2023 gender report presentata, in occasione della giornata internazionale della donna dell’8 marzo 2023, da Porte Aperte/Open Doors, organizzazione internazionale che sostiene i cristiani perseguitati e che aggiorna ogni anno, con la sua World watch list, la classifica dei paesi dove si registrano le maggiori persecuzioni a causa della fede.
«Per le donne – sottolinea il rapporto – la violenza sessuale e fisica, il matrimonio forzato e la riduzione in schiavitù, uniti alle minacce e al controllo dei cellulari, sono elementi che le intrappolano in una ragnatela soffocante».
Il report presenta anche la classifica dei paesi nei quali le donne sono perseguitate sia per la loro fede che per il loro genere.
Al primo posto troviamo la Nigeria. A seguire Camerun, Somalia, Sudan, Siria, Etiopia, Niger, India, Pakistan e Mali.
Nelle regioni settentrionali della Nigeria, dove i cristiani subiscono i livelli più alti di violenza, le donne cristiane sono vittime di rapimenti, spostamenti forzati, traffico di esseri umani, uccisioni e violenza sessuale.
La punta di un iceberg
I casi di donne rapite, violentate, convertite forzosamente, uccise che emergono nelle cronache sono solo la punta di un iceberg. Spesso, infatti, le famiglie, per paura o per vergogna, non denunciano i crimini subiti.
È quanto emerge dalla ricerca Ascolta le sue grida, pubblicata da Acs Italia nel 2021, nella quale si evidenzia che, tra i membri delle minoranze religiose, le ragazze e le giovani donne cristiane sono le più esposte agli attacchi.
Secondo l’Associazione cristiana della Nigeria, per esempio, il 90 per cento delle donne e delle ragazze detenute dagli islamisti è di fede cristiana. In Pakistan, il Movimento per la solidarietà e la pace ha stimato che le cristiane costituivano, già dal 2014, fino al 70 per cento delle ragazze e delle giovani di minoranze religiose che ogni anno erano costrette a convertirsi e a contrarre matrimonio.
Ma le denunce non corrispondono mai alla reale entità del fenomeno.
Un altro dato chiave, che emerge frequentemente nelle ricerche sull’argomento, è la maggiore incidenza di persecuzioni sessuali e religiose ai danni delle donne in aree di conflitto.
Questo è stato particolarmente evidente durante la presa del potere da parte dell’Isis (Daesh) su alcune aree della Siria e dell’Iraq. In quelle zone, in quegli anni – secondo il dossier del luglio 2020 della Coalition for genocide response intitolato Without justice and recognition the genocide by daesh continues – vigeva «un sistema organizzato di schiavitù sessuale delle minoranze».

2 July 2018.
Nadia Murad e le schiave sessuali
![]() A raccontare le atrocità subite in prima persona, perché yazida, cioè donna della minoranza religiosa che vive per lo più nella Piana di Ninive, in Iraq, è stata Nadia Murad, Premio Nobel per la pace 2018. Nel suo libro L’ultima ragazza. Storia della mia prigionia e della mia battaglia contro l’Isis, edito da Mondadori, l’attivista per i diritti umani racconta: «A un certo punto non restano altro che gli stupri. Diventano la tua normalità. Non sai chi sarà il prossimo ad aprire la porta per abusare di te, sai solo che succederà e che domani potrebbe essere peggio». È il racconto dello stupro usato come arma di guerra. È la storia del rapimento e della prigionia che nel 2014 ha cambiato la vita di questa ventenne yazida che sognava una vita normale.
A raccontare le atrocità subite in prima persona, perché yazida, cioè donna della minoranza religiosa che vive per lo più nella Piana di Ninive, in Iraq, è stata Nadia Murad, Premio Nobel per la pace 2018. Nel suo libro L’ultima ragazza. Storia della mia prigionia e della mia battaglia contro l’Isis, edito da Mondadori, l’attivista per i diritti umani racconta: «A un certo punto non restano altro che gli stupri. Diventano la tua normalità. Non sai chi sarà il prossimo ad aprire la porta per abusare di te, sai solo che succederà e che domani potrebbe essere peggio». È il racconto dello stupro usato come arma di guerra. È la storia del rapimento e della prigionia che nel 2014 ha cambiato la vita di questa ventenne yazida che sognava una vita normale.
Nadia ha deciso di denunciare al mondo le violenze subite nella speranza di essere lei «l’ultima» del suo popolo ad aver vissuto quel genere di sofferenze.
La prassi di ridurre le donne delle minoranze religiose in schiave sessuali è presente anche altrove. Ad esempio in Mozambico e in altri paesi nei quali il fondamentalismo religioso ha gettato nel caos intere comunità.
Le violenze dei gruppi terroristici e islamisti hanno inoltre determinato una forte intensificazione del traffico di esseri umani.
C’è poi il caso della Nigeria dove si sono ripetuti diversi rapimenti di massa nei confronti delle donne cristiane da parte del gruppo jihadista di Boko Haram.
L’intento della milizia vicina all’Isis è, tra gli altri, quello di cacciare le comunità cristiane dai loro villaggi (cfr. MC 10/2016).
Asia Bibi e le altre
La persecuzione e le sofferenze non sono però solo numeri e dati, sono soprattutto storie di persone concrete.
Il caso che ha avuto maggiore rilievo sui media internazionali è stato quello della donna cristiana pachistana Asia Bibi che, dopo dieci anni di carcere duro e con una condanna a morte che pendeva sulla sua testa con l’accusa di blasfemia, ha ritrovato la libertà nel novembre 2018.
Oggi vive in Canada con la sua famiglia perché restare in Pakistan sarebbe stato per lei e i suoi familiari troppo pericoloso.
Ma ci sono tante altre Asia Bibi nel mondo. In Somaliland, ad esempio, due donne sono in carcere dal 2022 perché colpevoli di essere cristiane. Una delle due donne si chiama Hanna Abdirahman Abdimalik. Il 30 maggio 2022 è stata arrestata per essersi convertita al cristianesimo e per aver condiviso la sua fede attraverso un gruppo cristiano su
Facebook. La polizia non ha esibito un mandato d’arresto, ha interrogato la ragazza senza la presenza di un avvocato e le avrebbe ripetutamente domandato chi l’avesse convertita, aggiungendo che, qualora avesse rivelato l’identità della persona, oppure si fosse nuovamente convertita all’islam, sarebbe stata rilasciata. Hanna ha rifiutato di abiurare e il 27 giugno le forze di polizia del Somaliland hanno concluso le indagini presentando un fascicolo a suo carico al procuratore regionale di Hargeisa. Il procuratore ha quindi formalizzato le accuse di «crimini contro la religione dello stato» nei suoi confronti. I capi di accusa sono: blasfemia, oltraggio alla religione islamica e al Profeta dell’islam tramite social media, e diffusione del cristianesimo. Il 6 agosto 2022 il tribunale regionale l’ha condannata a cinque anni.
Il secondo caso riguarda la ventisettenne Hoodo Abdi Abdillahi, condannata a sette anni di carcere per essersi convertita, anche lei, al cristianesimo.
La donna è reclusa dall’ottobre 2022 presso il carcere femminile di Gebiley. Nel corso del processo non avrebbe avuto un avvocato difensore, mentre durante la reclusione non avrebbe potuto avere contatti con la famiglia.
Attualmente i due casi sono all’esame della Corte d’appello del Somaliland, in attesa di una sentenza definitiva.
Bangladesh, istruzione negata
Rahima Akter Khushi, 20 anni, è una giovane rifugiata rohingya, la maggiore di cinque fratelli nati nel campo profughi di Kutupalong a Cox’s Bazar, in Bangladesh. A raccontare la sua storia è Amnesty international.
Dopo aver completato gli studi superiori, a gennaio 2019 Rahima si era iscritta alla Cox’s Bazar international university con il sogno di conseguire una laurea in giurisprudenza. Dopo che un’agenzia di stampa internazionale l’aveva inserita in un video come una delle pochissime giovani donne rohingya in grado di raggiungere l’eccellenza accademica, il 6 settembre 2019, l’università le ha proibito di proseguire gli studi poiché «secondo le regole del governo del Bangladesh, nessun Rohingya può studiare in alcuna università pubblica o privata».
Negare l’istruzione alle giovani delle minoranze religiose è una delle armi di persecuzione: ad esempio in Nigeria è accaduto più volte che Boko Haram rapisse studentesse il giorno prima degli esami per negare loro un futuro.
Magda, rapita in Egitto
In Egitto, negli ultimi anni, la situazione dei cristiani è migliorata dopo l’ondata di attentati e vittime che c’erano stati nel periodo in cui era forte la presenza nel Paese del movimento dei Fratelli musulmani.
Se in generale nel Paese rimangono strascichi di emarginazione, ad esempio nel mondo del lavoro, situazioni nelle quali i cristiani continuano a essere penalizzati, è soprattutto nel Sud che si manifestano ancora oggi le forme più forti di persecuzione: una di queste è la piaga dei rapimenti di donne copte che avvengono lontani dagli occhi dei media, anche a causa del fatto che la maggior parte dei casi non viene denunciata.
Magda Mansur Ibrahim, cristiana copta ventenne, il 3 ottobre del 2020 è stata sequestrata mentre viaggiava dalla sua casa di Al-Badari verso il college di Assiut.
A riferire la sua vicenda è stato il portale Coptic solidarity. Sebbene la famiglia abbia denunciato il caso alla polizia, le autorità non hanno preso provvedimenti.
Tre giorni dopo il rapimento, è stato pubblicato sui social media un video in cui Magda appariva con indosso un hijab e dichiarava di essersi convertita all’islam sei anni prima, di essere fidanzata con un musulmano e, alla fine del filmato, chiedeva di non essere cercata.
I suoi genitori non si sono arresi e alla fine, poco meno di una settimana dopo, Magda è stata restituita loro. Dopodiché la famiglia ha chiuso ogni comunicazione senza fornire ulteriori informazioni circa il rapimento. Alcuni ipotizzano che tra le condizioni poste per la liberazione della ragazza vi fosse il divieto di parlare con i media, di sporgere denuncia o di cercare di scoprire l’identità del rapitore.
Gli stupri in Pakistan
Era il 14 febbraio 2021 quando la trentenne Neelam Majid Masih, cristiana, è stata aggredita da Faisal Basra. Lui era armato quando è entrato in casa di Neelam nel villaggio di Nanokay, Punjab, Pakistan. Sotto minaccia della pistola la ragazza è stata trascinata nella camera da letto, picchiata e violentata. Poi un vicino e cugino di secondo grado della donna è intervenuto costringendo Basra alla fuga.
A raccontare la vicenda è il portale persecution.org: «Pretendeva che lo sposassi e che mi convertissi, ma io ho rifiutato dicendo che non ero disposta a rinnegare Gesù. Lui ha risposto che mi avrebbe uccisa se non avessi accettato», ha raccontato la ragazza. La giovane, che ha riportato ferite al viso, alla spalla e alle gambe, ha sporto denuncia contro Faisal Basra, accusandolo di stupro. L’avvocato della vittima, Sumera Shafique, chiedendo aiuto all’associazione Aiuto alla Chiesa che soffre, ha sottolineato: «Neelam è determinata a raccontare la propria storia per porre fine alle aggressioni contro le ragazze e le giovani donne cristiane».
Schiava in Mozambico
![]() Nel rapporto Ascolta le sue grida già citato si racconta la storia di Aana (nome di fantasia), giovane cristiana del Mozambico, rapita da un gruppo armato.
Nel rapporto Ascolta le sue grida già citato si racconta la storia di Aana (nome di fantasia), giovane cristiana del Mozambico, rapita da un gruppo armato.
La giovane, dopo la sua liberazione, ha riferito che alle ragazze cristiane veniva imposta una «scelta»: «Avevamo tre opzioni. Le prime due erano essere selezionate da uno dei soldati per diventarne la moglie oppure essere scelte da alcuni uomini, non per il matrimonio, ma per seguire le norme più radicali dell’islam. Loro istruivano le giovani donne a diventare vere islamiche e brave madri perché credono che la donna sia colei che educa la famiglia a seguire i precetti nel modo corretto. La terza opzione riguardava le cristiane che non volevano convertirsi. Queste sarebbero state scelte dai soldati per essere loro schiave».
Aana ha spiegato che il suo indottrinamento è iniziato non appena è stata presa in ostaggio: «Il giorno in cui siamo arrivate ci hanno letto dei passi del Corano e hanno parlato dell’ingiustizia nel Paese, degli abusi sociali e della corruzione. Una delle cose che ripetevano più spesso era che la democrazia era demoniaca, perché in Mozambico permetteva ai politici di rubare e alla gente di morire di fame senza alcun tipo di assistenza. Cercavano di indottrinare le donne perché accettassero la loro proposta». Alla fine, la pressione psicologica conduceva le ragazze a «cambiare parte», ha spiegato la giovane. In condizioni di riduzione in schiavitù, spesso è l’unica via d’uscita.
Aana è riuscita a scappare e a denunciare. Oggi non è più prigioniera.
Manuela Tulli