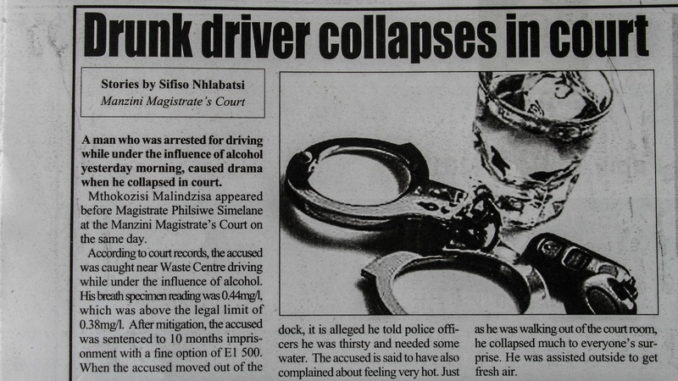Colombia: La pace teorica
testi di Angelo Casadei, Paolo Moiola e Mauricio A. Montoya Vásquesz |
Parole di pace, fatti di guerra
Perdono, riconciliazione e… indifferenza
«Ricercato, vivo o morto» (l’ultima intervista)
Storia di Isabel, guerrigliera per forza.
L’interminabile conflitto colombiano
Parole di pace, fatti di guerra
Dagli accordi di pace siglati nel 2016 sono trascorsi oltre quattro anni. Il lunghissimo conflitto colombiano è mutato, ma non è terminato. E le cause che lo hanno prodotto sono ancora irrisolte.
Le parole sono importanti, ma spesso insufficienti, sopravvalutate o inutili. La Costituzione colombiana, promulgata nel luglio del 1991, parla di pace in tre circostanze: nel preambolo, nell’articolo 22 e nel 95. Nel preambolo si dice che il potere sovrano assicura ai cittadini «la vita, la convivenza, il lavoro, la giustizia, l’eguaglianza, l’istruzione, la libertà e la pace». L’articolo 22 afferma che «la pace è un diritto e un dovere di realizzazione obbligatoria». Infine, secondo l’articolo 95, tra i doveri della persona e del cittadino c’è quello di «promuovere il raggiungimento e il mantenimento della pace». Eppure, nonostante le parole solennemente scritte nella Carta costituzionale, in Colombia la pace è largamente incompiuta. Ancora oggi essa rimane una promessa di molti e una speranza di tanti.
I numeri del conflitto possono cambiare a seconda delle modalità di raccolta dei dati e dei soggetti che li raccolgono. In tutti i casi si tratta di numeri impressionanti. Il Centro nacional de memoria histórica, tramite l’Observatorio de memoria y conflicto, conta le vittime del conflitto distinguendo tra undici modalità di violenza: azioni di guerra, danni a beni civili, uccisioni selettive, attacchi alla popolazione, attacchi terroristici, sparizioni forzate, massacri, mine antiuomo, ordigni esplosivi improvvisati e ordigni inesplosi, reclutamento e utilizzo illeciti di bambine, bambini e adolescenti, sequestri, violenze sessuali.
Le informazioni, raccolte e minuziosamente catalogate dall’istituzione, disegnano un quadro dettagliato di cosa abbia significato e significhi il conflitto interno per i colombiani. Secondo questa fonte, nel periodo 1958-2020 le vittime mortali (víctimas fatales) della guerra sono state 266.988.
Gli attori principali del conflitto sono quelli conosciuti: la guerriglia (politicamente di sinistra), i gruppi paramilitari (politicamente di destra), gli agenti dello stato, banditi, altri gruppi non identificati.
Leggendo i dati dell’Observatorio de memoria y conflicto, non mancano però le sorprese. Per esempio, la vulgata comune, sia in Colombia che all’estero, ha sempre attribuito le maggiori responsabilità del conflitto alla guerriglia (Farc, in primis). Invece, i colpevoli principali pare siano stati i gruppi paramilitari. Questi sarebbero i primi responsabili delle uccisioni mirate, delle sparizioni forzate, delle violenze sessuali e dei massacri. La guerriglia (Farc, Eln, M-19, Epl, Cgsb), invece, sarebbe in testa per i sequestri, gli attacchi a centri abitati, la distruzione di infrastrutture pubbliche e l’arruolamento nelle proprie file di minori. Gli agenti dello stato sarebbero i protagonisti della maggior parte delle azioni belliche. Dopo la firma dell’accordo di pace del 2016 (prima respinto dal referendum, poi modificato e approvato dal Congresso), la situazione sul campo è mutata, ma non i risultati. In alcune zone sono tornate le Farc con gruppi di dissidenti (identificati come Gao-r), mentre vari attori legati al narcotraffico hanno esteso il proprio dominio. Perché dunque, dopo decenni di lutti e devastazione, la guerra non ha ancora termine? Una delle cause principali è il persistere nel paese di condizioni di povertà e diseguaglianza. Per citare soltanto un dato, nel 2019 la povertà interessava il 35,7% dei colombiani (Departamento administrativo nacional de estadística, Dane). Con percentuali molto più alte in alcune regioni (con un massimo di 68,4% nel dipartimento del Chocó) e nelle zone rurali e amazzoniche.
Queste ultime ospitano anche le zonas cocaleras. Secondo il White House office of national drug control policy (Ondcp, marzo 2020), nel 2019 erano coltivati a coca 212mila ettari per una produzione di 951 tonnellate di cocaina. Invece, secondo lo United Nations office on drugs and crime (Unodc), gli ettari coltivati sono di meno (154mila), ma la produzione maggiore (1.136 tonnellate nel 2019). Quali che siano i dati corretti, la realtà mostra una produzione enorme di cocaina con il coinvolgimento di migliaia di famiglie contadine costrette a coltivare piante di coca non per arricchirsi ma per sopravvivere.
Secondo l’organizzazione non governativa Planeta paz, la pace va costruita e suppone la creazione di condizioni politiche, sociali ed economiche. Essa non significa semplicemente superare il conflitto armato. È necessario «sradicare dalla vita sociale colombiana lo stato di guerra in cui vive la maggior parte dei suoi abitanti a causa dell’incertezza sull’ottenimento dei mezzi necessari per garantire la vita biologica e una vita dignitosa».
In questo quadro, nell’ultimo anno si è anche inserita la pandemia da coronavirus. Una tessera in più da sistemare nel complicato puzzle colombiano.
Paolo Moiola
![]()
![]()
Colombia
- Forma di governo:
Repubblica presidenziale. - Presidente: Iván Duque Márquez del
partito conservatore Centro democratico, guidato dall’ex presidente Álvaro Uribe. - Superficie: 1.141.748 km² (quasi quattro volte l’Italia).
- Abitanti: 49,9 milioni.
- Etnie: 1.905.614 (4,4%) indigeni; 2.950.072 (6,7%) afrocolombiani (fonte: Dane, 2018).
- Città principali: Bogotá (capitale), Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias.
- Religioni: 79% cattolici, 12% protestanti; in rapida crescita le chiese evangeliche e pentecostali.
- Economia: agricoltura molto varia, con il caffè e la coca al primo posto; allevamento, in primis di bovini; risorse minerarie come oro, smeraldi e petrolio; il paese ha sostituito il Venezuela come primo esportatore sudamericano di petrolio verso gli Usa.

Conversazione
Perdono, riconciliazione e… indifferenza
Nel conflitto e nel processo di pace colombiano, le variabili in gioco sono numerose. Proviamo a fare ordine con il professor Mauricio A. Montoya Vásquez, studioso del conflitto.
Per chi ha pagato sulla propria pelle le conseguenze di un conflitto, dimenticare e magari perdonare sono passaggi complicati o forse impossibili. «In primo luogo – ci spiega il professor Mauricio A. Montoya Vásquez, storico e studioso del conflitto -, occorre differenziare tra perdono e riconciliazione. Il perdono è una cosa più personale, che può includere anche caratteristiche religiose. La riconciliazione è una cosa più ampia, che include l’instaurazione di legami di fiducia. È meglio non iniziare un processo di pace con la parola perdono e utilizzare invece la parola riconciliazione».
Chiediamo se la società colombiana sia in grado di dimenticare oltre sessant’anni di conflitto interno. Il nostro interlocutore ha un’opinione particolare. «Non credo – dice – che il problema sia dimenticare, che, a volte, può essere in qualche misura un elemento salvifico. Io credo che, per la maggior parte dei colombiani, il grande problema sia quello dell’indifferenza, come abbiamo visto bene nel plebiscito del 2016. Erano più di 30 milioni le persone aventi diritto, ma solamente 13 milioni hanno partecipato. Inoltre, le persone che hanno votato per il “Sì” (all’accordo di pace) erano quelle che vivevano nei territori più colpiti dalla violenza. È qui che si è deciso di voltare pagina».
Mauricio Montoya ricorda Tzvetan Todorov. «Secondo il filosofo bulgaro – spiega -, ci sono due memorie: una letterale e una esemplare. Ci sono società che vogliono rimanere legate a una memoria letterale, che è quella che ricorda, commemora e – sfortunatamente – mette il dito nella piaga e in ogni occasione cerca vendetta. Con la seconda invece si commemora e si ricorda. Non dimentica, ma è disposta a voltare pagina perché la società del futuro non soffra e non ripeta queste situazioni. Perché la società vecchia sia d’esempio a quella nuova».
Dissidenti e banditi

«Già all’inizio c’erano persone che non erano disponibili ad accettare il processo di pace. In seguito altri – come Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y Romaña – si sono ritirati dicendo che non c’erano garanzie sufficienti e che non si stava compiendo quanto stabilito».
«Secondo me, questo è stato un errore. Avrebbero dovuto aspettare visto che il nostro sistema è lento e per questo richiede pazienza. Costoro sono dunque tornati alle armi formando la dissidenza che sta tentando di occupare il territorio che un tempo era dominio delle Farc. In molte zone sono in competizione con bande criminali dedite al narcotraffico. Io penso che i dissidenti abbiano un progetto politico sempre meno visibile e si avvicinino ai Bacrim (acronimo di Bandas criminales come los Urabeños, ndr), ovvero i gruppi paramilitari che non hanno accettato il processo di smobilitazione».
Tuttavia, non c’è soltanto la dissidenza. Ci sono anche notizie incoraggianti: «Un 70 per cento di ex combattenti delle Farc – precisa Mauricio – sta scommettendo sulla pace, anche con vari progetti produttivi: i cento ex guerriglieri e rispettive famiglie che si sono trasferiti su una terra di Mutatà, quelli impegnati nel turismo ecologico, o quelli che hanno aperto fabbriche di abbigliamento (marca “Manifiesta-Hecho en Colombia”) e di birra artigianale (“La Roja”)».
Si tratta di progetti d’inserimento nella società civile da incoraggiare, ma anche da difendere visto che, al 7 gennaio 2021, erano già stati assassinati almeno 252 ex membri delle Farc (un film già visto negli anni Ottanta quando i paramilitari sterminarono gli iscritti al partito Unión patriótica). Ancora più alte sono le cifre riguardanti l’assassinio di líderes sociales (difensori dei diritti umani, ambientalisti, attivisti indigeni e afrocolombiani). Negli ultimi quattro anni sarebbero stati 421, secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Mentre la Defensoría del pueblo riporta oltre 700 morti. «Eppure – precisa Mauricio -, secondo alcuni, questi líderes sociales sono stati uccisi a causa di lios de faldas (letterale, “litigi per le gonne”, ndr) come fossero cioè problemi amorosi che non hanno nulla a che vedere con il contesto politico».
Chi vuole il fallimento?
![]()
Oltre ai dissidenti delle Farc e ai gruppi paramilitari, ci sono molti altri attori che lavorano per far fallire il processo di pace. Il nostro interlocutore non ha dubbi al riguardo.
«Dagli anni Ottanta – spiega – la pace è un tema elettorale. In questo senso, molti lo hanno manipolato per arrivare alla presidenza. È chiaro che ci sono persone che non vogliono che gli accordi si compiano nei modi sottoscritti a l’Avana e, dopo la sconfitta nel plebiscito, al Congresso. Il problema è quello degli approfittatori, dei mercenari che cercano di portare confusione e di preservare i propri interessi particolari. Costoro lavorano affinché le cose non si sappiano e da qui nascono gli attacchi alle istituzioni che operano per il processo di pace».

Dall’accordo di pace firmato dall’allora presidente Manuel Santos e dai vertici delle Farc-Ep, è nato il «Sistema integrale di verità, giustizia, riparazione e non ripetizione» (Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, in sigla Sivjrn). Incorporato nella Costituzione attraverso il decreto legislativo 01 del 2017, il Sistema è fondato su tre componenti: la «Commissione di chiarimento della verità, convivenza e non ripetizione» (Comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, Cev); l’«Unità per la ricerca delle persone date per scomparse» (Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, Ubpd) e la «Giurisdizione speciale per la pace» (Jurisdicción especial para la paz, Jep).

Tra i maggiori oppositori del processo di pace c’è Álvaro Uribe, l’uomo forte della Colombia, fondatore del partito Centro democrático (Mano firme. Corazón grande, «Mano ferma. Cuore grande») del quale è militante anche l’attuale presidente Iván Duque. «È ovvio – conferma Mauricio Montoya – che l’ex presidente Uribe ha avuto ed ha influenza. Ha guadagnato appoggio e popolarità tra una fetta importante della popolazione per la sua opposizione ai gruppi armati, per la sua volontà di non negoziare con essi. La sua scelta militare ha però portato anche a violazioni ed eccessi come per i “falsi positivi” (civili innocenti assassinati dall’esercito che li faceva passare per guerriglieri per ingigantire i propri successi militari, ndr). Uribe continua ad essere molto influente in ambito politico, cosa che gli permette di far eleggere senatori, governatori, sindaci. Oggi rimane popolare tra la popolazione più anziana, ma non tra i giovani colombiani».
Come fare giustizia?
Dopo gli accordi del 2016, le Farc si sono trasformate in partito politico, mantenendo la denominazione ma con un significato diverso: da «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» a «Fuerza alternativa revolucionaria del Común». Lo scorso 24 gennaio i responsabili hanno annunciato di aver cambiato il nome in «Comunes» per non confondere il gruppo firmatario degli accordi di pace con il gruppo dei dissidenti. Il leader Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ha ammesso che mantenere il nome di Farc non è stata una buona idea e che il nuovo nome del partito fa riferimento alla gente comune.
Questo non significa però che gli ex guerriglieri non verranno giudicati. Gli accordi di pace non sono infatti una patente d’impunità, una rinuncia a fare giustizia e a punire i responsabili.
«I media e i social – spiega Montoya – hanno creato un ambiente negativo attorno alla Jep. Dicendo che è una giustizia dei guerriglieri e che è contro i militari. Tutti argomenti che a poco a poco sono caduti». Anzi, lo scorso 29 gennaio il tribunale speciale creato con gli accordi di pace (la citata Jep, Jurisdicción especial para la paz) ha accusato l’antica cupola della guerriglia di crimini di guerra e di lesa umanità per i sequestri commessi per decenni. Sono stati incriminati otto membri delle ex Farc, tra cui lo stesso Rodrigo Londoño e due senatori.
«A dimostrazione – chiosa Montoya – che il compito che sta svolgendo la Jep è reale».

L’irrisolta questione della terra
In Colombia la diseguaglianza è visibile e confermata da tutti gli indici. Chiediamo al professor Montoya il peso della questione della terra.
«Durante i colloqui e il processo di pace – risponde -, la questione della terra è stata un tema ricorrente. “Perché ancora una volta il tema della terra?”, domandava molta gente. La risposta è semplice: perché in realtà il problema della terra non è stato mai risolto. Sta scritto negli accordi, ma la soluzione ancora non si vede. Un passaggio fondamentale è la trasformazione e attualizzazione del catasto rurale, che significa riuscire a sapere quanti ettari di terra possiedono le persone, quante imposte pagano e se queste sono coerenti con le terre possedute, perché ci sono territori vuoti che non vengono consegnati ai contadini e alle comunità agricole che li richiedono. Molti ritengono che il problema della diseguaglianza e della terra non sia una causa della guerra. Forse non è l’unica, ma è fondamentale».
Il narcotraffico
Legata al tema della terra è la questione delle piantagioni di coca e del commercio della stessa. «Il narcotraffico – spiega il professore – ha attraversato il conflitto dagli anni Settanta. Le coltivazioni di coca continuano sotto il controllo dei gruppi armati, illegali e legali. È infatti comprovato che in questo lucroso business ci sono anche politici. In molti territori ci sono combattimenti tra i vari gruppi armati per controllare le rotte della droga. Un esempio tra i tanti possibili: l’ex paradiso dell’arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina (davanti alle coste del Nicaragua, ndr) ha altissimi livelli di violenza essendosi convertito in un ponte per il traffico con Stati Uniti ed Europa. Accanto a queste rotte c’è poi il microtraffico all’interno delle città colombiane dove le bande si contendono con le armi il traffico non soltanto di droga ma anche di persone».

Con il Venezuela e gli Stati Uniti
Lo scorso febbraio il presidente Iván Duque ha annunciato la regolarizzazione (tramite il nuovo Estatuto nacional de protección) per dieci anni di oltre due milioni di immigrati venezuelani, che permetterà loro di accedere ai sistemi pubblici della salute e dell’educazione e di lavorare regolarmente. Il presidente colombiano ha sempre usato (furbescamente) la lotta contro il Venezuela di Maduro come strumento di lotta politica interna e internazionale.
«Duque usa quel paese – spiega Mauricio Montoya – in termini elettorali per spaventare la popolazione su certi candidati o modelli politici o idee per supposte affinità al Venezuela o, come viene spesso detto, al castrochavismo. Credo perciò che le relazioni tra i due paesi si manteranno tese, instabili e polarizzate».
Nel frattempo, negli Stati Uniti, storico alleato del paese, la presidenza è passata da Donald Trump a Joe Biden. «Non cambierà molto – osserva Montoya -. Alcuni media dicono che, avendo il governo colombiano appoggiato Trump, Biden presenterà il conto. Non credo sarà così. La Colombia non perderà l’appoggio statunitense né in termini economici né di lotta al nartraffico. Credo però che gli Usa avranno un ruolo nella competizione per la prossima presidenza la cui campagna inizierà ancora quest’anno».
In effetti, l’ex presidente ed ex senatore Álvaro Uribe ha già iniziato le audizioni per selezionare i propri candidati.
Paolo Moiola

Incontro con un dissidente Farc
«Ricercato, vivo o morto» (l’ultima intervista)
Abbiamo incontrato Dúver, uno dei leader dissidenti delle Farc. È stata una conversazione unica. Due mesi dopo, Dúver è stato ucciso in un’operazione militare che ha avuto una grande eco sui media locali.
Solano (Caquetá). Ho ricevuto un invito da parte di Dúver Guzmán, nome di battaglia di Marco Tulio Salcedo, importante guerrigliero delle Farc-Ep, a Mononguete, lungo il fiume Caquetá. Il luogo prescelto è presso il distributore galleggiante di benzina, situato nel porticciolo principale del paese. L’appuntamento è per venerdì 18 settembre, alle 10,30.
Con Rito, il motorista della parrocchia, arrivo in anticipo, alle 9,30. Mentre attendo, vedo arrivare dall’altra parte del fiume, in territorio della regione del Putumayo, altri guerriglieri che non fanno però parte di coloro che sto aspettando.

La guerriglia vuole sapere tutto
All’ora concordata arriva Dúver. Viene verso me, mi dà la mano e mi offre da bere una gazzosa. Ci accomodiamo uno di fronte all’altro: io su una panca, lui su una sedia. Alla cintura porta una pistola. Indossa una maglietta con la mappa della Colombia e l’immagine di Marulanda: il contadino che fondò le Forze armate rivoluzionarie della Colombia è raffigurato che impugna un fucile, mentre nel mezzo della mappa campeggia la sigla Farc-Ep.
Iniziamo a parlare. Subito mi chiede: «Padre, mi parli del progetto». Non capisco, o meglio, fingo di non capire quello a cui vuole riferirsi Dúver, e così inizio a parlargli del progetto di evangelizzazione che portiamo avanti nel Vicariato apostolico di Puerto Leguizamo-Solano con mons. Joaquin Humberto Pinzón, il nostro vescovo; dell’équipe missionaria in parrocchia, composta da quattro suore, due seminaristi, un laico missionario e me come parroco e coordinatore.
Proseguo la mia descrizione: «Dúver, il territorio della parrocchia è molto vasto, visto che comprende 106 comunità, 90 villaggi di coloni e 16 popoli autoctoni. In esso ci sono la parrocchia San Francisco d’Asis formata nel 2019, il centro di missione Assunzione, il centro di missione San José, la parrocchia Nuestra Señora de las Mercedes. Per la vastità del territorio in futuro sono previste quattro parrocchie».
Dúver ascolta attentamente, anche perché la guerriglia vuole sapere tutto ciò che succede nell’area in cui essa opera. «Come missionari della Consolata – continuo -, siamo presenti in questa regione dal 1951 e a Solano in modo permanente dal 1959, mentre la parrocchia è stata istituita nel 1969. La nostra presenza ha come sua prima finalità l’annuncio di Gesù Cristo, ma abbiamo sempre tenuto presente l’educazione scolastica, e oggi proseguiamo il lavoro appoggiando e proponendo alcuni progetti sociali».
Gli spiego la nostra filosofia: «L’annuncio del Vangelo non è scollegato dall’aspetto sociale: evangelizzazione e promozione umana, che come missionari della Consolata, le abbiamo nel sangue».
Dúver mi interrompe dicendo: «Il Vaticano ha molti soldi!». Gli rispondo: «Non so quanti soldi abbia il Vaticano. Io so solo che il nostro Vicariato e il nostro vescovo di soldi non ne hanno. Viviamo alla giornata, di quello che si riceve dalle offerte delle persone semplici del nostro popolo caqueteño e da aiuti di alcuni benefattori sia colombiani che di altri paesi».
Insiste che gli parli del progetto, però di nuovo chiedo che mi dica a quale progetto si riferisce. Alla fine, gli suggerisco: «Il progetto cambio climatico?». Annuisce. «Il nome completo è “Miglioramento sostenibile della situazione socio-economica e ambientale della popolazione amazzonica nelle regioni del Caquetá e Putumayo”. È appoggiato dalla Cooperazione tedesca e dalla Caritas tedesca, ed è coordinato dalla Pastorale sociale colombiana».
«Sosteniamo 60 famiglie della zona, con supporto tecnico nell’area agroforestale e con un adeguato allevamento del bestiame nei pascoli. Ne deriva quindi un lavoro anche di formazione al lavoro comunitario e impegno politico».
A Dúver però queste informazioni non bastano: vuole sapere l’ammontare in denaro degli aiuti economici che arrivano. Minaccia che, se non gli darò l’informazione, parlerà con il vescovo.
Per evitare di esporre mons. Joaquin gli dico che «più o meno il progetto ha una base di appoggio di 200 milioni di pesos colombiani (50mila euro, ndr) all’anno per un periodo di tre anni». Dúver commenta: «Pensavo molto di più!».

Dall’età di 12 anni nella guerriglia
Dopo aver raggiunto il suo obiettivo, la conversazione si apre a vari argomenti. Gli chiedo: «Da quanto tempo si trova nelle Farc?». «Da quando avevo 12 anni. Sono originario del Caguán. Ho vissuto nella regione del Meta. Ora vivo in questo territorio, in una zona tra il fiume Caquetá e il fiume Caguán».
Domando: «Quando finirà questa guerra che dura da più di 60 anni?». «Quando – risponde – il popolo aprirà gli occhi e avrà in mano il potere». «Ma come pensate di arrivare al potere?», insisto io. «L’unica soluzione sono le armi. È il linguaggio più chiaro per farsi capire, sentire, e rispettare anche se noi tuteliamo la giustizia a favore della comunità».
«Le racconto, padre, che, poco tempo fa, un grande proprietario terriero ha venduto una grandissima finca (fattoria). Noi gli abbiamo chiesto una percentuale ma lui ci ha negato il denaro. Lo abbiamo processato davanti al popolo ed abbiamo lasciato decidere alla stessa comunità che lo ha graziato». E continua: «Padre, ha visto quanti líderes delle comunità sono stati assassinati perché hanno aperto gli occhi al popolo?»
Allora gli chiedo: «Dúver dov’era quando si sono fatti gli accordi di pace?». «Nel “monte”, in foresta a continuare la guerra. Non possiamo lasciare scoperti spazi che altri potrebbero occupare».
«Che altri gruppi ci sono oltre le Farc nella zona?», domando. «Il gruppo narcotrafficante messicano di Sinaloa: il loro territorio è un po’ più giù verso Curillo. Ma sono interessati solo ai soldi. Noi paghiamo 2.300 pesos (circa 0,55 euro, ndr) al grammo la pasta di coca, mentre loro la pagano molto meno. Se il contadino non si adegua alle regole da loro imposte, viene ucciso senza chiedere il parere alla comunità».
Dopo quasi due ore di chiacchierata, ci salutiamo. Mi accorgo che, dietro a me, ci sono altre persone in attesa di parlare con il dissidente delle Farc. Li saluto. Poi, con Rito salgo sulla barca e ci dirigiamo dal porto verso il paesino per salutare la gente. Con tutte le precauzioni possibili.
Angelo Casadei

L’UCCISIONE

Il 24 novembre 2020 le autorità colombiane hanno annunciato la morte di Marco Tulio Salcedo Pinilla alias Dúver, responsabile («cabecilla») delle finanze di un gruppo dissidente delle Farc (ufficialmente, «Grupo armado organizado residual», Gao-r), struttura Míller Perdomo, operante nei dipartimenti di Caquetá, Putumayo e Meta.
L’operazione è stata effettuata dalla Sesta divisione dell’esercito nazionale nella vereda Mononguete, nel municipio di Solano, Caquetá.
Sulla testa di Dúver vigeva una taglia di 150 milioni di pesos (circa 35mila euro) per la sua cattura o morte.
Secondo le autorità competenti, la struttura criminale era incaricata di raccogliere denaro tramite estorsioni e sequestri, traffico di droga, reclutamento forzoso, soprattutto di minori, attacchi a strutture militari.
Pa.Mo.

Il reclutamento forzato
Storia di Isabel, guerrigliera per forza
Reclutata, arrestata, condannata, liberata e ancora reclutata. In questo cammino disperante, Isabel ha trovato l’aiuto della Chiesa. Eppure, oggi è scomparsa di nuovo, persa nel gorgo di un conflitto infinito.
Solano (Caquetá). Siamo in piena novena della festa patronale Nuestra Señora de la Mercedes (Nostra Signora della Misericordia), che ricorre il 24 di settembre. Lunedì 21 settembre arriva in canonica una donna (la chiamerò Isabel) con un bambino di quattro anni, mezz’ora prima dell’eucaristia delle 18,00. «Padre, provengo dal villaggio Yurilla che è lungo il fiume Mecaya – mi dice -. La prego, deve aiutarmi a mettermi in contatto con i militari della Forza aerea».
«Nella finca (fattoria) dove vivo, ci sono 24 ragazzini dai 12 ai 14 anni che le Farc-Ep stanno addestrando alla guerra. Quattro di loro sono gravemente feriti. Vi è stato un violento scontro con il gruppo Sinaloa (potente cartello di narcotrafficanti messicani, ndr) lungo il fiume Putumayo un po’ più in giù della nostra finca».
«Uno dei ragazzi mi ha chiesto di cercare un sacerdote e chiedergli aiuto. Sono qui a Solano perché ho dei seri problemi ginecologici e il medico, dopo la visita, mi ha indirizzata a Florencia per degli accertamenti più approfonditi, ma non posso andarci finché non avrò l’autorizzazione del comandante Danilo. Vivo qui nel Mecaya dall’inizio dell’anno con mia sorella. Lei è la moglie di un comandante delle Farc».
«Un giorno è venuto Danilo e mi ha imposto di essere parte del movimento. Avevo due possibilità: o m’inserivo come guerrigliera militare o collaboravo come guerrigliera “civile”. Vedendomi costretta, ho deciso per questa seconda scelta».
«Mi ha proposto di andare con lui in un loro centro per fare da cuoca a sessanta persone promettendomi che mi avrebbe dato 750mila pesos il mese (circa 170 euro, ndr), e la possibilità di poter uscire dalla finca ogni due mesi».
«Non ho ancora visto un soldo e sono quattro mesi che sono chiusa in quel posto».
«Prima di trasferirmi nel Mecaya sono stata quattordici anni in prigione. Ero stata condannata a trentacinque anni ma, per buona condotta e per i vari corsi a cui ho partecipato, mi hanno condonato gli anni rimanenti».
«Padre, io voglio salvare questi ragazzini: me
l’hanno chiesto e, come le ripeto, quattro sono feriti gravemente e hanno bisogno di cure immediate. Per favore mi metta in contatto con il colonnello della base aerea, e anche con il vescovo. Con lei e con loro, attorno a questo tavolo, posso indicare il luogo preciso dove si trova la finca di addestramento delle Farc. Devo parlare velocemente con la Forza aerea perché intervenga immediatamente, domani potrebbe essere troppo tardi! Nella Farc ho fatto parte dell’équipe di strategia militare, quindi sono in grado di dare le coordinate dove si trovano i ragazzi. Mi aiuti, padre».
«Isabel – le rispondo -, mi lasci pensare questa notte per vedere cosa fare, e domani ci sentiremo». Mi dà il suo numero di cellulare, anche se mi dice che è senza caricabatterie.
![]()
Contatto con il «personero»
Non dormo tutta notte con il pensiero di quei ragazzini. Devo e dobbiamo fare qualcosa. Ne parlo con il vescovo Joaquin che mi suggerisce di mettere Isabel in contatto con il «personero» (figura giudiziale dello stato presso la quale chiunque, anonimamente, può fare ricorso per eventuali denunce soprattutto quando sono violati i diritti umani, ndr).
Alle otto contatto la segretaria che mi dà il suo numero. Gli telefono subito e mi dice che sarà libero alle nove. Chiamo Isabel che viene nell’ufficio della parrocchia per continuare il dialogo.
La aggiorno dicendole che ho parlato con il vescovo e che la cosa migliore è metterla in contatto con il personero. Isabel insiste però che vuole parlare con un colonnello della Forza aerea per intervenire immediatamente.
Ha anche delle esigenze pratiche: «Padre, mi può prestare il caricabatterie. Inoltre, sono rimasta senza soldi. Mia sorella mi ha dato 50mila pesos (11 euro, ndr), ma li ho spesi per l’alloggio e la cena per me e il mio bambino. Questa mattina, quando sono uscita dalla casa dove abbiamo dormito, la signora che gestisce il posto aveva una colazione prenotata per una persona che poi non è arrivata. Quando ha visto che il bambino piangeva perché aveva fame, ce l’ha regalata».
Testa bassa e manette ai polsi
Isabel ripercorre gli anni della sua esistenza. «Quando avevo 8 anni, i miei genitori sono stati uccisi a San Vicente del Caguán. Allora il vescovo Luis Augusto Castro mi ha accolta alla Finca del niño (Fattoria del bambino) con mia sorella e mio fratello, e lì sono rimasta quattro anni».
«Terminate le scuole elementari nella Finca del niño, sono tornata a casa dalla nonna. Avevo soltanto 12 anni, ma su di me, allora non lo sapevo, erano puntati gli occhi della Farc che mi ha preso e mi ha introdotta nelle loro fila, per addestrarmi a combattere».
È un’esistenza difficile quella di Isabel. «Mi hanno fatto abortire molte volte, perché i bambini sono un “peso” e un pericolo per i guerriglieri. Noi viviamo nella foresta, ci nascondiamo, combattiamo. Ed è proprio a causa di questi aborti che ora ho questi seri problemi di salute. Ho avuto però un figlio da un compagno guerrigliero, il quale è morto in uno scontro a fuoco e in quel contesto l’esercito mi ha fatto prigioniera. Le dicevo, padre, che sono stata condannata a 35 anni, ma per buona condotta ne ho scontati soltanto 14».
Mi accorgo che Isabel si sta commuovendo mentre continua a raccontare: «Mi trovo in carcere. Ho la testa bassa e le manette ai polsi. So che si stanno svolgendo i colloqui per trovare un accordo di pace. Il vescovo Luis Castro visita i carcerati. Appena lo vedo lo riconosco. Lo vorrei abbracciare, come feci da bambina quando mi uccisero i genitori, ma non posso farlo perché sono custodita da due guardie e devo rimanere seduta. Allora lo saluto alzando le mani e le muovo come se fossero ali di una farfalla, perché, padre Angelo, facevo questo gesto quando il vescovo veniva a trovare me e tutti gli altri bambini alla Finca del niño. Il vescovo mi guarda, mi riconosce, mi chiama per nome. E io piango».
Durante i lunghi dialoghi per trovare un accordo di pace tra la Farc e lo stato colombiano, mons. Luis Castro è il rappresentante della Conferenza episcopale colombiana. Da quel momento tra Isabel e mons. Castro si ristabilisce il contatto e il vescovo la aiuterà per buona parte della sua lunga detenzione. Isabel è molto riconoscente di quel provvidenziale appoggio.

Dubbi (tra fedeltà e tradimento)
Dopo aver ascoltato il suo drammatico racconto, le offro del denaro per comprare vestiti al bambino, per pagare la camera e il cibo. Si convince anche a chiamare il personero.
Chiamo la segretaria che si mette in contatto con lui. Così, finalmente, tutti e tre ci sediamo attorno al tavolo del suo ufficio.
Il personero, Carlo Mario, dice subito che lui è un tramite. Non può coinvolgersi direttamente vivendo in un territorio ad alto rischio. Può «aprire porte» e offrire contatti e propone autorità a livello nazionale come il procuratore. Tuttavia, Isabel insiste che ci deve essere un intervento immediato dell’esercito.
Carlo Mario allora fa un esempio chiarificatore: «Se tu – spiega – dai un pezzo di carne a un cane affamato, lui lo addenta e se lo divora immediatamente senza tenere in conto chi sta attorno e le eventuali conseguenze. In questo territorio, in questo momento, le forze dell’esercito cercano dei risultati. Se vi è un obiettivo preciso e chiaro, loro arrivano con un potente spiegamento di uomini, senza tener conto di chi si trova nel luogo: civili bambini, donne… Così possono andarci di mezzo le stesse persone che la guerriglia obbliga con la forza di stare dalla loro parte. Oppure può accadere che la stessa guerriglia le elimini per non lasciare testimoni».
Isabel mi chiede dei fogli e incomincia a disegnare la posizione della finca, dove si trovano i ragazzi e le postazioni della guerriglia attorno e nel resto del Putumayo e Caquetá.
Carlo Mario allora si mette in contatto con la base aerea di Tres Esquina e parla direttamente con il colonnello, che non può venire, ma invierà il vice che nel pomeriggio arriverà a Solano. Il luogo dell’incontro con l’intelligence della Forza aerea sarà nel salone della catechesi.
A questo punto Isabel mi prende la mano e me la stringe forte. Sente che, in qualche modo, sta tradendo il movimento guerrigliero dopo tanti anni di fedeltà e mi dice: «Lo faccio per i ragazzi che sono stati strappati alle loro famiglie e arruolati contro la loro volontà, per la durezza del comandante Danilo verso loro e verso me».
«Un giorno mi ha colpito violentemente con il calcio della pistola sul viso facendomi cadere per terra e per questo sono svenuta. Mio figlio di quattro anni si è messo in piedi, davanti al comandante, e con autorità l’ha minacciato e gli ha detto di smettere di picchiare la sua mamma».
Sicuramente il tempo trascorso fuori dalle file della guerriglia, quando era in carcere, i corsi di studio e il contatto con altre persone hanno fatto pensare Isabel.
È forte il desiderio di non collaborare più con il movimento guerrigliero. Non può scappare perché il figlio di sedici anni è sequestrato. L’ha dovuto lasciare nella fattoria come garanzia che sarebbe ritornata.
Le chiedo: perché, dopo il carcere, sei tornata in questo territorio? «La mia famiglia è qui, dove potevo andare? Sono uscita di prigione che non avevo assolutamente niente. Sono venuta da mia sorella che vive come guerrigliera civile in un paesino del fiume Mecaya con un guerrigliero che, ogni tanto, la viene a trovare».

I colloqui, il ritorno, la scomparsa
In attesa dei militari andiamo a pranzo. Nel pomeriggio Isabel mi vuole mostrare quello che ha comprato per il figlio e mi ringrazia.
All’ora stabilita inizia l’incontro con i due militari della base aerea. A un certo punto, uno esce per confermarmi che il dialogo è iniziato, ma Isabel non ha voluto dare il suo numero di telefono. Mi domanda se posso fare da intermediario con il mio cellulare, e naturalmente accetto. La conversazione dura sino alle sei del pomeriggio.
Alla fine, i militari mi dicono che vi sarà un nuovo incontro però ancora non sanno quando.
Il giorno dopo, mercoledì, mi chiamano e mi dicono che ci troveremo quello stesso giorno o il successivo ma che, in ogni caso, devo attendere una conferma.
Nel pomeriggio Isabel viene in parrocchia mentre mi trovo in un incontro. Vado a parlarle. È preoccupata perché ancora non la chiamano, e insiste a chiedermi di vedere il vescovo. Tramite il mio cellulare la metto in contatto con i militari. Nel frattempo parlo con il vescovo, che la incontra poco dopo. Isabel gli chiede una benedizione e gli affida i suoi due figli se dovesse succederle qualcosa.
Ha piena fiducia nella Chiesa perché, nella sua vita, è stata aiutata con mons. Castro. Una storia che sembra ripetersi.
Giovedì mi richiamano i militari perché contatti la muchacha per continuare il dialogo. L’appuntamento è per le nove del mattino. Isabel non mi risponde. Nel frattempo arriva il vice colonnello. Isabel chiama. Arriva dopo qualche minuto. La conversazione si protrae sino alle cinque del pomeriggio. In seguito i militari mi chiamano e mi dicono che si è creata una certa fiducia e, quindi, continueranno il contatto.
Venerdì mattina presto Isabel mi chiama e mi avvisa che cercherà di viaggiare in giornata per rientrare alla finca dove ancora si trova il figlio più grande. È lui la ragione per la quale lei fa ritorno in foresta.
Durante il suo viaggio, Isabel mi invia vari messaggi Whatsapp. Dopo quel giorno, non ho più saputo nulla.
Angelo Casadei
Archivio MC
● Paolo Moiola, Colombia: Contro l’odio la scommessa del perdono, agosto 2018;
● Paolo Moiola, La pace bussa due volte. Incontro con mons. Luis Augusto Castro, maggio 2017;
● Paolo Moiola (a cura di), Colombia. Un paese alla ricerca della pace, dossier, novembre 2016.
Video su YouTube
● Mauricio A. Montoya Vásquez, 100 preguntas y respuestas Para comprender el conflicto colombiano, 2018;
● Paolo Moiola, La paz llama dos veces. Incontro con mons. Luis Augusto Castro, 2017.