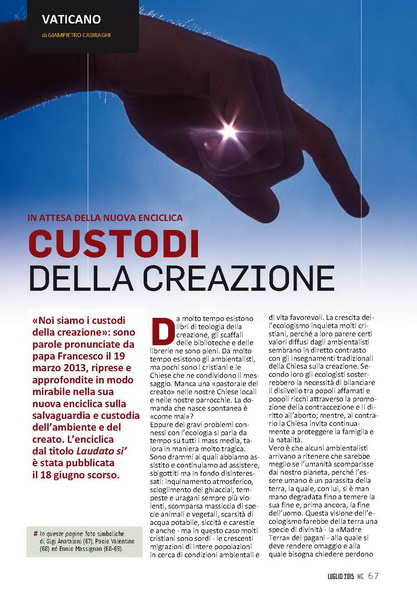Italia-Congo: La lunga marcia per la pace
Lui è un rifugiato congolese in Italia. Dove ha vissuto metà della sua vita. Ha il suo lavoro, vive bene. Ma un giorno succede qualcosa. Il Congo chiama e John sente di dover agire. Ma come? La strada si presenterà da sola, e lui dovrà fare delle scelte. E avere molto coraggio.
John Mpaliza porta con sé un entusiasmo dirompente. Quando lo incontri per la prima volta percepisci intorno a lui un’energia positiva. E ti diventa subito simpatico. È tipico di chi sta a suo agio nella propria pelle. Detto in altre parole, ha trovato la sua strada. Lo conosciamo grazie a una serie di incontri organizzati per lui dall’Ong Cisv di Torino.
Nato a Bukavu, in Kivu, nell’Est dello Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo), 46 anni fa, all’età di 11 anni John va a vivere a Kinshasa da sua sorella maggiore che si è sposata in capitale. Qui frequenta il liceo scientifico Boboto, gestito dai gesuiti, «una delle migliori scuole in Africa centrale», dice, e poi si iscrive all’università a ingegneria. È il 1988-89, anno in cui cade il muro di Berlino. Non c’è né Inteet né tv satellitare. «Ascoltavamo la radio sulle onde corte – ci racconta John -. All’università si riuscivano a creare momenti di confronto». Proprio in quegli anni nascono dei movimenti di dissenso, molto legati a un partito clandestino, l’Udps (Unione per la democrazia e il progresso sociale) di Etienne Tshisekedi, l’attuale maggiore partito di opposizione.
«Una volta fui contattato da qualcuno che mi portò a un incontro segreto e fu così che aderii a questo partito». John inizia a fare attività di propaganda, distribuendo volantini clandestinamente. «Non avevamo computer, si scrivevano a mano e si buttavano nei mercati».
Nel 1990 Mobutu fa un discorso importante: «Comprendete la mia emozione». Permette la creazione di altri partiti. È il multipartitismo. Il momento storico è quello del discorso di La Boule di François Mitterrand, nel quale il presidente francese sancisce che ormai è giunto il momento del multipartitismo per gli stati africani. «Lui diceva che non sarebbe mai stato chiamato “ex presidente”» ricorda John.
«Studiavo e manifestavo. Andai avanti fino al ’91. In quell’anno furono uccisi molti studenti a Kinshasa, Lubumbashi e Kisangani. Io fui tra i fortunati».
Congo addio
Incarcerato con alcuni compagni John rischia grosso, ma viene salvato dalla famiglia. «Vista la corruzione che ormai si era installata, pagando si veniva rilasciati. Da noi, in Congo, si dice: “Un figlio nasce da una madre e un padre, ma viene cresciuto da una società”. Così la mia famiglia allargata è riuscita a fare una colletta per tirarmi fuori e aiutarmi a scappare all’estero».
Il giovane John lascia il Congo proprio nel 1991. «Il mio viaggio è stato di lusso, in aereo, non è paragonabile alle traversate dei migranti di oggi».
John tocca diverse capitali africane, per arrivare a Orano, in Algeria, dove ha degli amici che stanno studiando. «Avevo iniziato gli studi a Kinshasa, così mi sono riscritto all’università, per studiare telecomunicazioni. È stata dura perché nel 1992 il Fis (Fronte islamico di salvezza, gruppo radicale, nda) vinse le elezioni, e la Francia disse che non potevano governare». Sono gli anni in cui infuria il terrorismo algerino, con attentati e bombe nelle città. Il presidente Mohamed Boudiaf viene ucciso in diretta tv: «Io l’ho visto e sono rimasto scioccato».
Così John, nel 1993 decide di fare un viaggio in Europa per andare a visitare degli amici a Parigi, Bruxelles e Roma. In Francia passa anche dalla comunità ecumenica di Taizé, in Borgogna.
«Sulla via del rientro in Algeria, a Roma, dovevo prendere l’aereo ma lo persi. Allo stesso tempo ci fu un attentato all’aeroporto di Algeri. Decisi allora di restare in Italia, anche perché in Algeria c’erano manifestazioni e se la prendevano ancora con gli studenti universitari». Così John Mpaliza chiede asilo politico in Italia e per lui inizia una nuova vita. «Una vita difficile, anche se non posso confrontare quei tempi alla situazione di emergenza attuale. Perché i numeri dei migranti erano diversi, così come la percezione che ne aveva la gente. Anche se la normativa non è cambiata molto».
Una nuova vita
Mpaliza si stabilisce nel Sud Italia dove svolge svariati lavori. Dalla raccolta di pomodori in Puglia, a quella delle arance a Rosao e a Castel Voltuo. Vive pure nella terra dei fuochi. «A Giuliano (in Campania) ho conosciuto gente meravigliosa che mi ha cambiato la vita. Avevo un permesso di soggiorno con divieto di studio e di lavoro. Ma non ricevevo sovvenzioni. Facevo dunque dei lavoretti per sopravvivere. In quel periodo ero presso una famiglia di Giuliano. Ci fu una sanatoria nel ’96. La padrona di casa decise di aiutarmi, mettendomi in regola per farmi avere il permesso di soggiorno. Da lì sono andato a Bologna e poi a Reggio Emilia».
Qui, finalmente, John può tornare a studiare e consegue la laurea breve in ingegneria informatica. Poi inizia a lavorare in comune. Un lavoro che svolgerà per 12 anni.
«Nel 1996 appresi dai media l’invasione dell’esercito ruandese in Congo, con a capo Desiré Kabila (che diventerà presidente del Rdc, nda) e subito telefonai a mia madre. Quando le dissi dove ero, replicò: “Cosa fai in Italia?”. Lo stupore era dovuto al fatto che l’Italia non gode di ottima fama, esporta troppi stereotipi, come la criminalità. In quell’occasione mi dissero che mio padre era morto durante l’ingresso dei soldati ruandesi a Bukavu, perché durante una crisi ipoglicemica, a causa della guerra non si era trovata l’insulina».
Ritoo all’inferno
Nel 2009 finalmente John decide di tornare in Congo, a Kinshasa, per una visita. Non è più tornato in patria dalla sua partenza, anche se ha sempre tenuto i contatti con la famiglia.
Quello che vede lo fa stare male: «Era come un paradiso trasformato in inferno. Il mio paese è un paradiso per le risorse che possiede. Terra fertile, acqua dolce, foresta, ecc. Quando ero piccolo, negli anni ’80, si viveva bene in Congo. Ho trovato tutto distrutto. Forse anche perché ero abituato a vivere in Europa.
Ho saputo di una sorella dispersa nell’Est, stessa sorte per molte cugine. Ho ritrovato mia madre, che si era trasferita a Kinshasa».
Nella guerra in Kivu è stato usato, e lo è tuttora, lo stupro come arma di guerra. Le donne inoltre sono rapite e ridotte in semi schiavitù alla mercé dei miliziani.
«Mia madre allora mi confidò: “Ogni sera prego Dio perché vostra sorella sia morta. È meglio così, piuttosto che soffra troppo”».
Si parla di 8 milioni di vittime in otre 20 anni di conflitto nell’Est del Congo. «Un genocidio dimenticato, ci ricorda John».
Tornato in Italia, dopo tre settimane di Congo, va in crisi.
«Ho vissuto 23 anni in Congo e 23 anni in Italia. Mi sento europeo, ma anche africano. Ritrovarti nelle tue radici e trovare questa situazione è stato un disastro. Avevo gli incubi tutte le notti. Ho provato a scrivere un articolo ma non sono stato considerato dai media». John inizia a maturare l’idea che deve provare a fare qualcosa per il suo paese. Ma cosa? Si chiede. «Qualcosa che desti curiosità, perché l’Africa non fa notizia».
L’ispirazione gli viene proprio dalla sua visita a Taizé di molti anni prima.
«Premetto che io non sono camminatore. Ma a Taizé una ragazza polacca mi aveva detto: se ti piace tanto questo posto, un giorno devi andare a Santiago di Compostela».
Pellegrino per caso
«Decisi di andare a incontrare i pellegrini. Nel 2010, per combinazione, c’era il Giubileo di Santiago. Ho parlato con circa 1.000 persone, di 27 lingue diverse, da 30 paesi. E lì ho capito che camminando e parlando la gente si ferma ad ascoltare». John parla di Congo, guerra, stupri, saccheggio delle risorse. Ma non ha ancora le idee chiare. È il raccontare quello che ha vissuto nel suo recente viaggio a Kinshasa.
«Nel frattempo, in Italia, avevo preparato una documentazione, e i miei dirigenti al lavoro volevano aiutarmi presentandomi a un politico. Ma in quel momento c’era crisi quindi non successe a nulla».
Ancora un altro segnale. «Nel febbraio 2011, una ragazza da Sidney mi chiamò su skype. L’avevo conosciuta al Cammino di Santiago. Era arrabbiata perché io non avevo fatto ancora nulla per il Congo, mi disse. Era un’insegnante e al suo rientro dalla Spagna aveva fatto lavorare i suoi studenti sul tema dello sfruttamento dei minerali del Congo.
Una persona su 1.000 si era attivata a causa di quello che le avevo raccontato. Forse qualcosa poteva cambiare. Decisi di organizzare una marcia da Reggio Emilia a Roma e portare la documentazione ai palazzi del potere. Avevo coinvolto la città: comune, provincia, la scuola di pace di Reggio, il centro missionario. La gente seguiva. Ero andato a parlare su Tele Reggio. Feci una marcia di 21 giorni e mi ricevettero alcuni deputati e senatori».
È la prima marcia di John Mpaliza per il Congo, che ne inaugura una lunga serie, in un crescendo di difficoltà. E, soprattutto, diventerà il modo di vivere e di lottare del congolese-italiano, dalla simpatia irresistibile.
On the road
Come si organizza una marcia per la pace in Congo?
«Si definisce la partenza e l’arrivo. Si prendono contatti con le istituzioni locali lungo il percorso, gli scout, le chiese, le scuole. Così nascono gli incontri. Le persone mi accompagnano per un pezzo della strada. Talvolta vengono ad accogliermi alle porte di una città al mio arrivo. Ma la marcia completa la faccio da solo.
A Roma, ad esempio, una quarantina di persone mi aspettarono fuori città e mi accompagnarono fino in Parlamento».
Segue nel 2012 la marcia Reggio Emilia – Bruxelles, di due mesi. John passa a Ginevra dove incontra l’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite. Va anche a Strasburgo dove è ricevuto da parlamentari italiani ed europei. Molti di loro sono promotori dell’emendamento del maggio 2015 sulla tracciabilità dei minerali (si veda il dossier su MC luglio 2015). «Per la prima volta abbiamo chiesto una regolamentazione. C’erano anche congolesi dal Belgio e italiani nella marcia».
Il grande salto
«All’inizio le marce le facevo in estate, durante le vacanze. Oppure, nel caso dovessero durare oltre un mese, prendevo aspettativa dal lavoro. I miei dirigenti erano comprensivi e mi appoggiavano».
Tornato casa dalla marcia di Bruxelles, John si trova sommerso dalle richieste di incontri e conferenze.
Nel novembre del 2012 decide di prendere un part time verticale: alcuni giorni della settimana lavora in ufficio, durante gli altri fa incontri sul Congo, i minerali della guerra, le vie della pace. La sua vita sta cambiando. «Cominciai a chiedermi se fosse questa la via che dovevo seguire. A dicembre 2013 mi sono ammalato e ho capito che questo sistema non reggeva. Così ho spiegato al dirigente che il mio futuro non era più con loro.
Inoltre, la notizia della marcia di Bruxelles era arrivata anche in Congo. I miei famigliari avevano fatto una veglia di preghiera nel paese. Si raccoglievano i primi frutti, perché ormai se ne stava parlando. Mollare, sarebbe stata la dimostrazione che noi (africani) non sappiamo costruire».
John decide di lasciare il lavoro il 31 maggio 2014 e di consacrarsi totalmente alla causa. A luglio parte la marcia Reggio Emilia – Reggio Calabria.
Da quando ha lascia il lavoro John non ha più un reddito. Organizza marce, cammina e fa incontri in scuole, università, parrocchie e istituzioni. Vive di accoglienza e provvidenza.
«Ho deciso di rinunciare a tutto – ricorda – ma devo vedere quando mi sento in forma e posso camminare, fare le cose a modo mio. Ho collaborato con tante organizzazioni, come Rete pace per il Congo, creata dai missionari Saveriani di Parma. Ora mi appoggia anche Libera Internazionale. Non ho ancora fondato un’associazione, ma ci stiamo arrivando. Potrebbe servire per gestire eventuali donazioni».
John approfondisce le rivendicazioni delle sue marce. «L’obiettivo principale è rompere il silenzio, fare breccia. Fare conoscere il dramma congolese, denunciare l’assenza di diritti umani, la guerra economica che produce morti, lo stupro come arma di guerra. I danni che creano i caschi blu dell’Onu, che costano due milioni di dollari al giorno».
I progetti
John ci parla degli incontri: «I giovani a cui parlo sono talmente tanti che tutto questo non può non produrre qualcosa!», ci dice con entusiasmo.
«Voglio spiegare il rapporto che c’è tra noi e quel mondo in Congo». Rapporto che passa dal telefonino che ognuno possiede. «Sì. Non c’è ragazzino che non sia coinvolto. Tutti abbiamo a che fare con i minerali come il cobalto. Per questo parlo della “guerra che abbiamo in tasca”».
I ragazzi si coinvolgono anche con azioni pratiche. «Abbiamo lanciato dei progetti – spiega John – con scuole in Trentino e nel padovano. I ragazzi fanno raccolte di telefonini, per il riciclo. In effetti si può recuperare parte del minerale dall’apparecchio dismesso. È una ricchezza che abbiamo in tasca, anche quando si rompe, senza saperlo. È una miniera d’oro. Ad esempio l’Arpa del Friuli Venezia Giulia collabora con un’azienda svizzera che recupera l’oro dai telefonini».
La normativa in stallo
Oltra alla testimonianza, ovvero «raccontare, spiegare la nostra responsabilità» per formare l’opinione pubblica, è molto importante anche il livello istituzionale.
«Perché comunque abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a far passare una legge sulla certificazione dell’origine dei minerali con i quali si produce l’elettronica di consumo».
Gli Stati Uniti si sono dotati di una legge, nel 2010, la Dodd-Frank Act (vedi dossier MC luglio 2015), mentre l’Unione europea è in una fase di «negoziazione».
«La situazione è complicata. Il Parlamento europeo si è espresso il 20 maggio 2015 rendendo più restrittiva la proposta della certificazione volontaria. In realtà quello è stato il primo round, ora gli stati devono ratificare. In Italia c’è la Focsiv che porta avanti la “Campagna europea sui minerali dei conflitti” (vedi box) e che collabora con Rete pace per il Congo ed Eurac del Belgio».
John è deluso anche del comportamento dell’Italia: «Ero certo, sulla base dei miei contatti, che l’Italia avrebbe subito ratificato. Ma ho appreso che mentre il ministero degli Affari esteri è d’accordo, il ministero dello Sviluppo economico è contrario. Inoltre a dicembre è iniziato un negoziato trilaterale tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea. Io non sono un negoziatore, e ho paura che diventi un nulla di fatto».
Oltre l’importante questione normativa, John scende più in profondità, per eradicare le cause: «Non basta la legge sulla certificazione dei minerali. Serve la stabilità in questi paesi. Se ci fosse uno stato che mettesse delle regole, le compagnie dovrebbero rispettarle e il livello dei problemi sarebbe diverso. Nelle miniere potrebbero lavorare solo adulti, non i bambini, e in certe condizioni di sicurezza. E soprattutto queste risorse andrebbero a beneficio del popolo del Congo e non del Rwanda o dell’Uganda che le stanno sfruttando senza controllo. E si vivrebbe un po’ meglio in Congo».
Nel 2015 John realizza la marcia da Reggio Emilia a Helsinki. Percorre a piedi 3000 km attraversando l’Europa in cinque mesi, da maggio a ottobre. «In Finlandia sono stato ricevuto da funzionari del ministero degli Esteri.
La marcia, richiesta da cittadini finlandesi che avevo incontrato a Varsavia, aveva l’obiettivo di incontrare la Nokia, che nel frattempo, a causa della crisi, era stata comprata di Microsoft. Ai finlandesi interessano molto le tecnologie. Io ho detto loro che sarebbe importante far capire ai cittadini da dove vengono i materiali per produrre i dispositivi. Loro temono che una legge di certificazione porterebbe a un aumento dei prezzi per i cittadini».
Obiettivo Africa
John è tornato in Congo in segreto nel 2014, perché sua madre e sua sorella non stavano bene. Ormai la sua lotta è conosciuta e rischia per la sua sicurezza personale. Ha un altro grande sogno che sta diventando un progetto: una marcia panafricana, che lo porti nel suo paese.
«A fine ottobre vorrei fare Reggio Emilia – Roma. Qui parteciperei a degli incontri durante la settimana internazionale per i diritti umani. Da Roma volerei a Città del Capo in Sudafrica. Da lì voglio risalire verso il Mozambico, la Tanzania e Zanzibar. Per poi attraversare la Tanzania verso Ovest per arrivare nell’Est della Repubblica democratica del Congo. Se ci riusciamo! Occorre lavorare con i movimenti della società civile, le chiese, le associazioni europee e africane. Bisogna creare una specie di scudo, perché camminare in Africa è più difficile!».
Marco Bello








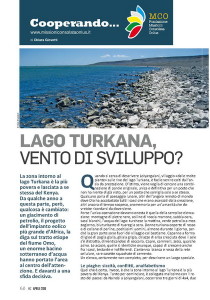
.JPG)

.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
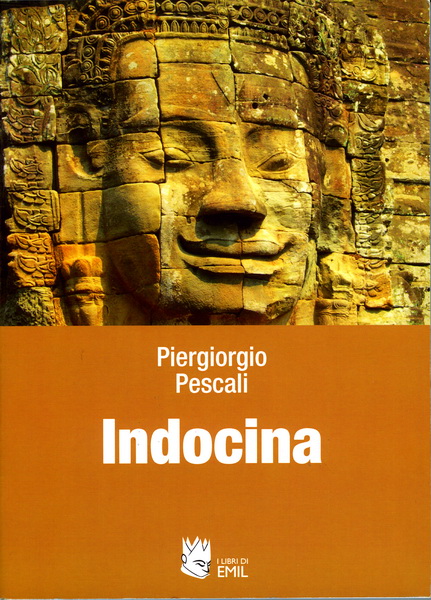 • Piergiorgio Pescali – Gioalista e scrittore, si occupa di Estremo Oriente, in particolare di Sud Est Asiatico, penisola coreana e Giappone. Suoi articoli e foto sono stati pubblicati da Bbc, Cnn, Avvenire, Il Manifesto, Panorama e riviste specializzate. Dal 2010, cura per Asia Maior (www.asiamaior.org) il capitolo sul Myanmar. Ha scritto il saggio Indocina, Edizioni Emil, Bologna 2010.
• Piergiorgio Pescali – Gioalista e scrittore, si occupa di Estremo Oriente, in particolare di Sud Est Asiatico, penisola coreana e Giappone. Suoi articoli e foto sono stati pubblicati da Bbc, Cnn, Avvenire, Il Manifesto, Panorama e riviste specializzate. Dal 2010, cura per Asia Maior (www.asiamaior.org) il capitolo sul Myanmar. Ha scritto il saggio Indocina, Edizioni Emil, Bologna 2010.