Cubetti di zucchero
 Racconto / in collaborazione con LINGUA MADRE
Racconto / in collaborazione con LINGUA MADRE«Il valore delle cose
non sta nel tempo in cui esse durano ma nell’intensità con cui vengono vissute.
Per questo esistono momenti indimenticabili, cose inspiegabili e persone
incomparabili». (Feando Pessoa)
 Mia nonna matea Nura e suor Vilma trascorrevano insieme ogni
Mia nonna matea Nura e suor Vilma trascorrevano insieme ogni
sabato mattina. Caffè, tante chiacchiere e un’infinità di sorrisi che, al
ricordo, scaldano la mia anima ancora oggi. Erano ciascuna la migliore amica
dell’altra ed è veramente difficile descrivere l’atmosfera che si creava quando
quelle due grandi donne stavano insieme nella stessa stanza. Accadeva come se
il senso di tutte le cose del mondo fosse concentrato proprio lì, nei 36 metri
quadrati dell’amato appartamento. E noi quattro, i miei genitori, mio fratello
e io, abitavamo lì in quegli anni, fino a quando l’azienda di mio padre non ci
assegnò un appartamento tutto nostro. Quelle mattine di sabato, dunque,
rappresentavano un vero e proprio rituale.
Ancora
prima dell’arrivo di suor Vilma, tutti, come per magia, scomparivano per
qualche commissione, a parte me che, essendo la più piccola, rimanevo avvolta
nel calore di quei momenti, quasi mi ritrovassi immersa nelle soffici nuvole
bianche illuminate dal sole, un sole che altro non era che l’aria che in quel
momento respiravo. Immancabilmente quell’aria si mescolava all’inconfondibile
profumo del caffè fatto «alla turca» che ha tutto un suo modo per essere
bevuto: prima si mette in bocca un cubetto di zucchero inzuppato nel caffè
rigorosamente versato in una tazzina detta fildžan (si pronuncia «filgian»)
che non ha un manico ma è tonda e si avvolge con la mano in modo da percepire
il calore della bevanda. Subito dopo si prende un sorso di caffè che si mescola
con il cubetto di zucchero sciolto in bocca, ma molto lentamente, tra una
parola e l’altra, fino ad arrivare al fondo il quale, certamente, non è
intelligente bere. Ci si ferma sempre al momento giusto, è nel sangue del
popolo, non c’è che dire! E allora si riempie fildžan di nuovo e avanti
così.

sabato mattina, quindi, suor Vilma, suora crornato-cattolica, veniva a trovare
mia nonna, atea di origini musulmane. E di che cosa queste due donne,
apparentemente così diverse nelle loro culture, potevano parlare ogni sabato?
Del come avevano trascorso la settimana, della moda (mia nonna era sarta) che
le ricche signore della città seguivano alla lettera, di catacombe (suor Vilma
aveva visitato il Vaticano ben tre volte), della poesia di un poeta che entrambe
amavano molto, del come si prepara un piatto tipico dell’Erzegovina… Sì, di
questo e di tanto altro, ma spesso non erano le tematiche ad attirare la mia
attenzione quanto l’armonia nella quale venivano trattate e la forma, di un
rispetto dalla dinamica straordinaria. Era musica per le mie orecchie. Come
incantata, mi ritrovavo a guardare i cubetti di zucchero scomparire dalla
ciotola piano piano, quasi il loro compito fosse quello di cadenzare il tempo. «Prendine
uno e inzuppalo nella mia tazzina», mia nonna richiamava la mia presenza a
tavola nella sua piccola cucina e io, seduta su una sedia con l’aiuto di un
cuscino, iniziavo allora a gustarmi quella delizia proibita.
Accadeva
poi che a volte si unisse a loro teta Vida (teta equivale a «zia»
ed è un modo tipico di rivolgersi a tutte le donne adulte conoscenti o amiche
di famiglia). Teta Vida, dunque, laica per eccellenza, era una signora
di origine serbo-ortodossa dall’eleganza ineguagliabile. Gonne plissé, a
scacchi neri e bianchi, giacchettine di velluto nero, guanti raffinati,
berrettini francesi e l’immancabile ombrello, a meno che non fosse estate. Il
tutto indossato con la grazia di una figura alta e snella illuminata da un
sorriso ammaliante che nei suoi occhi chiarissimi rifletteva la pace. E non
parliamo della sua vasca da bagno! Era più piccola di quella che aveva mia
nonna ma a forma di poltrona e quindi di gran lunga più comoda. Io la adoravo
ed era, infatti, teta Vida a fare sempre il bagno alla sua Nanà, come
lei mi chiamava. In poche parole, ero la sua prediletta. Abitava proprio
nell’appartamento di fronte, al primo piano di un palazzo dall’architettura
socialista che sorgeva nel cuore di Sarajevo. A pochi passi, il mondo intero:
la cattedrale cattolica, quella ortodossa, la moschea tra le più antiche della
città e la sinagoga. Insomma, una Gerusalemme in miniatura! Attorniate poi da
un’infinità di palazzi di tutte le epoche: turco-ottomana, austroungarica,
socialista.
Ma se
questo mondo io lo vedevo all’esterno, è dentro casa nostra che lo percepivo
nelle sue essenze. Sento ancora negli occhi i loro sorrisi, vedo ancora le
parole scorrere sulle loro labbra quando vengo distratta dal forte picchiare
sulla porta di un bastone. Eh sì, era teta Anita, una professoressa di
geografia in pensione, profondamente devota alla propria tradizione ebraica e
altrettanto incuriosita da tutte le altre. Un essere tanto ingombrante nella
propria fisionomia quanto delicato nel modo di parlare: «Queste sono un dono
raro, che non ti venga in mente di sfoltirle quando sarai grande!», mi diceva
sempre, accarezzando delicatamente le mie folte sopracciglia. Scesa dal quarto
piano dello stesso palazzo, questa alquanto insolita vicina di casa, a volte,
in segno di un saluto, picchiava sulla porta e se ne andava via, fuori, a farsi
la sua lenta passeggiata quotidiana. Ma se picchiava più di due volte, voleva
dire che anche lei era lì per un caffè e due parole. Ed ecco che mi ritrovavo
il mondo intero in casa nostra ogni sabato mattina.
Quattro
culture, o cinque o sei, tra origini,
idee, convinzioni e pensieri. Insomma, una vera macedonia. E quale raro gusto
aveva questa macedonia, e tutta per me! Vita raccolta in quattro menti, anime e
cuori nella purezza di quell’umanesimo che incoronava la loro umanità. Tanta
semplicità vedo oggi in quei preziosi momenti, che è stata, in fondo, il vero
filo conduttore della loro esistenza. L’amicizia che scorreva in tutti quegli
anni tra i personaggi di questo racconto raffigura un’anima, l’unica anima di
un mondo che non c’è più. Quale magnifico folclore colorava l’aria e quanta
poeticità esprimevano quegli azzurri occhi di suor Vilma nel guardare mia nonna
con tanta stima e ammirazione. Due donne così apparentemente diverse, una sarta
e una suora. Ecco, mi fermerei a queste definizioni e null’altro conta. Si
erano conosciute all’ospedale di Sarajevo; una cuciva le lenzuola e l’altra
assisteva i malati, all’interno di un sistema guidato da un ideale politico che
nessuna delle due aveva mai abbracciato ma con il quale entrambe avevano convissuto
in pace e nel rispetto. Era come se viaggiassero su un binario parallelo, a un
ritmo tutto loro e a una velocità misurata. Puro teatro erano questi due
personaggi, e nasceva dal nulla.
Immaginatevi
la scena in cui mia nonna prende le misure per il suo abito da religiosa mentre
le dà notizie dei suoi generi, uno italiano e l’altro un comunista di origine
serba, nonché mio padre. Le Nozze di Figaro nasce da un’idea simile:
inizia con una scena in cui Figaro misura la stanza per vedere se dentro ci può
stare un letto nuziale, capite? E quanto parlare di una figlia così lontana e
di un’altra in casa ma così criptica, mentre nel frattempo suor Vilma cercava
di capire il modo migliore per tenere su il suo copricapo ingombrante. Ma
allora, dico io, ho vissuto su un palcoscenico per diciotto anni e mia nonna e
suor Vilma ne sono testimoni? Quale strepitosa pièce teatrale è mai
questa? È forse vero che quando il teatro diventa la nostra casa, esso diventa
anche la nostra realtà? E se questa era la mia realtà, allora la mia vita non è
stata che una commedia, un dramma, un dialogo oppure un monologo?

Se ci
penso, in ognuno di questi modi oggi potrebbe definirsi quello che è stata
l’ormai dimenticata Jugoslavia. Quanto alla Bosnia Erzegovina, non è che una
parte del puzzle di un racconto irraccontabile. Sarajevo ne è un pezzo. Nura e
Vilma, invece, un prezioso dipinto all’interno di quel pezzo del puzzle mentre
quei momenti, in cui mi immergevo come nelle più accoglienti delle acque, sono
oggi per me il viaggio eterno. Mi giro e rivedo tutto, ascolto e sento tutto,
annuso e percepisco ogni profumo, odore, l’aria di un mondo che si è sciolto
come un cubetto di zucchero inzuppato nel caffè lasciandomi l’inestimabile
ricordo del suo gusto. Custode di attimi, vado avanti nel silenzio che possiamo
sentire soltanto camminando nella notte, lungo le strade coperte di neve di una
città che accoglie ogni fiocco, gentile e discreta. Ah, che freddo generoso di
vita sulle guance. E che pace la neve mentre cade armoniosa come il sipario che
si chiude con grazia.
 Il
Il
concorso letterario nazionale Lingua
Madre, ideato da Daniela Finocchi,
giornalista da sempre interessata ai temi inerenti il pensiero femminile, nasce
nel 2005 e trova subito l’approvazione e il sostegno della Regione Piemonte e
del Salone Internazionale del Libro di Torino.
Il concorso è il primo a essere espressamente dedicato alle
donne straniere – anche di seconda o terza generazione – residenti in Italia
che, utilizzando la nuova lingua d’arrivo (cioè l’italiano), vogliono
approfondire il rapporto fra identità, radici e mondo «altro». Una sezione
speciale è riservata alle donne italiane che vogliano raccontare storie di
donne straniere che hanno conosciuto, amato, incontrato e che hanno saputo
trasmettere loro «altre» identità.
Il concorso letterario vuole essere un’opportunità per dar voce
a chi abitualmente non ce l’ha, cioè gli stranieri, in particolare le donne che
nel dramma dell’emigrazione/immigrazione sono discriminate due volte.
Un’opportunità di incontro e confronto, perché il bando non solo ammette ma
incoraggia la collaborazione fra le donne straniere e italiane nel caso l’uso
della lingua italiana scritta presenti delle difficoltà.
Per
gentile concessione del Concorso letterario nazionale Lingua
Madre pubblichiamo il racconto di: Sabina Gardovic, Cubetti di
zucchero, dal
libro «Lingua Madre Duemilaquattordici – Racconti di donne straniere in Italia», Edizioni SEB27. Il racconto di Sabina
Gardovic è stato selezionato al IX Concorso letterario nazionale Lingua Madre.
tags: racconto, Boia Erzegovina, amicizia, dialogo, folclore
Sabina Gardovic








 La Sindone è stata finora conservata arrotolata in una
La Sindone è stata finora conservata arrotolata in una




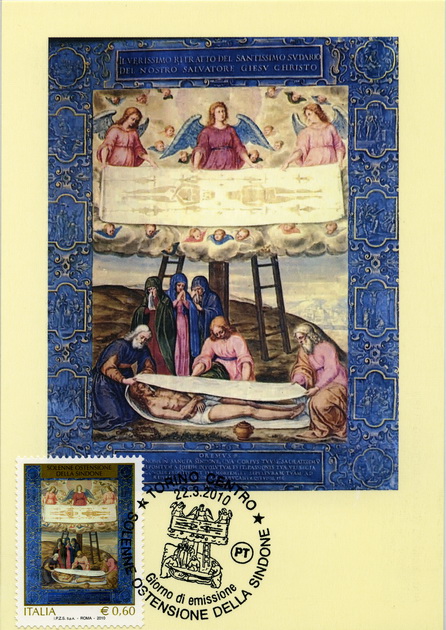
 Toiamo a parlare di
Toiamo a parlare di

 Alcuni villaggi sulle colline a sud di Hebron, in Area C
Alcuni villaggi sulle colline a sud di Hebron, in Area C



