I Perdenti 8. ANTÔNIO Conselheiro di Canudos

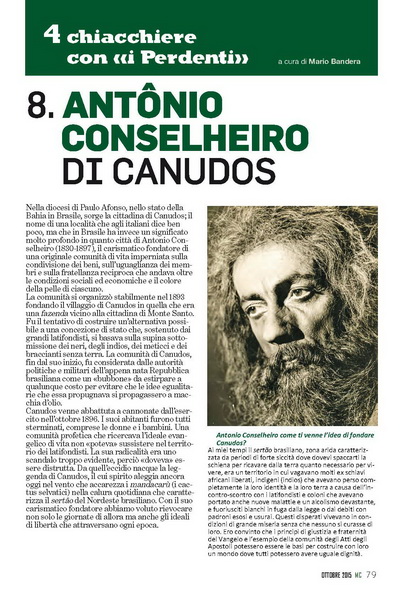 Nella
Nella
diocesi di Paulo Afonso, nello stato della Bahia in Brasile, sorge la cittadina
di Canudos; il nome di una località che agli italiani dice ben poco, ma che in
Brasile ha invece un significato molto profondo in quanto città di Antonio
Conselheiro (1830-1897), il carismatico fondatore di una originale comunità di
vita impeiata sulla condivisione dei beni, sull’uguaglianza dei membri e
sulla fratellanza reciproca che andava oltre le condizioni sociali ed
economiche e il colore della pelle di ciascuno.
La
comunità si organizzò stabilmente nel 1893 fondando il villaggio di Canudos in
quella che era una fazenda vicino alla cittadina di Monte Santo. Fu il
tentativo di costruire un’alternativa possibile a una concezione di stato che,
sostenuto dai grandi latifondisti, si basava sulla supina sottomissione dei
neri, degli indios, dei meticci e dei braccianti senza terra. La comunità di
Canudos, fin dal suo inizio, fu considerata dalle autorità politiche e militari
dell’appena nata Repubblica brasiliana come un «bubbone» da estirpare a
qualunque costo per evitare che le idee egualitarie che essa propugnava si
propagassero a macchia d’olio.
Canudos
venne abbattuta a cannonate dall’esercito nell’ottobre 1896. I suoi abitanti
furono tutti sterminati, comprese le donne e i bambini. Una comunità profetica
che ricercava l’ideale evangelico di vita non «poteva» sussistere nel
territorio dei latifondisti. La sua radicalità era uno scandalo troppo
evidente, perciò «doveva» essere distrutta. Da quell’eccidio nacque la leggenda
di Canudos, il cui spirito aleggia ancora oggi nel vento che accarezza i mandacarù
(i cactus selvatici) nella calura quotidiana che caratterizza il sertão
del Nordeste brasiliano. Con il suo carismatico fondatore abbiamo voluto
rievocare non solo le giornate di allora ma anche gli ideali di libertà che
attraversano ogni epoca.
Antonio Conselheiro come ti venne l’idea
di fondare Canudos?
Ai miei tempi il sertão brasiliano, zona arida
caratterizzata da periodi di forte siccità dove dovevi spaccarti la schiena per
ricavare dalla terra quanto necessario per vivere, era un territorio in cui
vagavano molti ex schiavi africani liberati, indigeni (indios) che avevano
perso completamente la loro identità e la loro terra a causa
dell’incontro-scontro con i latifondisti e coloni che avevano portato anche
nuove malattie e un alcolismo devastante, e fuoriusciti bianchi in fuga dalla
legge o dai debiti con padroni esosi e usurai. Questi disperati vivevano in
condizioni di grande miseria senza che nessuno si curasse di loro. Ero convinto
che i principi di giustizia e frateità del Vangelo e l’esempio della comunità
degli Atti degli Apostoli potessero essere le basi per costruire con loro un
mondo dove tutti potessero avere uguale dignità.

Se non vado errato, in quei tempi nel sertão
brasiliano si muovevano molte figure carismatiche.
È vero, predicatori del Vangelo ce n’erano in abbondanza, ma il
personaggio che più di ogni altro ha incarnato l’anima nordestina, è stato
Padre Cicero (Romão Batista, 1844-1934, zelantissimo sacerdote considerato
santo dai nordestini, anche se morto ufficialmente scomunicato. Oggi il vescovo
della diocesi di Crato nel Cearà ne ha avviato il processo di riabilitazione, ndr),
che percorse il sertão in lungo e in largo, a piedi o in groppa a umili
somarelli per migliaia di chilometri sotto il sole cocente per predicare,
confessare e celebrare l’Eucarestia in posti dove nessun sacerdote aveva messo
mai piede. Per noi, abitanti del sertão, è stato un sacerdote santo e
capace di miracoli e accorrevamo da ogni parte per ascoltarlo, confessarci e
mettere a posto la coscienza.
E tu come ti collocasti in questa realtà?
Considerando la violenza imperante ai miei tempi in quella zona,
ebbi l’idea di creare una comunità in cui si vivesse radicalmente l’ideale
evangelico, cominciai così ad accogliere gli ex schiavi (circa l’80% della
comunità) e gli indigeni sbandati.

Ma c’erano anche bianchi nella tua comunità?
Certamente. C’erano marinai che si erano ammutinati sulle loro
navi, in fuga dalla dura disciplina che regnava a bordo e che, una volta a
terra, avevano trovato rifugio nel sertão. Così c’era anche chi, avendo
problemi con la legge, non poteva più rimanere nelle città e si rifugiava
nell’interno disabitato, nella caatinga autentico cuore del sertão
(caatinga, lett. foresta grigia, è l’unico bioma esclusivamente
brasiliano e si trova solo negli stati del Nordeste, ndr). Erano tutti
accomunati da uno stato di povertà e di esclusione sociale. Non per questo
erano tutti pacifici e inermi. Tra loro c’era anche gente dura, abituata a
combattere per sopravvivere.
Dal 1877 il Nordeste fu colpito da una
delle sue tipiche devastanti siccità aggravando gli effetti di una crisi
economica e sociale già molto grave.
Si, migliaia di persone (banditi, flagellanti, miserabili senza
terra) vagavano affamate senza alcun aiuto dal governo, contando solo
sull’aiuto divino. Ma la miseria è una pessima consigliera, così molti,
ritenendo che «rubare per ammazzare la fame» non fosse peccato, assaltavano le
grandi fazendas e i piccoli proprietari.
In più, a partire dal 1888, quando in Brasile fu ufficialmente
abolita la schiavitù, molti ex schiavi, tutti di origine africana, si
ritrovarono allo sbando senza nessuna risorsa e, quel che è peggio, senza una
terra su cui vivere.
Vedendo questa gente vagabondare senza meta nel sertão,
cominciai a radunarla in un nuovo piccolo villaggio chiamato appunto Canudos,
in un territorio disabitato, dove ognuno riceveva un pezzo di terra da
coltivare e metteva poi a disposizione dell’intera collettività i prodotti
ricavati dal suo lavoro. Ciò permetteva loro di guardare con speranza al
futuro.

Canudos divenne quindi un punto di
riferimento importante per molti disperati.
Alla fine del 1800, Canudos poteva contare su un totale di circa
30mila abitanti. Il movimento popolare che avevamo avviato ispirandoci al
Vangelo, crebbe rigogliosamente. Eravamo ben organizzati, quasi una «comune»
religiosa. Canudos era diventata la seconda città della Bahia, dopo Salvador.
Le autorità politiche e anche religiose, però, cominciarono ben presto a
preoccuparsi di una presenza così scomoda e autonoma che di fatto non
riconosceva il governo centrale, non pagava le tasse, si autogestiva
collettivamente e aveva leggi proprie.
Erano gli anni in cui il Brasile si era
appena staccato definitivamente dalla monarchia portoghese per diventare una
Repubblica a tutti gli effetti.
Il Brasile era diventato indipendente dal Portogallo nel 1822 e si
era dato una monarchia costituzionale, ma l’imperatore Pietro II era della
stessa famiglia del monarca del Portogallo. Negli anni era cresciuto un forte
movimento repubblicano che aveva contagiato anche l’esercito, il quale nel 1889
depose l’imperatore con un golpe militare. C’era quindi, in quegli anni, un
clima politico sociale caratterizzato da una cronica instabilità istituzionale,
la nuova Repubblica cercava di rafforzarsi e Canudos era fuori dal sistema,
anzi a qualcuno sembrava una roccaforte di restaurazione monarchica.
Tu, Antonio, eri favorevole alla nuova
Repubblica o eri un nostalgico dell’impero?
Fuori dal mondo come eravamo là nel sertão, la questione
non ci toccava molto. Non avevo certo molte simpatie per i repubblicani i quali
avevano separato – per me in un modo anticristiano – Chiesa e Stato, ma non ho
mai pensato di fomentare una restaurazione. Purtroppo è anche vero che la
Repubblica non fece molto per farsi amare dai poveri, anche se erano stati i
repubblicani a far abolire la schiavitù. Ma gli ex schiavi erano stati
abbandonati a se stessi e uno dei primi atti della Repubblica era stato un
pesante aumento delle tasse sia sulla terra che su tutti i prodotti. E, come al
solito, chi ci rimetteva di più erano i più poveri, non i ricchi.

Il tuo progetto poteva sembrare a molti la
realizzazione di un sogno, ma le autorità brasiliane non erano certamente
disposte a lasciare una zona franca nel bel mezzo del sertão.
Purtroppo era cosi! Accusandoci di essere ribelli e monarchici,
tra il 1896 e il 1897 mandarono ben quattro spedizioni militari contro di noi.
La resistenza di Canudos fu straordinaria. C’è da dire che, oltre al coraggio
della comunità, potevamo contare su uomini valorosi dall’invidiabile acume
tattico e una profonda conoscenza della natura aspra e impervia del sertão
nel quale i soldati, provenienti dalle città della costa, erano impreparati a
sopravvivere. Respingemmo facilmente le prime due spedizioni e anche la terza,
ma con perdite pesantissime.
Ma il vostro desiderio di vivere in pace e
armonia, liberi da ogni legge eccetto quella di Dio, non poteva durare…
 Sì, e in più l’esercito repubblicano si era sentito umiliato da
Sì, e in più l’esercito repubblicano si era sentito umiliato da
straccioni come noi. Così l’ultima spedizione fu organizzata con molta cura
dallo stesso ministro della guerra, il maresciallo Carlos Machado Bittencourt.
Furono messi in campo circa 4.000 soldati con le armi più modee del tempo.
L’attacco cominciò a settembre. La mia gente era provata da fame e
denutrizione, male armata, senza scorta di munizioni e demoralizzata dalla mia
morte avvenuta il 22 settembre 1897 a seguito di molti giorni di penitenza,
preghiera e digiuno per la pace. Dopo un terrificante bombardamento durato
diversi giorni che incendiò le case e rase al suolo Canudos, la maggioranza dei
superstiti si arrese il 5 ottobre, ma i soldati sterminarono ugualmente uomini,
donne e bambini tra terribili violenze. Di circa 30mila persone della comunità,
ufficialmente ci furono solo 150 superstiti. Di essi le donne giovani furono
vendute nei bordelli di Bahia. Il mio corpo fu riesumato e la mia testa
tagliata e fatta esaminare dagli scienziati per provare che ero stato un matto
fanatico. Messa poi nel Museo della Scuola di Medicina di Salvador, un
incendio, più pietoso degli uomini, la consumò nel 1905.
L’unica relazione sulla «guerra di Canudos» ci è pervenuta tramite
gli scritti di Euclides da Cunha, corrispondente del giornale O Estado de São
Paulo, che era stato inviato nel sertão brasiliano al seguito dell’esercito
(embedded, si direbbe oggi). Con il passare del tempo i luoghi della
battaglia di Canudos caddero nel dimenticatornio dell’imbarazzo collettivo e la caatinga
ebbe il sopravvento.
Ma la memoria storica dell’esperienza di Antonio Conselheiro e
della sua comunità non è mai scomparsa e si è tramandata nei racconti della
gente semplice e umile del sertão fino a quando è stata recuperata tra
le pieghe della storia e le è stata ridata la sua importanza, grazie anche a
libri e film (purtroppo non tradotti in italiano, ndr). Si può dire che
lo spirito di Canudos scorre ancora oggi come un fiume carsico sotto la crosta
dura e solida dell’arida terra del sertão, dove i nordestini imparano
fin dalla nascita che devono misurarsi con le asprezze della natura e con i
cataclismi sociali che i potenti di tuo ciclicamente rovesciano loro addosso.
Questa gente speciale ha bisogno di esempi di libertà e figure eccezionali per
continuare a sperare, Canudos e Antonio Conselheiro proprio per l’ansia di
libertà che incarnano, indicano ancora oggi la strada da percorrere.
Don Mario Bandera,
Missio Novara
Mario Bandera



.jpg)
.jpg)





.jpg)


.jpg)

 Il Mozambico affronta, questo mese di ottobre, la sua quinta elezione presidenziale dal 1994, anno dell’introduzione del multipartitismo dopo una devastante guerra civile durata vent’anni e conclusa con la pace di Roma del 1992. In queste pagine racconto il viaggio che, come responsabile dell’ufficio progetti della MCO, ho fatto lo scorso giugno nel paese lusofono. Una panoramica sulla situazione politica e qualche istantanea della quotidianità nelle missioni.
Il Mozambico affronta, questo mese di ottobre, la sua quinta elezione presidenziale dal 1994, anno dell’introduzione del multipartitismo dopo una devastante guerra civile durata vent’anni e conclusa con la pace di Roma del 1992. In queste pagine racconto il viaggio che, come responsabile dell’ufficio progetti della MCO, ho fatto lo scorso giugno nel paese lusofono. Una panoramica sulla situazione politica e qualche istantanea della quotidianità nelle missioni.






