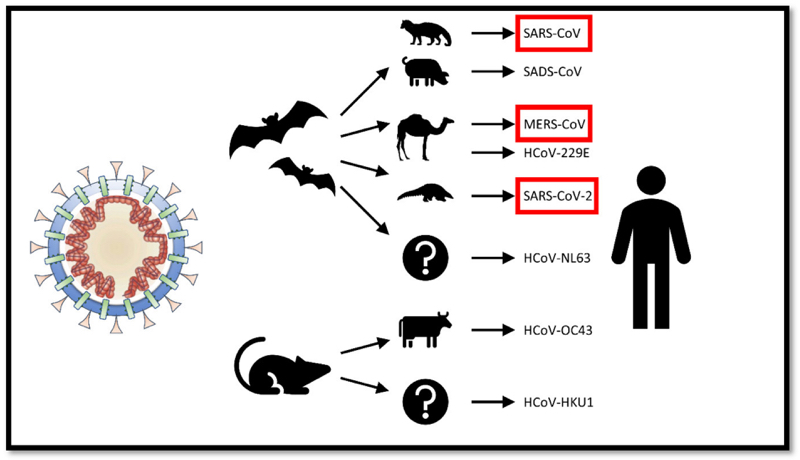La plastica è nel nostro piatto
Il problema più grave è quello non visibile a occhio nudo: le microplastiche. Ormai esse si trovano ovunque: nelle acque, nei terreni, nelle nevi ad alta quota. Nei prodotti d’igiene. E nel nostro cibo.
*la prima parte di questo articolo è in MC aprile 2020
La visione di ammassi di plastica galleggianti in acqua o dispersi per terra, solitamente suscita più clamore di una forma d’inquinamento molto più insidiosa, quella da microplastiche. La loro dispersione nell’ambiente è legata principalmente a due diverse fonti.
Una è rappresentata dalla manifattura di prodotti plastici, che usa come materia prima piccoli granuli di resina chiamati «pellets», «nibs» e «microbeads». Questi ultimi possono essere dispersi accidentalmente nell’ambiente durante il trasporto, a seguito di un uso inappropriato dei materiali da imballaggio o per deflusso diretto dagli impianti di trasformazione. In seguito al dilavamento dei terreni dovuto alle piogge, questi materiali possono finire negli ecosistemi acquatici.
La seconda fonte sono i rifiuti in plastica abbandonati nell’ambiente e soggetti a vari tipi di degradazione: la fotodegradazione ad opera della radiazione solare; la biodegradazione compiuta da organismi viventi, soprattutto microbi; la degradazione termossidativa a temperatura modesta, quella termica ad alta temperatura e l’idrolisi dovuta alla reazione con l’acqua.
I principali composti chimici presenti nelle plastiche sono il polietilene, il polipropilene, il polistirene, il polietilene tereftalato e il polivinilcloruro, costituenti di oggetti come le bottiglie, le posate e le stoviglie di plastica, i contenitori per il cibo, le reti da pesca, le pellicole.
Micro e nanoplastiche
Poiché le microplastiche e le nanoplastiche a occhio nudo non le vediamo, siamo portati a considerarle come insignificanti, mentre in realtà sono molto più insidiose per la nostra salute delle plastiche di maggiori dimensioni. Esse si trovano praticamente ovunque nelle acque di ogni latitudine, sul terreno e nelle nevi in alta quota. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è stata recentemente condotta (settembre 2019) una campagna di campionamenti delle nevi valdostane da parte dell’European research institute (con la Cooperativa Erica e la società VdATralier). La ricerca ha evidenziato come ogni anno precipitino sulle montagne valdostane, a causa degli eventi atmosferici, 200 milioni di frammenti di plastica (equivalenti a circa 25 Kg) di cui 80 milioni sono microplastiche. Questo valore è probabilmente sottostimato, considerando che parte delle nevi fondono, quando si alza la temperatura, riversando il loro contenuto nei ruscelli. È quindi chiaro che le microplastiche e le nanoplastiche in tal modo possono raggiungere tutti i bacini idrografici intermedi fino ad arrivare al mare. Lo stesso viaggio viene intrapreso prima o poi da tutti i minuscoli frammenti sparsi sul terreno, ogni volta che si verificano delle precipitazioni. A questi si aggiungono le microplastiche e le microfibre riversate quotidianamente nelle acque di scarico di ogni centro abitato e quelle generate direttamente in mare dalla frantumazione e degradazione delle reti e delle attrezzature da pesca, oltre che dei rifiuti in plastica gettati dalle imbarcazioni e di quelli giunti attraverso i fiumi. Quindi, il mare è ricchissimo di microplastiche e microfibre derivanti dagli oggetti che comunemente usiamo nella nostra vita quotidiana e nelle nostre attività. Ad esempio, la nostra lavatrice mediamente provoca a ogni normale lavaggio il rilascio di circa 1.900 microfibre per ogni capo d’abbigliamento sintetico, corrispondenti a circa 100 fibre/litro per il lavaggio di tutti i capi, quantitativo che costituisce il 180% delle fibre di un analogo abbigliamento in lana. Durante la stagione invernale, inoltre, utilizzando più indumenti, il rilascio di microfibre aumenta del 700%. A quelle rilasciate in acqua, si devono aggiungere quelle depositate al suolo. Secondo una ricerca condotta nel 2016 dall’Università di Parigi Est, sull’area cittadina (circa 2.500 Km2), ogni anno, cadono al suolo 3-10 tonnellate di microfibre provenienti dagli abiti sintetici. I microbeads e i frammenti spigolosi di polietilene sono invece contenuti in prodotti di uso quotidiano come lo scrub facciale, alcuni tipi di shampoo e di saponi, il dentifricio, l’eyeliner, le creme solari, i detergenti esfolianti, in quantità che talora raggiungono il 10% del peso del prodotto e che, negli ultimi anni, hanno sostituito i tradizionali ingredienti naturali, come le mandorle tritate, la farina d’avena e la pomice. È stato calcolato che ogni persona produce circa 2,4 mg di microplastiche al giorno.
Negli ecosistemi acquatici le microplastiche riescono a espletare tutto il loro potenziale distruttivo. Esse possono causare danni fisici come il soffocamento degli invertebrati filtratori. Oltre a questo esse sono responsabili dell’assorbimento e del bioaccumulo di sostanze fortemente tossiche con proprietà mutagene, cancerogene e teratogene come gli ftalati, i Pcb, il bisfenolo A, le organoclorine e i metalli pesanti. Purtroppo i fr ammenti di plastica in acqua si comportano come delle spugne, assorbendo le sostanze tossiche disciolte e può succedere che un piccolo frammento riesca a concentrare su di esso una quantità di sostanze tossiche pari a un milione di volte quella presente nelle acque circostanti.
Disastro marino
Non c’è più alcuna zona dell’oceano, inteso come insieme di tutti i mari terrestri, che non sia contaminata dalle microplastiche, anche laddove non si vedono rifiuti plastici galleggianti, come nel passaggio a Nord Ovest nel mare Artico, dove una serie di campionamenti delle acque ha rivelato la presenza di smog di microplastiche e di nanoplastiche. Le ricerche condotte in questo mare hanno messo in evidenza il fatto che le microplastiche qui trovate non derivano da processi di degradazione in loco di rifiuti in plastica di maggiori dimensioni, ma sono state trasportate dalle correnti oceaniche, quindi provengono dai continenti in cui la plastica viene prodotta e dispersa in acqua. Tra l’altro i sistemi di depurazione e filtraggio delle acque (laddove esistono) non riescono a trattenere le microplastiche e le nanoplastiche, per via delle loro ridottissime dimensioni. Tutti i campionamenti effettuati in diverse parti dell’oceano hanno evidenziato come solo l’8% dei frammenti trovati è più grande di un chicco di riso.
Date le loro ridottissime dimensioni, le microplastiche e le nanoplastiche entrano a fare parte della catena alimentare, rilasciando le sostanze tossiche che trasportano, le quali sono caratterizzate da un processo di bioaccumulo o biomagnificazione, cioè il loro quantitativo all’interno degli organismi aumenta man mano che si sale lungo la catena alimentare. Frequentemente gli animali a vita bentonica, cioè viventi sui fondali marini si nutrono delle microplastiche, con tutto il loro contenuto di sostanze tossiche. Tra questi animali vi sono le cozze e le vongole, che spesso finiscono nei nostri piatti, i crostacei cirripedi (balani), gli invertebrati detritivori come oloturie, isopodi, anfipodi e policheti. Le nanoplastiche possono essere ingerite invece dagli organismi planctonici, che sono il cibo per elezione della balenottera comune (Balaenoptera physalus) e dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), animali di grossa taglia che in tal modo accumulano nel loro tessuto adiposo quantità rilevanti di ftalati (mediamente 45 ng/g di grasso nella balenottera) derivanti dal plancton contaminato. I pesci sovente ingeriscono microplastiche, contaminandosi con le sostanze tossiche trasportate e quelli predatori, che si nutrono delle specie più piccole, accumulano nel loro tessuto adiposo ingenti quantità di tali sostanze.
Un piatto «ben» condito
Secondo la Coldiretti, in Italia consumiamo mediamente 25 Kg a testa di pesce all’anno, mentre il leader europeo del consumo di pesce è il Portogallo con 56 Kg procapite all’anno. È logico pensare che, attraverso il cibo, ci ritroviamo nel piatto la plastica, che abbiamo disperso in mare qualche anno prima, per giunta condita dalle sostanze tossiche che è riuscita ad assorbire, oltre a quelle di cui è normalmente costituita. Tra le prime possono figurare anche il Ddt e i pesticidi, finiti più o meno accidentalmente in acqua. Tra i costituenti della plastica, quelli che vengono maggiormente trasferiti dalle microplastiche e che risultano particolarmente pericolosi per la nostra salute sono gli ftalati. Queste sostanze trovano impiego nella fabbricazione delle materie plastiche in Pvc, perché ne migliorano la modellabilità e la flessibilità. Essi hanno inoltre diversi altri impieghi poiché consentono la persistenza dello smalto sulle unghie, quella del profumo nei deodoranti e quella della pigmentazione delle vernici. Data la loro elevata tossicità, la loro concentrazione nei giocattoli e negli articoli di puericultura, spesso messi in bocca dai bambini piccoli, a livello europeo non può superare lo 0,1% (Dir. 2005/84/Ce). Tra gli ftalati più pericolosi per la salute riproduttiva, in quanto interferenti endocrini, ci sono il Dehp o ftalato di bis (2-etilesile) e il prodotto della sua idrolisi o Mehp, cioè mono (2-etilesile) ftalato. Inoltre, il Dbp o ftalato di dibutile e il Bbp o ftalato di butilbenzile.

La biomagnificazione
Pericolosissimo è il cosiddetto effetto cocktail dovuto sia al bioaccumulo, causa di una maggiore concentrazione, sia alla mescolanza di più sostanze tossiche, che comportano una tossicità ancora più marcata. In molti organismi marini sono stati riscontrati alterazione riproduttiva e dello sviluppo e diminuzione della sopravvivenza.
La prima osservazione dell’ingestione di microplastiche da parte di sei differenti specie di pesci risale al 1990. Le specie maggiormente colpite da questo fenomeno sono quelle planctofaghe. Sono stati rinvenuti frammenti plastici nel 35% delle specie ittiche pelagiche del Pacifico settentrionale e nel 36% delle specie mesopelagiche e demersali costiere (come halibut e platessa) dell’Atlantico. Particolarmente problematici dal punto di vista del ritrovamento di microplastiche e microfibre nello stomaco dei pesci si sono rivelati gli estuari dei fiumi. In queste aree, i pesci bentonici, che si nutrono dei sedimenti sui fondali, risultano le specie più colpite. In questi ambienti sono particolarmente accentuati i rapporti di predazione, con l’inevitabile conseguenza del fenomeno della biomagnificazione, per trasferimento degli inquinanti tossici dalle specie di piccola taglia ai predatori di maggiori dimensioni.
Tra le specie di pesci, che compaiono comunemente sulle nostre tavole, sono risultate contaminate da ftalati le sardine (Sarda sarda), le acciughe europee (Engraulis encrasicolus), le triglie di scoglio (Mullus surmuletus), i merlani comuni (Merlangius merlangus).
Naturalmente il processo di biomagnificazione continua in tutte le specie di uccelli, rettili e mammiferi che si nutrono di pesci contaminati. Sono state rinvenute fibre plastiche nell’apparato digerente e sostanze tossiche nel tessuto adiposo di orsi polari, foche e cetacei.
Poiché all’apice della catena alimentare ci sono i grandi predatori e tra questi l’uomo, era inevitabile trovare prima o poi le microplastiche e nanoplastiche nei nostri organi e tessuti.
Un team di ricerca dell’Università statale dell’Arizona, grazie ad una tecnica di imaging chiamata spettrometria -Raman, per la prima volta ha analizzato 47 campioni prelevati da diversi organi di persone decedute, tra cui fegato, polmoni, milza e reni, trovandoli tutti positivi per la presenza di microplastiche e di nanoplastiche. Al momento non sappiamo ancora quali siano gli effetti della presenza delle microplastiche e delle nanoplastiche sulla salute umana, ma le problematiche come infertilità, infiammazione e cancro riscontrate nei modelli animali non fanno presagire alcunché di buono.
Misure insufficienti
È evidente che non possiamo più limitarci al riuso della plastica, alla raccolta differenziata e al suo riciclo (che non può proseguire all’infinito, come quello del vetro o dei metalli). È indispensabile limitarne la produzione, sostituendola con materiali completamente biodegradabili, perché per quanto siano stati messi a punto dei metodi di cattura delle plastiche galleggianti nei fiumi, per impedire che esse raggiungano il mare e di eliminazione delle microplastiche (peraltro ancora a livello sperimentale) dalle acque, non sarà mai possibile ripulire le acque e i fondali di tutto l’oceano (anche perché ancora in gran parte inesplorati). Sicuramente ciascuno di noi può fare la sua parte, a cominciare dalle scelte che facciamo al momento dell’acquisto, dando la preferenza a prodotti in altro materiale, a cibi venduti sfusi, senza packaging in polistirolo o plastica, ad abiti in fibra naturale e a calzature in pelle e cuoio. È inoltre di fondamentale importanza educare i nostri ragazzi ad un minore consumo di plastica. Solo scegliendo prodotti alternativi si può influenzare il mercato e, di conseguenza, la produzione della plastica.
Rosanna Novara Topino
(Fine)
*la prima parte è in MC aprile 2020

L’incomprensibile ritorno dell’«usa e getta»
Tonnellate di rifiuti sanitari
La riapertura delle scuole in tempo di Covid ha portato il ministero dell’Istruzione alla decisione di imporre l’uso a tutti – docenti, operatori scolastici e studenti – delle mascherine chirurgiche monouso, per la massima tutela, secondo gli esperti del Comitato tecnico scientifico incaricato dallo stesso ministero, della salute di tutti coloro che si trovano nell’ambiente scolastico. In pratica, ogni istituto scolastico dovrà fornire giornalmente una mascherina chirurgica monouso a tutti. Secondo tale piano si dovrà giungere a una fornitura quotidiana di 11 milioni di mascherine chirurgiche per tutte le scuole italiane.
Perché la scelta della mascherina chirurgica usa e getta? Secondo gli esperti del Comitato tecnico, perché la mascherina chirurgica è certificata in base alla sua capacità di filtraggio e risponde alle caratteristiche richieste dalla norma Uni En Iso 14683 – 2019, per quanto riguarda la capacità di barriera contro i microbi di ogni tipo. Le mascherine di stoffa lavabili e riciclabili, nella maggior parte dei casi non rispondono a tale norma. In realtà però esistono in commercio anche mascherine riutilizzabili e certificate, le cui prestazioni sono del tutto analoghe a quelle delle mascherine chirurgiche. Sarebbe sufficiente cambiare tipo di fornitura.
Gli esperti del comitato tecnico non hanno tenuto conto del fatto che 11 milioni di mascherine usa e getta giornaliere corrispondono a 44 tonnellate di rifiuti in più da smaltire mediante incenerimento, l’unico modo corretto di smaltimento dei rifiuti sanitari.
Siamo proprio sicuri che questa sia la migliore forma di tutela della salute? Anche perché le mascherine chirurgiche contengono sostanze plastiche, essendo realizzate in polipropilene o poliestere (che costituiscono il «tessuto-non tessuto» o Tnt di cui sono fatte) e l’incenerimento delle materie plastiche è senza dubbio fonte di sostanze tossiche, come le diossine, che rappresentano un rischio certo per la salute pubblica, a differenza di quello potenziale da Coronavirus. Tutto ciò si aggiunge alla già elevata quantità di mascherine e guanti monouso abbandonati per terra o in mare da persone che dimostrano in tal modo il loro grado di inciviltà.
C’è poi da dire che non è corretto indossare la stessa mascherina chirurgica per più di quattro ore, altrimenti essa perde completamente la sua efficacia perciò, nelle scuole a tempo pieno dove la permanenza è di otto ore, ciascuno dovrebbe avere a disposizione un paio di mascherine al giorno. È evidente che tutto questo rappresenta una spesa enorme per le casse dello stato ed un peso enorme per l’ambiente, che si potrebbero evitare ricorrendo alle mascherine lavabili, che tra l’altro possono anche essere sterilizzate in casa mediante bollitura, mentre le chirurgiche non sono quasi mai sterili.
Oltre a questo va detto che la scuola, che dovrebbe insegnare ai ragazzi a rispettare l’ambiente, obbligandoli ad indossare le mascherine monouso, fa esattamente l’opposto. A conti fatti, questo provvedimento risulta altamente diseducativo. Anziché abituare i ragazzi al riuso e al riciclo, per diminuire l’impronta ecologica, proprio la scuola li abitua a un inutile spreco di materie prime.
R.N.T.