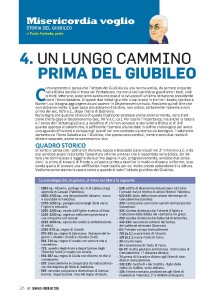Storia del Giubileo 7. Il giubileo biblico incompiuto
Nel libro del Levitico si prescrive una contraddizione: da una parte il giubileo deve farsi ogni 49 anni e dall’altra, si dice di celebrarlo ogni 50.
«8Conterai sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni. 10Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi toerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. 11Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. 12Poiché è un giubileo: esso sarà per voi santo; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi» (Lv 25,10-12).
Queste espressioni sono la spia non solo di tradizioni diverse confluite nella redazione finale del testo giunto fino a noi, ma anche la prova della praticità della religione ebraica. In tutte e due le versioni, comunque, si afferma l’idealità teorica, non la concretezza storica del Giubileo perché dal sec. V a.C. al tempo di Gesù, cioè durante tutto il periodo del secondo tempio, ricostruito da Esdra e Neemia, il giubileo non fu mai praticato, come abbiamo già visto. Lo stesso capitolo 25 del libro del Levitico, pochi versetti prima, imponeva il riposo sabbatico per la terra ogni sette anni:
«2Quando entrerete nella terra che io vi do, la terra farà il riposo del sabato in onore del Signore: 3per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti; 4ma il settimo anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, non poterai la tua vigna. 5Non mieterai quello che nascerà spontaneamente dopo la tua mietitura e non vendemmierai l’uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di completo riposo per la terra» (Lv 25,2-5).
Se questa è la dimensione in cui bisogna muoversi, bisogna convenire che ogni «sette settimane di anni», cioè ogni quarantanove anni venivano a coincidere sia il riposo sabbatico (settennale) sia il giubileo (cinquantesimo), per cui sarebbe stato obbligatorio che la terra restasse incolta per due anni di seguito. Questa realtà era talmente presente e preoccupante che Alessandro Magno prima e Giulio Cesare poi esentarono gli Ebrei dal pagare le tasse negli anni giubilari; l’esenzione fu abolita nel sec. II d.C. dall’imperatore Adriano (117-138 d.C.) che odiava il popolo ebraico.
Dopo la seconda rivolta palestinese capeggiata da «Bar Kokba – figlio della stella», che molti identificarono come il Messia, l’imperatore Adriano nel 135 comminò l’espulsione definitiva degli Ebrei non solo da Gerusalemme, ma da tutta la Palestina, dando inizio alla transumanza perenne che fu il marchio d’infamia del popolo eletto. Scelto per possedere una terra «promessa», divenne il popolo senza terra, in balia di chiunque, reietti da tutti, fino ad arrivare all’apice dell’abiezione che fu l’orrore della «Shoàh». La quale non arrivò all’improvviso come un fulmine estivo, ma fu la logica conseguenza, preparata da venti secoli di emarginazione, persecuzione e disprezzo, alimentati teologicamente dalla Chiesa che ne aveva fatto un punto nevralgico della propria catechesi ordinaria fino all’arrivo del papa profeta, Giovanni XXIII, che volle modificare il Messale della liturgia, facendo togliere dalla preghiera del Venerdì Santo l’intercessione «pro pèrfidis Iudèis».
Se la terra è di Dio, nessuno è proprietario
Lo scopo di tutte queste prescrizioni dettagliate, oseremmo dire pignole, non è quello di creare un «istituto giuridico periodico», ma di sviluppare una teologia per la formazione del popolo: il concetto affermato dal Giubileo è che la terra, tutta la terra, è di Dio e l’uomo non ne può mai essere il proprietario, ma solo l’usufruttuario. In questo modo si svuotava di senso l’idea di «proprietà privata». Un esempio chiarirà meglio: se una donna era sposata a un uomo di una tribù diversa, l’eventuale eredità di una terra non poteva passare nella disponibilità proprietaria del marito, perché la terra doveva restare nella tribù di appartenenza. Per questo motivo si tentava di sposarsi solo tra membri delle rispettive tribù, o addirittura all’interno della stessa cerchia parentale con enormi problemi sul piano delle malattie ereditarie. In questo modo si affermava che solo Dio è il creatore e l’uomo, a cominciare da Àdam ed Eva, è perennemente ospite provvisorio della terra:
«Mia infatti è tutta la terra … al Signore, tuo Dio, appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la terra e quanto essa contiene … Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti» (Es 19,5; Dt 10,14; Lv 25,23).
Questa teologia è sviluppata nel libro di Giobbe, scritto nel dopo l’esilio, in cui si narra di un israelita cui Dio ha tolto tutto. Il pio Giobbe formula il principio dei riformatori e cioè che nessuno è proprietario di nulla in questo mondo: «Nudo uscii dal grembo di mia madre, e nudo vi ritoerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!» (Gb 1,10). Si è fatto passare questo povero Giobbe come l’uomo della pazienza, svilendo così il senso del libro, di grande portata sociale e religiosa: la relativizzazione della proprietà privata.
Siamo forestieri e ospiti, non proprietari o, peggio, dominatori, ritornando così «al principio» di Genesi, quando Dio «pose Àdam nel giardino di Eden perché gli ubbidisse e lo ascoltasse» (Gen 1,15, testo ebraico): l’uomo è al servizio della terra, come se questa fosse sua figlia. Non ci troviamo davanti a una norma civile, ma di fronte a una professione di fede che deve stabilire il rapporto dell’uomo con il creato e la sudditanza del primo al secondo, non il contrario. È ciò che afferma Papa Francesco nell’enciclica «Laudato si’» con un grido di allerta all’umanità tutta, alla politica, all’economia perché tornino alla coscienza del «principio» e si aprano alla consapevolezza del limite che è il contrario del delirio di onnipotenza che sta devastando tutto il creato.
Dio creatore aveva dato consistenza al creato e all’umanità in sette giorni, simbolici della totalità della perfezione. Ora l’Ebreo deve contare il tempo di sette anni in sette anni, poi in sette settimane di anni «perché mia è la terra», simboleggiando così che lo scorrere della storia è guidato da Dio. In questo modo si stabilisce un rapporto molto stretto tra Dio e il tempo: se il tempo della vita che dipende dal nutrimento della terra è scandito da Dio, si afferma l’antropologia teologica che l’uomo non è Dio e quindi non può pretendere di essere «onnipotente» come fece Àdam che, infatti, trasformò il giardino di Eden in un inferno di spine e sofferenze.
Il Giubileo tutela i poveri senza riuscirvi
Come abbiamo visto nelle puntate 5a e 6a, la differenza tra Anno Sabbatico e Giubileo era questa: nel primo era prescritto il condono dei debiti di qualsiasi natura e la restituzione della libertà agli schiavi; col secondo si doveva, teoricamente, rientrare in possesso della terra data in pegno per qualsiasi motivo, affinché si potesse ricostituire il patrimonio preesistente e quindi ristabilire l’assetto proprietario tra le tribù: ciò valeva solo nelle campagne, ma non nelle città, dove il principio non poteva essere applicato alle abitazioni.
Comunque sia, la pratica ha fatto sì che gli ideali dell’Anno Sabbatico (condono) e del Giubileo (proprietà) fossero in un certo senso intercambiabili, considerata la loro natura di fondamento per una maggiore equità sociale e comunitaria che si attribuiva direttamente alla volontà di Dio. In altri termini più modei, si direbbe una più equa distribuzione della ricchezza e l’affermazione solenne dell’uguaglianza di tutti davanti a Dio.
Dal Giubileo è estranea ogni idea d’indulgenza, concetto assente nella Bibbia, e qualsiasi pratica di pellegrinaggio come spostamento verso un luogo privilegiato perché Giubileo e Anno Sabbatico si compiono dovunque vi sono due Ebrei in relazione tra loro. Il pellegrinaggio, invece, ha preso il sopravvento nel Cristianesimo, e successivamente nel Islam, con il viaggio a Gerusalemme per Cristiani e Musulmani, poi trasferito dal sultano alla Mecca per quest’ultimi. Gli Ebrei non hanno il senso del pellegrinaggio come visita, ma l’idea del ritorno annuale a Gerusalemme, come simbolo escatologico della ricostruzione del popolo d’Israele attorno al tempio del Signore ricostruito e quindi come fine dell’esilio e della diaspora. Ancora oggi, la sera di Pasqua, gli Ebrei, ovunque sono nel mondo, concludono la cena, con un sospiro di desiderio che si fa preghiera e anche augurio: «Hashanàh haba’à beYerushallàyim – l’anno prossimo a Gerusalemme», auspicando la ricostruzione del tempio e la ricomposizione di Israele come popolo di Dio nell’unica terra che è la terra d’Israele, terra di Dio.
Durante il Giubileo, dunque, si doveva fare riposare la terra: non si doveva seminare, né potare o vendemmiare la vigna; i frutti dovevano restare sugli alberi e sulla vite; chi aveva riserve in cantina, poteva usarle fino a che gli stessi frutti restavano naturalmente sull’albero, ma quando cessava la stagione, dovevano essere distrutte anche le riserve nei depositi, che di solito erano appannaggio dei ricchi. Con ciò si affermava la parità assoluta tra ricchi e poveri e si ristabiliva un criterio di giustizia che metteva un freno alle prevaricazioni.
Nell’anno del Giubileo, infine, non si doveva pretendere la restituzione del debito. Quest’ultima norma ha avuto effetti micidiali, perché, all’approssimarsi del Giubileo, nessuno faceva più prestiti ai poveri con la conseguenza di aumentare la povertà, vanificando così il dettato divino, anzi capovolgendolo. Alla luce di questa tragica situazione, alcuni anni prima di Gesù, il grande rabbì Hillèl, di cui fu discepolo l’apostolo Paolo di Tarso, stabilì la norma che i debiti fossero trasferiti al tribunale che ne garantiva il riscatto, venendo in aiuto ai poveri. Si potrebbe dire che, come in tutte le culture e in tutti i tempi, fatta la legge, si è trovato l’inganno.
Ritrovare il senso del tempo e dello spazio
Da un punto di vista teologico, poiché il Giubileo riguardava un determinato periodo di anni in relazione a un determinato territorio fisico, è coerente pensare che esso sia il primo germe di una Teologia della Storia perché pone al centro della riflessione due elementi costitutivi della fede cristiana: il tempo e lo spazio, cioè l’ambito «umano» in cui si svolge l’esperienza dell’alleanza e quindi si vive la salvezza (in campo cattolico, indichiamo a modo di esempio solo due autori: H. Urs Von Balthasar, Teologia della storia. Abbozzo, Morcelliana, Brescia 1969; W. Kasper, Fede e storia, Queriniana, Brescia 1985).
Il tempo biblico non è la ruota ciclica (O) dei Greci che s’identifica con il destino, in quale si attua indipendentemente dalla volontà dell’individuo che soggiace al volere degli dèi. Non è nemmeno la linea retta (?) dei Romani che avanzano senza mai fermarsi come una legione a testuggine, verso un progresso senza limiti. Il tempo biblico è la sintesi del cerchio greco e della retta romana che si trasforma in una spirale, cioè non un semplice ritorno (Greci) né un inesorabile progresso lineare (Romani), ma una ripresa costante di ciò che precede, amalgamato con quello che segue, salendo di un gradino verso l’alto: la spirale appunto, un cerchio aperto che procede in avanti perché sale.
Questa immagine ridefinisce il concetto di tempo che non è più una dimensione cronologica (una cosa dopo l’altra), cioè una successione anonima di fatti che capitano per essere subìti in una rassegnazione sistematica. La spirale porta in sé l’idea di una circolarità arricchita da occasioni coscienti, messe in atto dagli eventi, ma specialmente dalle persone, capaci di dare una svolta all’anonimato, e quindi anche di cambiare il senso e la direzione della storia. È il concetto di «kairòs – occasione» che mette in evidenza l’aspetto di qualità del tempo. Vi sono fatti indifferenti e fatti che cambiano il corso della storia. È questo il caso dell’Anno santo della Misericordia di Papa Francesco.
In altre parole l’uomo biblico non subisce meccanicamente il susseguirsi della cronologia, ma con le sue scelte può influire, nel bene e nel male, inducendo la storia ad andare in una direzione o in un’altra. È il concetto di responsabilità che si richiama direttamente alla coscienza. In rapporto a Dio, il tempo dell’uomo diventa «liturgico», in quanto «regalato» al rapporto con il divino attraverso riti e atti stabiliti da un protocollo (rituale). Ciò esige per sua natura anche la riserva di uno spazio dove il tempo celebrato possa trovare espressione e dimensione: nascono il tempio, i santuari, le chiese, le moschee come simboli della sintesi tra tempo e spazio.
L’uomo tende a sacralizzare perché nel consacrare o nel separare ambiti (spazio) e dimensioni (tempo), definendoli «sacri» in quanto distinti dal «profano», trova una garanzia e una sicurezza garantita dalla ripetitività dei gesti, delle liturgie e delle parole (rubriche) che offrono un certo grado di inamovibilità e perennità, quasi a volere lambire così il mondo di Dio. Per questo, nella vita di ciascuno si individuano cinque tappe «storiche» da consacrare come appuntamenti quasi «giubilari»: la nascita (battesimo), la crescita (cresima), la fecondità (matrimonio), la sofferenza (unzione infermi), la morte (esequie).
Paolo Farinella, prete
(7, continua)