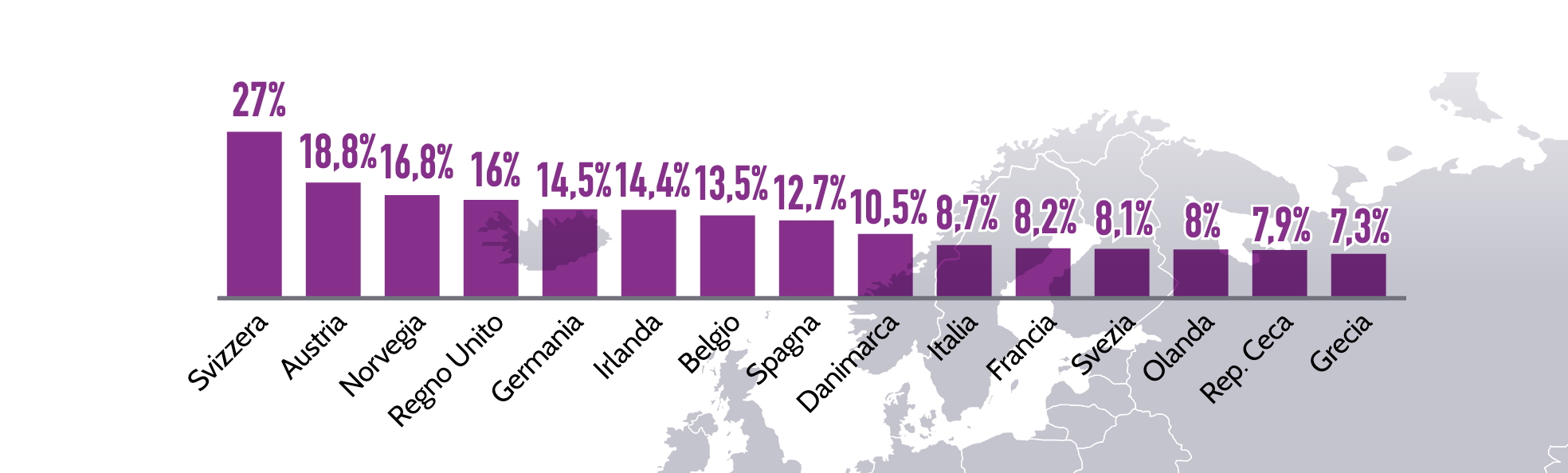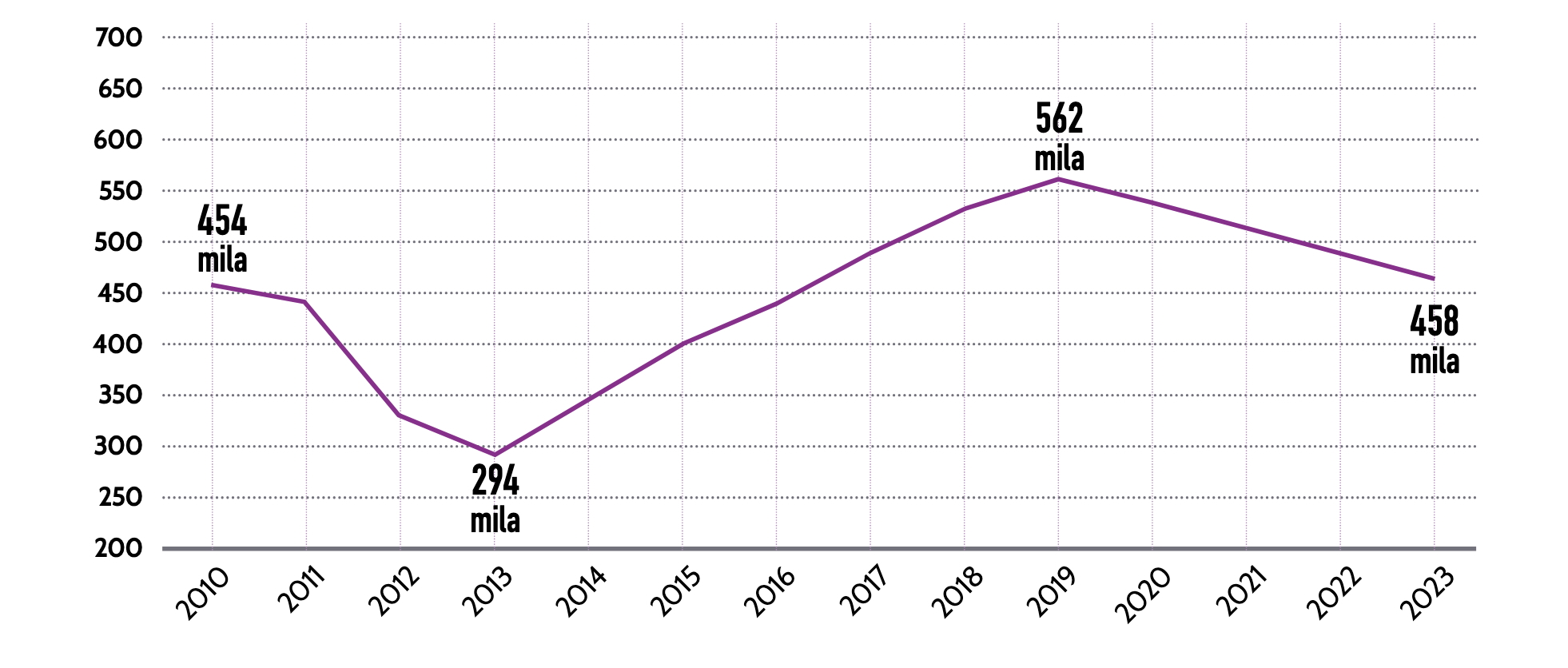eSwatini. Il mio papa imprevedibile
Un giorno di maggio del 2013, dopo che papa Francesco era stato eletto vescovo di Roma, io, che ero vescovo in Sudafrica, ho pensato di scrivergli, raccontandogli come la sua elezione fosse stata accolta nella nostra parte del mondo.
Il nunzio apostolico mi assicurò che la lettera sarebbe arrivata a lui e non a uno dei suoi segretari. E fu proprio così. Circa un mese dopo ricevetti una sua risposta scritta a mano. Non me lo sarei mai aspettato.
Tanto meno quello che è successo dopo.
A luglio Papa Francesco si è recato a Rio de Janeiro per la Giornata mondiale della gioventù e ha chiesto di organizzare un evento speciale per chi arrivava dall’Argentina (una folla enorme, come potete immaginare!). Dato che io sono Argentino, i vescovi mi hanno invitato a unirmi a loro.
All’arrivo del papa in cattedrale, i vescovi argentini lo hanno salutato con entusiasmo (era la prima volta che lo incontravamo come Papa!). Mi sono presentato non aspettandomi che si ricordasse di me. Mi ha detto: «Hai ricevuto la mia lettera?».
È stato travolgente. In mezzo a tutto ciò che stava accadendo intorno a lui, come poteva ricordarlo?
Al di là delle sue omelie, dei suoi discorsi e dei suoi documenti, si potrebbero scrivere pagine e pagine sul fatto che facesse sentire unica ai suoi occhi ogni persona che lo incontrava.
Credo che come Sacbc (vescovi di Botswana, Eswatini e Sudafrica) non dimenticheremo mai le due visite ad limina che abbiamo avuto con lui nel 2014 e nel 2023.
Il primo non lo dimenticheremo perché, accogliendoci (in due gruppi in due giorni diversi), ha esordito: «Come si dice nel calcio, il pallone è al centro, chi lo calcia per primo? Di cosa vorresti che parlassimo?».
Era uno spazio aperto per noi per parlare con il successore di Pietro di qualsiasi argomento avessimo nel cuore. Era totalmente nuovo per noi. Ricordo infatti ancora uno dei vescovi che disse dopo l’incontro: «Ho aspettato 20 anni per un momento così».
Il secondo incontro è stato segnato dal fatto di essere stato annullato. Il Papa era in ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico importante.
Il giorno in cui è stato dimesso, alcuni di noi si trovavano all’ingresso della sua residenza proprio nel momento in cui è stato riportato dall’ospedale. Mi ha visto e mi ha chiesto se fossimo lì per la visita ad limina e quando ci saremmo incontrati. Ho detto: «L’incontro è stato cancellato. Tu eri in ospedale ma tu sei il Papa e… sei imprevedibile!». Ha salutato gli altri vescovi e poi ha detto: «Dite ai vescovi che potremmo incontrarci dopo pranzo».
Nessuno si aspettava che un uomo di 86 anni trovasse il tempo per noi dopo un intervento chirurgico importante. Eravamo solo noi e lui, nessuna segretaria, nessun protocollo, nessuno a tradurre! Era il vescovo di Roma con i suoi fratelli vescovi nel modo più informale. Non sono stati gli argomenti di cui abbiamo parlato quel pomeriggio a rimanere nei nostri cuori, ma quello che abbiamo visto anche domenica scorsa: il suo dare tutto il suo tempo e le sue energie a tutti i costi.
Attraverso momenti come questi, attraverso le sue lettere personali, telefonate, visite… si è fatto vicino a tutti noi, ha testimoniato la cura amorevole di Dio per ogni persona, ma ha anche, silenziosamente, richiamato tutti noi a prenderci cura gli uni degli altri, ad apprezzare il dono gli uni degli altri e, a noi vescovi, ha mostrato il modo in cui siamo chiamati a prenderci cura di coloro che ci sono stati affidati.
+ José Luis Ponce de León, Imc, vescovo di eSwatini