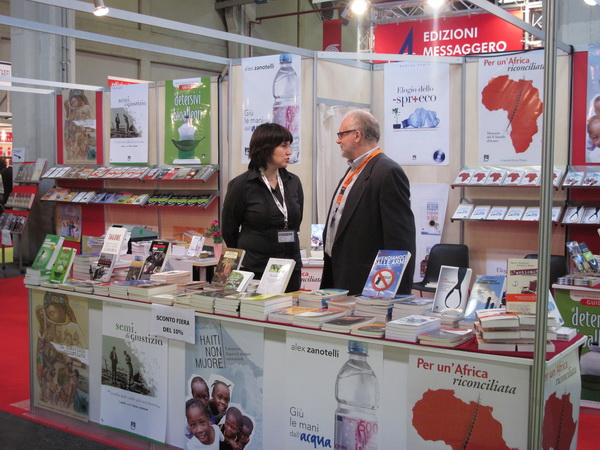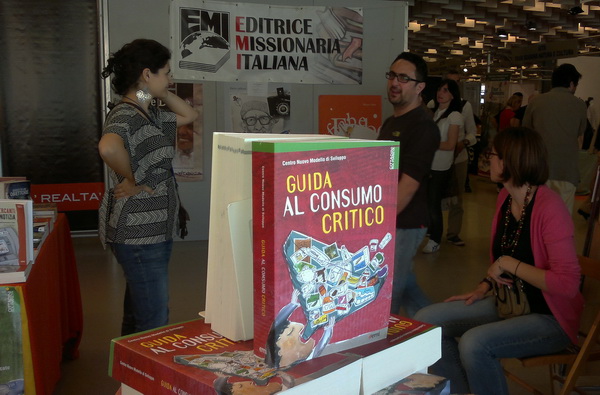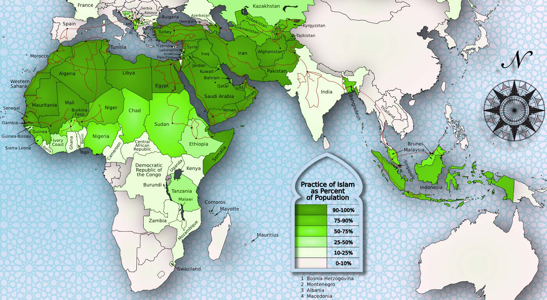Le cosiddette «Primavere arabe» si sono trasformate in
«Autunni» o addirittura in «Invei» (come dimostrano le proteste egiziane di
fine 2012). I veri vincitori non sono le masse giovanili, ma i movimenti
organizzati attorno alla «Fratellanza musulmana» e ai «neosalafiti». Con alcuni
protagonisti più o meno occulti: Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Israele e
Stati Uniti. E una serie di rivolte «non accreditate» (Bahrain, Arabia Saudita,
Yemen) né dalla comunità internazionale, né dai media.
72
Le «Primavere arabe», definizione sentimentale, e poco
realista, hanno deluso le aspettative dei loro stessi promotori, i giovani, e
si sono presto trasformate in «Autunni» o, peggio, in «Invei». Esse sono nate
dalle spontanee ribellioni di masse giovanili esasperate da corruzione,
clientelismo, dispotismi di presidenti a vita (sostenuti dall’Occidente) e di
caste arabe dure a morire: un’onda tendenzialmente sovvertitrice di un «sistema
tribale» (malattia endemica del mondo arabo), partita dalla Tunisia e con
effetto domino arrivata fino in Bahrain e Arabia Saudita. Tuttavia, prive di
un’ideologia e di una strategia politica tali da permettere loro di essere
definite «rivoluzioni» e di un sostegno economico capace di farle competere, in
campagna elettorale, con i potenti mezzi dei movimenti islamici, le «Primavere»
sono state sopraffatte da questi ultimi. In queste pagine, proveremo a
ripercorrere e interpretare i fatti e le situazioni (tutte le fonti a termine di questo articolo).

LE RIVOLTE NON SONO TUTTE EGUALI
Ogni rivolta ha dinamiche ed esiti differenti: quelle in
Tunisia ed Egitto, autentiche sollevazioni popolari di massa, non sono
paragonabili alla libica. Per questa si è infatti trattato di un golpe pilotato
dalla Nato in collaborazione con gruppi di oppositori al regime di Muammar
Gheddafi residenti all’estero, con mercenari al servizio degli Usa e jihadisti
e qaedisti al soldo dell’Arabia Saudita.
Per la Siria, con maggiori difficoltà di riuscita, almeno
finora, la strada che si sta seguendo è la stessa della Libia. Sebbene nata
come opposizione non-violenta di una parte della popolazione al lungo regime
degli Assad, la rivolta si è presto trasformata in uno scontro armato e cruento
tra l’esercito regolare governativo e un insieme di forze variegate (oppositori
locali, mercenari, jihadisti di professione assoldati da forze straniere)
pronte a tutto. Un’altra storia sono, infine, le ribellioni in Bahrain e Arabia
Saudita, volutamente dimenticate dai media, perché contro regimi «amici» e
finanziatori delle altre «Primavere», e quella nello Yemen.
DITTATORI, ISLAMOFOBIA, ALLEANZE
Proprio osservando gli sviluppi di ciascuna protesta
popolare araba, ci si sta accorgendo di come il vento del cambiamento abbia
fatto veleggiare speditamente una nave con a bordo islamisti (Fratelli
musulmani e «neosalafiti»), Stati Uniti, Israele, Qatar e Arabia Saudita. Tutti
e quattro, questi ultimi, sostenitori a vario livello del fondamentalismo
islamico, in quanto strumentale ai loro progetti di destabilizzazione e
ridefinizione del Vicino e Medio Oriente.
Sebbene l’Occidente in generale, e in particolare gli Stati
Uniti, siano stati colti di sorpresa dalle rivolte arabe, poiché non previste
in tempi così brevi, esse sono state presto utilizzate all’interno di un piano
di «Nuovo ordine del Medio Oriente».
Stiamo parlando della seconda fase del progetto iniziato a
fine anni ’90 e passato attraverso la tragedia delle Torri Gemelle e delle
guerre in Afghanistan e Iraq, e ora, appunto, attraverso il dirottamento e la
manipolazione delle «Primavere». Gli Usa non potevano, infatti, continuare a
dominare il Mediterraneo e la regione mediorientale usando solo l’arma
dell’islamofobia, come avevano fatto nel decennio precedente: l’amministrazione
Obama, definita «islamofila» dai suoi avversari repubblicani e neo-con (si
ricordi il discorso del neo-eletto presidente americano al Cairo, il 4 giugno
del 2009: reperibile su YouTube), aveva ora bisogno di cornoptare le leadership
dei movimenti islamici (dati per vincenti nelle elezioni dei vari paesi) e i
dirigenti musulmani in Europa. Incontri ufficiosi, poi divenuti ufficiali, con
la Fratellanza musulmana erano in corso già da tempo, e si sono infittiti
durante le rivolte. Per quanto riguarda, invece, le diverse organizzazioni del
neosalafismo, dalla creazione di al-Qaida (durante la guerra fredda con
l’Unione Sovietica) in poi, esse sono sempre state funzionali alle politiche
statunitensi nel mondo islamico.
Nella Libia devastata dal colpo di stato contro il dittatore
Gheddafi e dalla guerra tra bande attualmente in atto, il caos politico e la
mancanza di una leadership riconosciuta, nel bene o nel male, da tutta la
popolazione, sono le orde qaediste, cioè quell’accozzaglia di jihadisti di
mestiere, ad aver davvero guadagnato: esse sono state sdoganate e ora
scorrazzano felici (prima c’erano, ma erano meno liete, in quanto contenute e
spesso perseguitate) in varie regioni africane (si veda in Mali, come ben
spiegato nel dossier MC di novembre 2012), seminando distruzione, aggredendo
cristiani e minoranze religiose islamiche (sufi e sciiti, ad esempio) e
radicando fobie ignoranti. L’amministrazione statunitense, con i suoi tanti
think tank ed esperti, ha saputo cogliere l’onda di cambiamento delle piazze
arabe e ha scaricato i vecchi amici, i dittatori tunisino e egiziano, ormai
impresentabili e troppo compromessi, e ha stretto alleanze tattiche con la
Fratellanza musulmana e i suoi alleati/concorrenti salafiti.
In Egitto, all’inizio della rivolta, i Fratelli erano
rimasti in disparte, a osservare i giovani e le forze politiche laiche, di
sinistra e liberali, manifestare nelle piazze contro Mubarak e il suo sistema
corrotto. Solo in un momento successivo si sono uniti alla lotta popolare,
sapendo di avere le carte giuste per ascendere al potere, dopo anni di
persecuzioni.
I salafiti, invece, avevano avversato le ribellioni, in
quanto «sovvertitrici di un ordine costituito», per poi cavalcarle, come gli
altri, fino a godee i frutti politici e parlamentari.

NEOLIBERISMO IN SALSA ISLAMICA
L’Occidente neoliberista ha intravisto nei movimenti
islamisti (collocati nella «lista nera») degli alleati tattici per ridisegnare
il Mediterraneo e il Medio Oriente. Con i nuovi interlocutori c’è, infatti, una
comunanza di vedute a livello religioso fondamentalista ed economico: i
Fratelli musulmani apprezzano la dottrina economica del capitalismo
neo-liberista, rappresentando gli interessi di una potente borghesia
medio-alta, costituita da industriali, professionisti e commercianti. Infatti,
uno dei primi passi pubblici del milionario Khairat alShater, capo dell’ufficio
economico dei Fm e tra i fondatori del partito «Giustizia e Libertà» arrivato
al potere in Egitto, è stato di rassicurare Usa ed Europa sulla loro agenda
economica neo-capitalista e di libero mercato, in quanto «unico modello» per
garantire una veloce crescita del paese. Dunque, non si tratta di
rivoluzionari, come ritiene la vulgata.
Seppur nati come movimento di riforma religiosa e sociale,
molto attento ai bisogni dei ceti più deboli, che hanno sempre sostenuto
attraverso politiche di assistenza sociale radicata capillarmente sul
territorio (sia in Egitto sia in Palestina sia in altre nazioni), i Fratelli
hanno consolidato, negli ultimi decenni, la loro base politica tra la ricca
borghesia religiosa conservatrice. Distribuendo servizi fondamentali –
scolastici, assistenziali, sanitari, alimentari – e catechesi islamica, a una
massa di poveri senza speranza, hanno ottenuto negli anni un appoggio politico
ed elettorale rilevante.
CHI VUOLE LA GUERRA ALL’IRAN
La nuova fase della politica statunitense verso il mondo
musulmano non deve, però, trarre in inganno: l’alleanza tra Usa e islamismo è
solo tattica. C’è una strumentalizzazione reciproca e consapevole. I movimenti
islamisti, a partire dalle rivolte arabe, e soprattutto con le guerre in Libia
e Siria, stanno usando la forza militare occidentale (Stati Uniti, Nato,
squadroni e commando addestrati dalla Cia, ecc.) per raggiungere i loro
obiettivi di conquista del potere e rovesciamento selettivo (non tutti, cioè)
di regimi dispotici loro avversi, laddove, appunto, sanno che non ci
riuscirebbero dal «basso», con le sole rivolte di piazza, non-violente e
idealiste, o come in Marocco vincendo le elezioni (anche qui, come in Turchia,
il partito «Giustizia e Sviluppo») senza ribellioni o scontri.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, l’islamofobia è
sempre in agguato, e il pessimo e squallido video artigianale sulla vita del
profeta Muhammad, «L’innocenza dei musulmani», diffuso su YouTube a settembre
del 2012, ne è una delle tante prove. Esso aveva l’obiettivo di provocare l’ira
dei musulmani, feriti dalle gratuite offese al profeta dell’Islam, adducendo
nuovi pretesti per lo «scontro di civiltà» e per la guerra contro l’Iran, che
una parte delle amministrazioni statunitense e israeliana vorrebbero scatenare.
Proprio su quest’ultimo conflitto e sulle politiche da adottare verso l’Islam e
il mondo arabo, la dirigenza americana, e quella d’Israele, sono in conflitto interno
tra «falchi» e «colombe». Coerentemente con le strategie belliche dei loro
predecessori (la famiglia Bush), i neocon Usa auspicano aggressioni e lo
scontro diretto per realizzare le loro politiche imperialiste. La fazione
obamiana, che ha dimostrato di amare la violenza e le guerre tanto quanto i
suoi rivali si pensi all’uso disinvolto dei droni in Afghanistan e Pakistan, ad
esempio, e il golpe Nato contro la Libia -, adotta semplicemente metodi e
strategie diverse: utilizza e manipola i musulmani, siano leader o popoli
arabi.
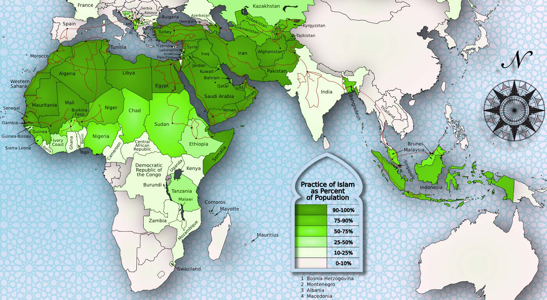
FAMIGLIA AL-SAUD E STRATEGIE
Nella sua lunga e dettagliata analisi sulle ragioni di quel
filmetto a basso costo, Mahdi Darius Nazemroaya, ricercatore di geopolitica
presso il canadese «Centro di ricerca sulla globalizzazione», spiega: «La
tempistica dell’uscita su YouTube del trailer de “L’innocenza dei musulmani”,
un film di piccola produzione che insulta il profeta Muhammad, non è solo una
coincidenza. La data dell’11 settembre è stata scelta appositamente per
l’associazione simbolica con i musulmani che viene fatta in maniera sbagliata e
assurda da coloro che percepiscono gli attacchi come un crimine collettivo di
tutti i praticanti islamici. Lo scopo di questo film offensivo è di
incoraggiare l’odio e la divisione incrementando il divario tra i cosiddetti
mondi occidentale e musulmano.
«L’uscita del film oltre ad aspirare alla divisione del
mondo è anche legata alla propaganda anti-Iran e al conflitto interno nella
politica estera statunitense. Israele ha un ruolo fondamentale nella divisione
intea tra le élite statunitensi e nell’antagonismo contro Teheran. L’analisi
del ruolo israeliano non dovrebbe essere svolta solo su una base nazionale che
vede Israele e Usa separatamente, ma anche dal punto di vista internazionale,
in cui riconoscere l’esistenza di alleanze tra gruppi diversi di élite
nazionali che vanno oltre i confini dei singoli stati».
«Non è certo per caso che una massiccia campagna
pubblicitaria islamofoba, legata ai sostenitori dell’occupazione del suolo
palestinese e della guerra Usa-Israele contro l’Iran, sia stata intrapresa e
intensificata in concomitanza con l’uscita del video su YouTube. Si tratta di
un costante assedio all’immagine dei musulmani. In breve queste campagne mirano
a rimodellare il Medio Oriente».
Come è ormai noto, le grandi manifestazioni musulmane
organizzate nelle piazze di molte capitali mondiali sono state orchestrate,
almeno in fase iniziale, dal clan della famiglia Al-Saud (la dinastia al potere
in Arabia Saudita) a Washington. Famiglia che, anche questo è risaputo,
sostiene economicamente i gruppi neo-salafiti in Egitto, Libia, Siria e in
altre regioni asiatiche e africane, che stanno collaborando con Stati Uniti,
Qatar e Israele, con il benestare di una parte della leadership della Fratellanza,
a creare un nuovo assetto si legga «destabilizzazione» del Mediterraneo e del
Medio Oriente, dopo aver infiltrato, manipolato e dirottato le primavere arabe.
ERDOGAN, IL NEO-OTTOMANO
Lo scenario geopolitico mediterraneo e mediorientale si sta
dunque configurando su nuove guerre di rapina delle risorse da parte
dell’Occidente, e di potere e conquista politico-religiosa da parte degli
alleati tattici arabi e musulmani (sunniti).
Questi ultimi sembrano avere un progetto di neo-califfato
che va dal Nordafrica, con appendici subsahariane, al Vicino e Medio Oriente.
Gli attori che si spartiscono la scena, come abbiamo accennato sopra, sono la
Fratellanza musulmana e la variegata e discussa galassia del neo-salafismo.
Tuttavia, uno dei co-protagonisti è anche la prospera Turchia,
che sotto la direzione del partito «Giustizia e Sviluppo» del presidente Recep
Tayyip Erdogan, emanazione anch’esso della Fratellanza, ha fatto passi da
gigante, dal punto di vista economico e sociale, e ha offerto al mondo islamico
una via di sviluppo da seguire.
Il cambiamento della propria politica estera, rispetto al
lungo periodo laico kemalista, la vede impegnata maggiormente nelle aree che
storicamente facevano parte dell’Impero Ottomano; tale aspirazione neo-ottomana
la porta a una rivalità geopolitica con un’altra antica e illustre nazione
mediorientale: la Persia, anch’essa musulmana non araba, e altrettanto
interessata al ruolo di guida del risveglio islamico in corso.
Le ambizioni regionali da una parte e la partecipazione alla
Nato dall’altra, fanno sì che il Paese anatolico prenda parte, a livello
militare e strategico, al war-game statunitense-israeliano, e salafita, e trascini i già più che convinti leader sunniti nella
conflittualità contro la Siria e, per ora, nelle schermaglie contro l’Iran.
SUNNITI CONTRO SCIITI
Osservando gli eventi in corso sembra che il mondo islamico
sunnita (almeno una parte di esso) stia andando alla «guerra», in senso
politico, e religioso (questo fattore non deve essere dimenticato, in quanto è
altrettanto determinante), contro la fazione minoritaria, lo sciismo. Lo si
nota negli articoli che appaiono nei
media arabi, nei social network, nei discorsi dei politici, dove spesso
emergono attacchi, critiche, denunce, a vario livello, contro la corrente
storicamente rivale e considerata «eretica» e contro l’Iran.
Nelle chiacchierate informali con leader o rappresentanti
locali sunniti, in Europa come nel mondo arabo, emerge la loro contrapposizione
agli «altri», gli sciiti, ritenuti «infidi», «dal doppio discorso», in quanto
«fuori dall’ortodossia». Ecco dunque che il piano religioso irrompe con
prepotenza e interseca, giustificandolo, quello politico-strategico e bellico:
per un fondamentalista sunnita, infatti, uno sciita è più «kāfir» (miscredente)
di un ebreo, di un cristiano o di un buddista, in quanto reo di «deviare» dalla
sunna, la tradizione musulmana.
Per un neosalafita jihadista o un qaedista egli è degno di
morte: fare la guerra quindi contro coloro che deviano dall’ortodossia è lecito
e incoraggiato. Di qui, la motivazione politico-religiosa per la presenza di
al-Qaida in Siria (gli Assad sono alawiti) e per l’animosità contro l’Iran.
Paradossalmente, dunque, in quest’epoca di «scontro di
civiltà», i nemici della corrente maggioritaria dell’Islam non sono le
politiche di conquista americane e israeliane, sempre più sottili e incisive,
che stanno mettendo sottosopra il Vicino e Medio Oriente e la Palestina, o la
deriva neosalafita che proietta indietro di secoli il mondo musulmano, ma i
loro fratelli/antagonisti «eretici».
Della fitna (prova, litigio, scontro, fino al significato di
guerra civile) contemporanea, scaturita all’interno del mondo islamico, fanno
parte il conflitto mediatico, politico e militare, in corso contro il regime
siriano e quello ipotizzato contro l’Iran. Questa risistemazione di alleanze
tattiche e strategiche include la decisione dell’ottobre 2012 dell’Ufficio
politico di Hamas, la cui sede era a Damasco fino a pochi mesi prima, di
schierarsi ufficialmente contro il governo di Assad, attirandosi molte
critiche. Non è estraneo certamente a tale scelta radicale del movimento di
resistenza islamica il fatto che ora sia ospite del ricco e potente (e
interferente) Qatar.
Che in Siria ci sia bisogno di risolvere urgentemente la
crisi in corso ormai da un anno e mezzo, e con strumenti interni e non estei,
è evidente, ma che la strategia «atlantica» scelta da Hamas sia vincente è
tutto da vedere.
La lacerazione intra-islamica è stata (momentaneamente)
ricucita durante l’operazione di guerra israeliana contro la Striscia di Gaza
(14-21 novembre 2012), che ha visto gran parte del mondo arabo e musulmano
unito a sostegno dei palestinesi bombardati del regime di Tel Aviv. Dal punto
di vista concreto, da parte araba c’è stato ben poco, ma le prese di posizione
e il vortice di riunioni, incontri e pressioni hanno indubbiamente giocato a
favore di una tregua.
LA POSTA IN GIOCO
In tutto questo complicato, contraddittorio e nebuloso risiko,
dove le ribellioni accreditate ufficialmente sono quelle mediterranee e
vicino-orientali (con altre, altrettanto importanti, lasciate in disparte o
misconosciute, come quelle in Bahrain, Arabia Saudita, Yemen), la posta in
gioco sono la Palestina, la Siria e l’Iran. Tutte e tre strategicamente
fondamentali per le politiche neo-imperialiste e per le aspirazioni turche.
Siria e Iran probabilmente riusciranno a non soccombere per capacità intee,
potenza militare e politica, e per il sostegno di Russia e Cina, contrarie a
ogni intervento militare. A perdere saranno le popolazioni arabe, i giovani,
soprattutto, che non vedranno le primavere cui avevano diritto e per cui
avevano lottato morendo in tanti nelle piazze delle rivolte. E sarà la
Palestina l’altra grande sconfitta. Non ci sarà uno Stato palestinese degno di
questo nome: la Cisgiordania e Gerusalemme stanno perdendo terra in modo
esponenziale, anche grazie alla grande distrazione di massa offerta dalle
rivolte arabe, che distolgono l’attenzione da Israele che sta spingendo
l’acceleratore sulla colonizzazione della Palestina storica. La Striscia di
Gaza non sta affatto meglio ora che in Egitto ci sono i Fratelli, che non hanno
aperto il valico di Rafah, limitandosi a promesse, affettuosi abbracci e molta
retorica.
A meno che tale traballante e pericolosa situazione non
nasconda un asso nella manica dei giocatori arabi nel grande scacchiere
geopolitico: il progetto di «neo-califfato», da stabilire una volta che i
Fratelli musulmani si saranno insediati, insieme ai salafiti wahhabiti e
jihadisti, in tutto il Nordafrica e il Medio Oriente. Un califfato che
scatenerebbe una «guerra santa» contro Israele e si rivolterebbe contro
l’alleato del momento, gli Usa.
Tuttavia, in una prospettiva globale e futura, bisognerà
capire quale direzione prenderanno i paesi arabi e se vorranno portare avanti
la fitna intra-islamica tra sunniti e sciiti, incoraggiata da Stati Uniti,
Israele e petro-monarchie del Golfo, e quanto spazio prenderanno i salafiti. Se
i giochi di alleanze e conflitti in corso andranno avanti senza soluzioni
pacifiche, ciò potrebbe portare a una vasta guerra regionale. A quel punto,
addio al califfato e alla Palestina. E lunga vita al fondamentalismo.

72
Scheda ____________________________
I FRATELLI MUSULMANI (AL
POTERE) (*)
EGITTO: Ḥizb al-ḥurriyya wa l-ʿadāla, partito Libertà e Giustizia (Fratelli
musulmani), attualmente al potere e già fortemente contestati a fine 2012.
TUNISIA: Ḥarakat an-Nahḍah, Movimento
della Tendenza islamica (en-Nahda), attualmente al potere. PALESTINA:
Jihad islamico; Hamas,
attualmente al potere nella Striscia di Gaza.
MAROCCO: Hizb al-adāla wa
at-tanmia, partito Giustizia e Sviluppo, attualmente alla presidenza del
Parlamento.
TURCHIA: Adalet ve Kalkınma
Partisi -Akp (Giustizia e Sviluppo), attualmente al potere.
GIORDANIA: Fronte di azione
islamico, che ha una rappresentanza in Parlamento (pur non essendo al governo).
I SALAFITI (ALL’OPPOSIZIONE)
Esistono più di un
centinaio di gruppi salafiti nel mondo. Precursori dei salafiti jihadisti
furono i mujahidin dell’AFGHANISTAN, al tempo della lotta contro l’Unione
Sovietica.
ALGERIA: Gia («Gruppo
islamico armato») e Movimento islamico
armato sono il braccio armato del Fis, «Fronte islamico di salvezza». Il Gia è oggi disciolto.
ALGERIA E MAROCCO: Gruppo
salafita per la predicazione e il combattimento, ora al-Qaida nel Maghreb
islamico.
MAROCCO: Gruppo
islamico combattente marocchino; Assirat
al-Mustaqim (La retta via).
TUNISIA: vari gruppi
salafiti.
EGITTO: al-Jihād
al-Islāmī; al-jamāʻah
al-islāmīyah; Jund Allāh (I soldati di Dio); al-Takfīr wa l-Hijra; Ansār
al-Islām. YEMEN: Esercito islamico Aden
Abyan.
LIBIA: Gruppo combattente
islamico libico. IRAQ: al-Qaida; Ansār
al-Islām.
GIORDANIA: Esercito di
Muhammad.
SIRIA: dopo l’inizio
della rivolta contro il regime della
famiglia al-Assad, sono presenti al-Qaida, gruppi jihadisti vari, finanziati da
Qatar e Arabia Saudita.
ARABIA SAUDITA: è la
patria del salafismo wahhabita, di al-Qaida e di molte organizzazioni
terroristiche. Paradossalmente, questo paese oscurantista e dittatoriale è
alleato dell’Occidente nella lotta al «terrorismo islamico» che esso stesso
alleva e finanzia.
(*) Per le voci in lingua
araba: sulla rivista si è usata la
traslitterazione ufficiale, che può non apparire totalmente corretta in queste
pagine web per questione di fonti.
Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabella normale";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
}
__________________________________
FONTI:
Le Monde Diplomatique (2011-2012), Al-Hiwar (Centro
Peirone, Torino), Asia News, Nigrizia, i saggi citati in bibliografia e altri
testi di geopolitica, italiani e stranieri. Mentre questo Dossier viene chiuso
(30 novembre 2012, il giorno seguente all’accettazione della Palestina come
«stato osservatore» all’Onu), sono in corso dinamiche complesse e
contraddittorie (si vedano le proteste egiziane di fine novembre 2012 contro il
presidente Mursi e i Fratelli musulmani) che rendono difficile tracciare delle linee
nette nelle alleanze e nei conflitti in atto.
Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabella normale";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
}
Angela Lano