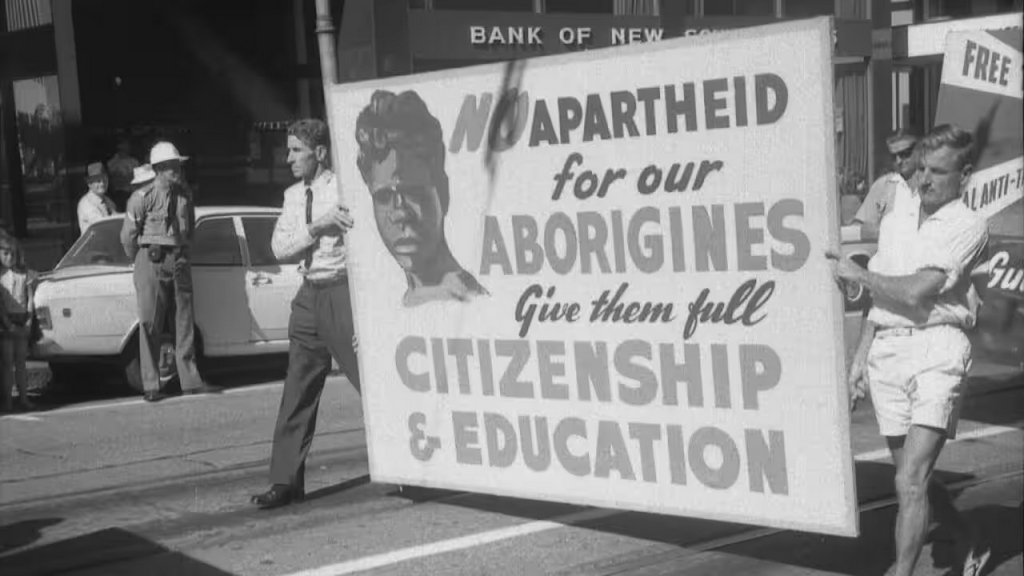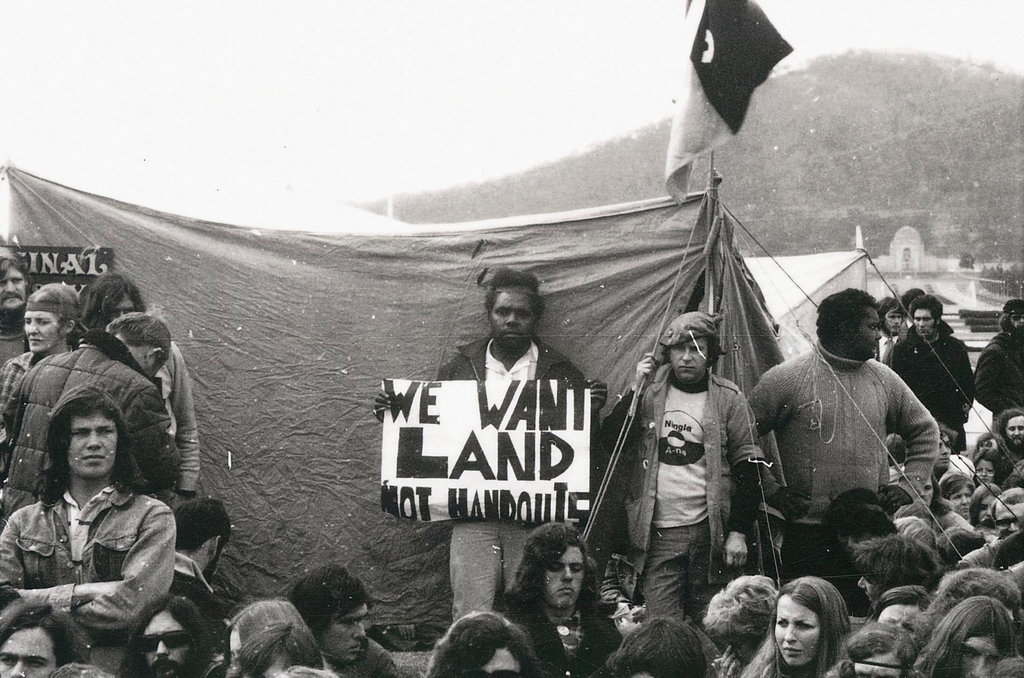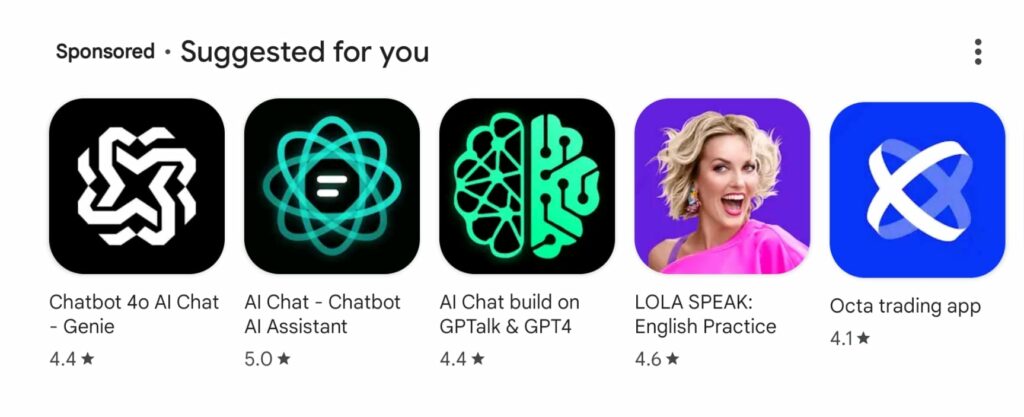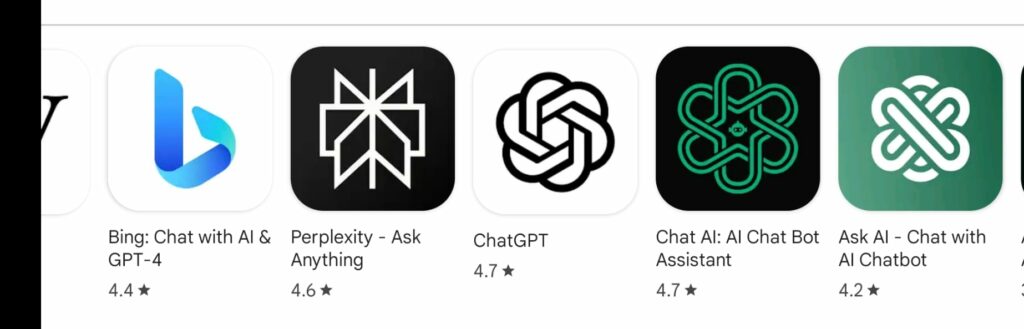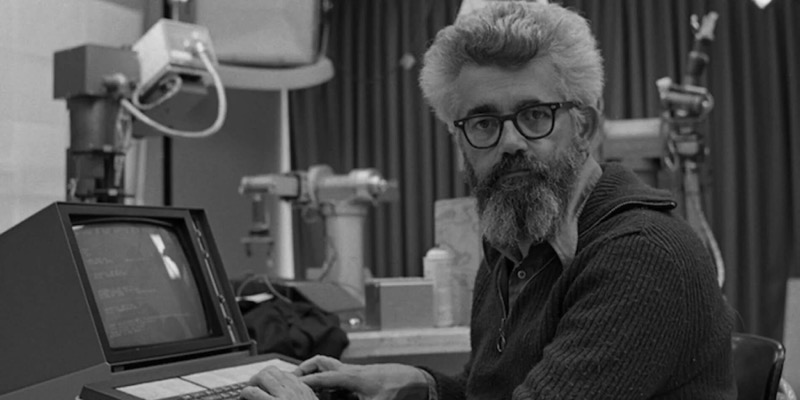La guerra calda globale
Mentre l’umanità è sull’orlo di una nuova guerra mondiale, decisori e grandi media ripetono: «Se vuoi la pace prepara la guerra». Un pensiero magico che occorre contrastare con strumenti razionali e nonviolenti.
Nel 2007 le Nazioni Unite, su proposta del governo indiano, dichiararono Giornata internazionale della nonviolenza il 2 ottobre, anniversario della nascita di Mohandas
Karamchand Gandhi.
Allora, quasi nessuno immaginava che nel giro di tre lustri l’umanità si sarebbe trovata sul punto di precipitare nel baratro di una nuova guerra mondiale.
La Seconda guerra fredda
Scrivo quasi nessuno, perché nel 2008 venne pubblicato in italiano il volume Affrontare il conflitto. Trascendere e trasformare, firmato da Johan Galtung, fondatore dei Peace studies, gli studi internazionali per la pace ispirati dall’opera di Gandhi.
In quelle pagine, lo studioso norvegese svolgeva un’operazione di diagnosi-prognosi-terapia riferita ai molti conflitti di quegli anni e agli scenari futuri sulle diverse scale (micro, meso, macro e mega), soffermandosi anche su quello della «Seconda guerra fredda», imputata all’agenda geopolitica degli Usa. «L’espansione globale a Est con la Nato, e a Ovest con l’Anpo, il Trattato di sicurezza Usa-Giappone», diagnosticava Galtung, aveva interesse a portare le alleanze «a linee di rottura radicali ed esplosive», tra Usa-Anpo-Nato da un lato e Russia-India-Cina dall’altro. Ma ciò, ed ecco la prognosi, non sarebbe durato a lungo: prevedeva Galtung, infatti, che sarebbe bastato «un incidente minore lungo il confine tra Polonia ed Ucraina, […], e queste faglie erutteranno lava come vulcani, con potenze nucleari dappertutto e senza alcun Paese neutrale in mezzo a fare da cuscinetto, come lo furono Finlandia, Svezia, Austria e Jugoslavia durante la “Prima guerra fredda”».

«Si vis pacem para bellum»
Oggi, finita la «Seconda guerra fredda», siamo dentro alla guerra calda globale. Questa si svolge contemporaneamente su molti fronti, dal Mediterraneo al Mar Rosso al confine russo-ucraino. Fronti che potrebbero rapidamente saldarsi, con seri rischi di carattere nucleare.
Di fronte a questo terrificante scenario, mentre Galtung con il suo lavoro propone precisi passi di disarmo e una radicale rifondazione dell’Onu – avendo anche elaborato e sperimentato manuali di «trasformazione dei conflitti con mezzi pacifici» per i mediatori -, i decisori e i media spingono per una nuova corsa agli armamenti.
Una corsa sempre più folle, fondata sulla menzogna originaria, una vera e propria formula magica, che recita «si vis pacem para bellum», se vuoi la pace prepara la guerra.
Un esempio su tutti è quello della lettera mandata a molti quotidiani europei da Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, al suo secondo mandato in scadenza il prossimo 30 novembre, che anticipava l’esito dell’assemblea dello scorso marzo chiudendosi proprio con queste parole: «Se vogliamo la pace dobbiamo prepararci alla guerra». Per non parlare del vertice Nato svoltosi a Washington il 10 e 11 luglio scorsi per i 75 anni dalla sua fondazione, che ha rilanciato la già massiccia corsa globale agli armamenti, cosa, quest’ultima, che per il nostro Paese comporta l’impegno a raggiungere velocemente una spesa militare pari al 2% del Pil, ossia a trasferire altri 10-12 miliardi all’anno di risorse pubbliche da scuola, università, sanità e welfare all’acquisto di nuovi armamenti, in aggiunta a quelli che già si spendono.
Il pensiero magico e guerra
Eppure, non è difficile dimostrare che preparare la guerra per avere la pace è un’illusione fondata sul pensiero magico, tenuta ancora in circolo per giustificare il trasferimento alle spese militari, e dunque all’industria bellica, di risorse pubbliche sottratte agli investimenti sociali e civili.
I governi di tutto il mondo non hanno mai speso così tanto per preparare la guerra (2.443 miliardi di dollari nel 2023, dati Sipri) e questo non ha impedito ai conflitti armati di dilagare ovunque (169 sul pianeta nel 2023, di cui 59 coinvolgono Stati, dati Uppsala conflict data program), facendo impennare il numero di vittime civili (il 72% in più nel 2023 rispetto al 2022, dati Onu), con il conseguente aumento di profughi e rifugiati (117 milioni nel 2023, giunti a 120 milioni nei primi sei mesi del 2024, dati Unhcr).
Preparando le guerre, dunque, non si ottiene – ovviamente – la pace, ma più guerre e più vittime, in un perverso circolo vizioso nel quale la prossima tappa – annunciata lo scorso 24 luglio dal nuovo Capo di stato maggiore britannico Roly Walker – prevede la Terza guerra mondiale entro il 2027.
Economia di guerra
In questa nuova corsa agli armamenti è pienamente coinvolto, da tempo, anche il nostro Paese: nel periodo 2013-2023 la spesa militare in Italia – rileva il Rapporto «Economia a mano armata» della campagna Sbilanciamoci – è aumentata del 30% e quella per i soli nuovi sistemi d’arma è passata da 2,5 miliardi a 5,9 miliardi di euro (+132%). Mentre, nello stesso periodo, l’investimento per la sanità è aumentato solo dell’11%, la spesa per la protezione ambientale del 6% e la spesa per l’istruzione appena del 3%.
Inoltre, specifica la Rete italiana pace e disarmo, la spesa militare italiana complessiva per il 2024 sarà di circa 28,1 miliardi di euro, con un aumento di oltre 1.400 milioni rispetto al 2023. Una crescita derivante soprattutto dagli investimenti in nuovi sistemi d’arma.
Ancora, come se non bastasse la spesa annuale, il milex.org, l’Osservatorio che monitora la dinamica delle spese militari italiane, informa che dall’inizio dell’attuale legislatura e fino a ora, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha trasmesso alle commissioni Difesa del Parlamento per avere il loro parere, sempre favorevole, ventisette nuovi programmi militari per un onere finanziario pluriennale di 34,6 miliardi di euro.
Insomma, mentre l’Istat segnala la crescente povertà assoluta nel nostro Paese, che colpisce ormai il 14% dei minori (il valore più alto della serie storica dal 2014), sul sito web di Leonardo, azienda di cui il Governo italiano è il principale azionista, che per il 75% produce armamenti, si legge: «Nei primi tre mesi del 2024 prosegue l’ottima performance del Gruppo già registrata nel 2023, con una solida redditività in tutti i segmenti di business, in ulteriore sensibile crescita rispetto al periodo precedente», con un +18,2% di ordini e un +20,8% di ricavi.
Una vera e propria economia di guerra.

Essere contro la guerra non è sufficiente
Quale uscita di sicurezza può esserci, dunque, da questo scenario nazionale e internazionale che si avvita perversamente nella logica bellica?
È di nuovo Galtung che ci viene incontro: «Essere contro la guerra è una posizione moralmente lodevole, ma non è sufficiente a risolvere i problemi delle alternative alla guerra e delle condizioni per la sua abolizione», scriveva in Pace con mezzi pacifici (Esperia, 1996). Ossia, occorre ricercare, formare e agire rispetto a tutta la filiera della violenza.
La violenza non si esprime solo nella dimensione manifestamente dispiegata ed esplicitamente distruttiva, come accade nei conflitti armati, ma ha delle componenti più profonde che, pur essendo implicite e nascoste, sono necessarie affinché la punta dell’iceberg della violenza propriamente detta emerga.
In un ideale «triangolo della violenza», se il vertice in alto è rappresentato dalla «violenza diretta», i due vertici della base sono la violenza strutturale e quella culturale.
La violenza strutturale è una violenza in sé – per esempio nelle forme dello sfruttamento economico o della repressione del dissenso -, ma anche la predisposizione delle strutture organizzative ed economiche che consentono la violenza e, in riferimento ai conflitti armati, le guerre: dagli eserciti alle spese militari, dagli armamenti alle cosiddette «banche armate».
La violenza culturale è quella forma pervasiva di giustificazione della guerra diffusa attraverso gli apparati formativi, i dispositivi mediatici, le curvature linguistiche che rendono la preparazione della guerra – e il suo impiego, variamente aggettivato – un fatto ovvio, da non mettere in discussione. Alimentando anzi, al bisogno, il bellicismo e l’odio verso il «nemico», ossia la propaganda di guerra.
E spesso chi produce e vende strumenti di guerra, produce e vende anche i media che la promuovono.
Trascendere i conflitti
Per queste ragioni l’impegno nonviolento, a differenza di quello genericamente pacifista, è indirizzato a decostruire tutto il sistema di violenza – non solo a contrastare questa o quella specifica guerra – e a costruire alternative nonviolente in riferimento a tutti i livelli esaminati. A cominciare dalla messa in campo della capacità di «trascendimento dei conflitti» (Galtung), ossia della loro trasformazione nonviolenta.
Ciò significa che non è il conflitto in sé a dover essere eradicato, in quanto i conflitti sono fisiologicamente generati dai differenti bisogni, ma la modalità violenta – e dunque patologica – della loro conduzione.
«Il maggior numero delle parti in conflitto», scriveva ancora Galtung, «ha qualche posizione valida: il lavoro sul conflitto consiste nel costruire una posizione accettabile e sostenibile a partire dal quel “qualcosa di valido”, per quanto minuscolo possa essere». È necessario, dunque, aiutare le parti a uscire dalla polarizzazione e dalla reciproca deumanizzazione.
Le tre caratteristiche necessarie, i tre saperi, per lavorare seriamente alla trasformazione de-polarizzante e umanizzante dei conflitti, sono l’empatia, ossia la capacità di vedere le cose anche dal punto di vista dell’avversario, la creatività, in quanto ricerca di soluzioni non scontate e prevedibili, e la nonviolenza, in quanto metodo che porta oltre il conflitto violento, lo trascende, appunto. Questi saperi sono indispensabili per stare al mondo in maniera non reciprocamente distruttiva, all’interno di sistemi complessi naturalmente generatori di conflitti. Agli antipodi di quelli messi in campo oggi da tutti gli apprendisti stregoni che alimentano le guerre anziché impegnarsi a spegnerle risolvendone i conflitti alla base.

Mezzi nonviolenti
Di fronte al bellicismo dei governi, ogni livello di violenza ha bisogno di essere dunque contrastato dal basso con adeguati strumenti e mezzi di nonviolenza, che interagiscono in modalità complessa e coerente.
Per esempio, rispetto alla violenza diretta delle guerre, è in corso la campagna nazionale e internazionale di «Obiezione alla guerra» del Movimento Nonviolento. Chi la sottoscrive, sostiene i tanti obiettori di coscienza, disertori e renitenti alla leva di tutte le parti coinvolte nei conflitti armati, e, allo stesso tempo, dichiara la propria personale obiezione di coscienza alla guerra e alla sua preparazione, esplicitando l’indisponibilità a qualunque «chiamata alle armi».
Rispetto alla violenza strutturale dell’accumulo degli strumenti di guerra, inoltre, è necessario intensificare l’impegno per il disarmo, a cominciare da quello nucleare, imponendo l’adesione anche del nostro Paese al Trattato internazionale per la messa al bando delle armi nucleari – come prevede la campagna «Italia ripensaci» – e per la riconversione sociale delle spese militari e quella civile delle industrie belliche, oltre a interrompere l’invio di armi e le collaborazioni militari con tutti i Paesi in guerra.
Rispetto alla violenza culturale, infine, la più difficile da decostruire, è necessario, prima di ogni altra cosa, contrastare il doppio standard etico che viene generalmente utilizzato per affrontare la violenza nei conflitti interpersonali e in quelli internazionali.
Per i conflitti interpersonali, infatti, è comune l’idea che si possano affrontare e risolvere in modo nonviolento anche tramite dispositivi formativi e giuridici di regolazione pacifica e sanzionamento della violenza. Per quelli armati, nazionali o internazionali, invece, è prevalente il pensiero magico dei vertici politico mediatici secondo il quale si ottiene più pace preparando più guerra, «etificando» la violenza, quando voluta dallo Stato, e sanzionando il suo rifiuto.
Il superamento di questo doppio standard morale, che promuove l’etica nonviolenta nei conflitti interpersonali ma il suo repentino «disapprendimento» e l’etica della violenza nei conflitti internazionali, metterebbe in crisi l’intero sistema della violenza: «Immagina che fanno la guerra e che nessuno ci va», scrisse Wolfgang Ness.
Qui si gioca, in ultima analisi, l’impegno formativo nonviolento, che deve contaminare i dispositivi culturali, mediatici ed educativi.
Pasquale Pugliese