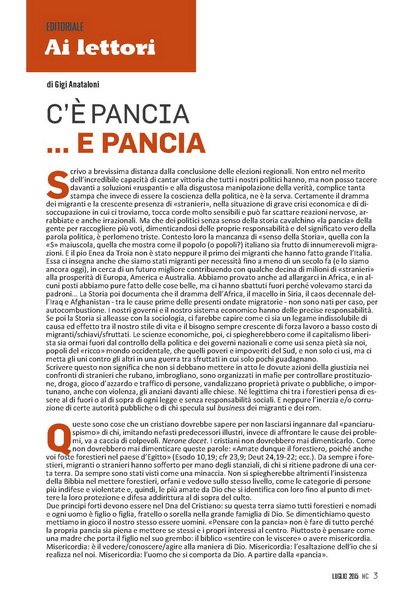Non lasciamoci rubare la gioia
«Cari fratelli e sorelle, non
lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione! Vi invito ad immergervi nella
gioia del Vangelo, ed alimentare un amore in grado di illuminare la vostra
vocazione e missione. Vi esorto a fare memoria, come in un pellegrinaggio
interiore, del “primo amore” con cui il Signore Gesù Cristo ha riscaldato il
cuore di ciascuno, non per un sentimento di nostalgia, ma per perseverare nella
gioia. Il discepolo del Signore persevera nella gioia quando sta con Lui,
quando fa la sua volontà, quando condivide la fede, la speranza e la carità
evangelica» (Francesco, Messaggio per la Giornata Missionaria 2014; cfr.
pag. 70).
Non lasciamoci rubare la gioia! Mi ha colpito molto questo invito
pressante del Papa. Dopo la sua esortazione apostolica sulla gioia del Vangelo
(Evangelii gaudium), ecco un nuovo richiamo non solo a essere giorniosi,
ma anche a difendere la gioia, quella vera, che nasce dall’incontro autentico,
profondo, personale e condiviso con Gesù.
Degli anni vissuti in Kenya mi manca molto la giorniosa celebrazione
della fede che si esprime anche in canti e danze, a volte troppo vivaci, ma
soprattutto nello stare insieme senza guardare l’orologio e in una
partecipazione corale in cui tutti si sentono attori e non spettatori. Quante
volte invece qui in Italia capita di celebrare la messa nella noia più
assoluta, per (non «con») gente frettolosa o addirittura per «spettatori»
completamente spaesati e incapaci di contribuire, nonostante i lontani ricordi
del catechismo e un battesimo ormai rimasto solo sulla carta. Funzione, non
celebrazione e festa, specchio di una religione in cui, malgrado gli sforzi di
tanti pastori, prevalgono i riti. Le chiese, belle e restaurate ma ridotte a «beni
culturali» e attrazioni turistiche, non sono più il luogo dell’assemblea
giorniosa della famiglia di Dio che vi celebra l’esperienza del perdono,
dell’accoglienza e della pace.
Anche nel cuore di chi si dice cristiano Dio è stato messo al margine,
soppiantato da nuovi «dei» nei cui «templi» si celebrano i modei riti del
divertimento per scaricare le tensioni di una vita frustrata e per dimenticare
che si è schiavi di un sistema consumistico volto prima di tutto a svuotare gli
individui dal di dentro e a rubare loro la speranza.
Certo, la domanda di felicità è sempre
altissima. Nessuno vuole vivere per essere infelice. Ma una società come la
nostra che privilegia l’avere sull’essere, il diritto sul dovere e l’io sul
noi, non può che lasciare l’amaro in bocca, perché la felicità non si compra. I
soldi possono pagare per il divertimento, il piacere, lo sballo, la
trasgressione, il lusso, il potere. Ma la felicità si ha solo donandola,
condividendola, facendo felici gli altri. è
questo il segreto di Gesù: perdere la vita per ritrovarla, morire per vivere. è il segreto di perdonare per essere
perdonati, dell’amare perché amati.
L’appello di papa Francesco è
più attuale che mai. Non possiamo lasciarci rubare la gioia di questa via alla
felicità: più uno si lascia prendere dal Signore Gesù e dalla logica della sua
Parola, più uno sperimenta un senso di pace, di serenità, più uno diventa
positivo e tollerante verso gli altri e meno ansioso verso gli accadimenti
quotidiani: il mangiare, il vestire, l’opinione altrui, la moda, il «così fan
tutti». Più uno lascia che Gesù diventi il «suo Signore», e più è capace di
empatia, di essere partecipe di giornie e sofferenze, attento ai bisogni di
tutti. Non è un cammino facile, le resistenze sono tante, l’orgoglio è forte.
Ma più uno si lascia «evangelizzare» più la gioia cresce. Niente di miracoloso,
certo, ma uno si scopre sempre più capace di meravigliarsi, di ringraziare e di
giornire delle piccole cose, con una desiderio di bellezza (purezza, onestà,
integrità) che lo fa reagire, anche con energia, a tutto ciò che è falso,
ingiusto, corrotto, umiliante, infanga la dignità della persona e uccide la
grandezza «dell’infante» che è dentro di lui. «Non lasciarci rubare la gioia» è
quindi resistere a un sistema che ci vuole appiattire e cosificare, rubandoci i
sogni e l’innocenza, infangando l’immagine di Dio che è in noi e che Gesù
Cristo, sulla croce, ha restaurato alla sua bellezza originale. Non lasciarci
rubare la gioia significa mantenere una relazione viva con Gesù Cristo,
l’Emmanuele Dio-con-noi e in mezzo a noi, senza rassegnarsi al fatto che venga
ridotto a un mero marchio di identità culturale sulle pareti di luoghi
pubblici. Sarebbe meglio invece che fosse come il crocefisso delle vecchie
edicole delle strade e sentirneri di campagna e montagna: compagno di viaggio nel
difficile cammino della vita.
LEGGI TUTTA LA RIVISTA COME PDF SFOGLIABILE!
Gigi Anataloni

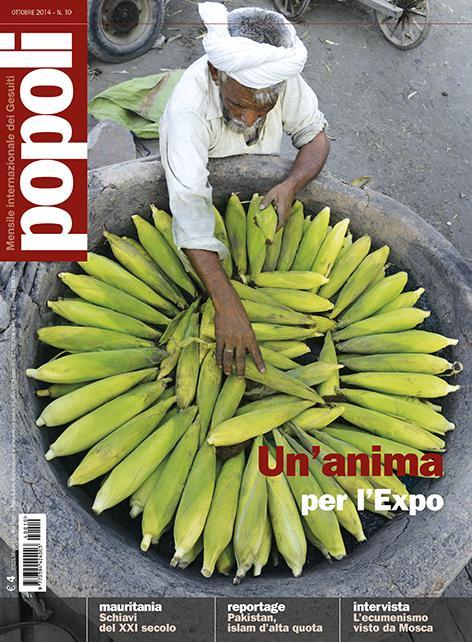 L’editoriale di ottobre della
L’editoriale di ottobre della