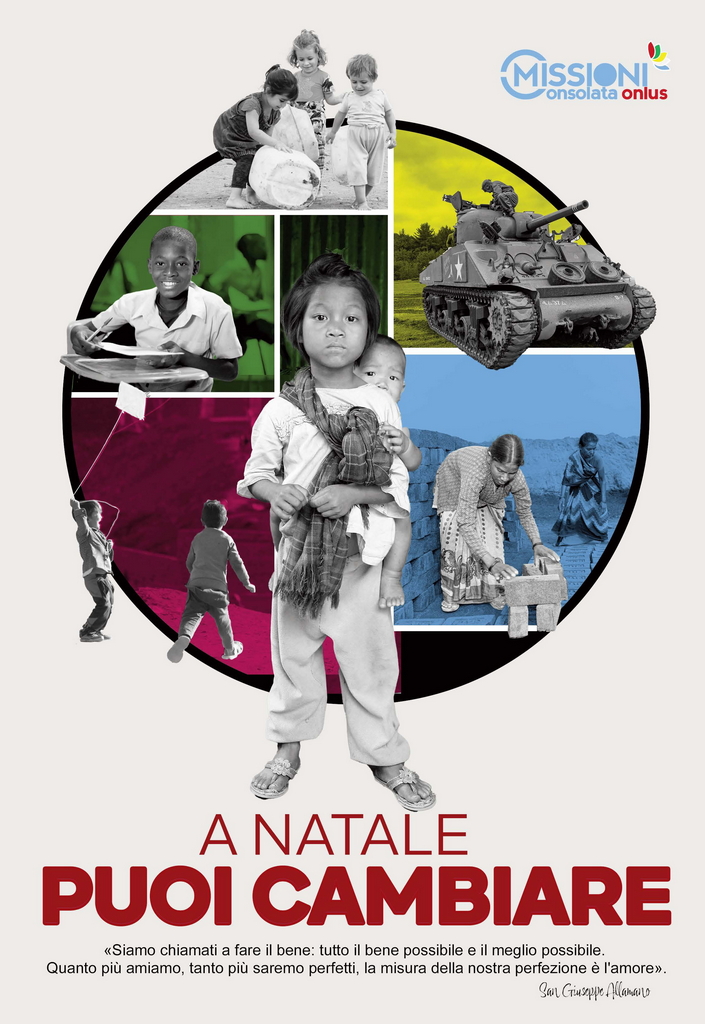Nel settembre scorso i missionari della Consolata hanno festeggiato i primi dieci anni di presenza a Taiwan, in particolare nella diocesi di Hsinchu. Il vescovo John Baptist Lee ha celebrato una messa molto partecipata nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Hsinchu (vedi pag. 5). Oggi l’istituto è presente con sette missionari di cinque diverse nazionalità (Kenya, Tanzania, Corea del Sud, Brasile e Argentina) e ha la gestione di tre parrocchie nella stessa diocesi, oltre a Hsinchu, animata dal 2017, anche Xinpu e Xinfong.
Un primo decimo anniversario, che pare poca cosa, ma rivela una presenza discreta, continua e con prospettive di crescita.
Ho avuto la possibilità di partecipare all’evento al Sacro Cuore e di visitare le altre due parrocchie. Ho potuto vedere e ascoltare persone impegnate nella vita della comunità, ma anche molto accoglienti verso chi viene da fuori. Peter e sua moglie Jennifer, Carmen, Lucia, Cathy, solo per citarne alcune, senza volere fare torto alle altre.
Taiwan, ufficialmente Repubblica di Cina, viene più volte citata anche sui nostri media come centro di tensioni tra la Repubblica popolare di Cina (la Cina comunista continentale) e gli Stati Uniti. Ma è ben più di questo. Vorrei dare qualche elemento della società nella quale stanno operando i missionari da dieci anni.
Si tratta di una società moderna, anzi una società che definirei «tecnologica», dove cioè la tecnologia ha un peso rilevante. Con le relative problematiche: secolarizzazione, i giovani in particolare sentono poco il richiamo della spiritualità di tipo convenzionale, quindi delle religioni, la bassa crescita demografica e l’alto livello di invecchiamento della popolazione che comporta le criticità conosciute anche da noi, le migrazioni da paesi vicini più poveri (in particolare da Filippine, Vietnam, Indonesia, Thailandia).
A Taiwan, inoltre, la Chiesa cattolica è una minoranza tra le minoranze, interessando l’1,3% della popolazione (i fedeli sono circa 300mila su 23 milioni di taiwanesi).
Il vescovo di Hsinchu, monsignor Lee, mi diceva che su settanta sacerdoti della sua diocesi solo due sono originari del Paese. Gli altri sono missionari. Molti sono coreani, poi vietnamiti, filippini e, recentemente, africani. Tutto questo denota la necessità e l’urgenza della missione ad gentes.
Guardando sul planisfero le presenze dei missionari e missionarie della Consolata nel mondo, la missione a Taiwan è forse quella nella società più moderna.
Per contrasto, il mio pensiero va a un’altra missione, che ho avuto la possibilità di visitare molti anni fa. Quella di Catrimani, nello stato di Roraima in Brasile. Una presenza nel mezzo della foresta amazzonica, dove si può arrivare solo a piedi o con piccoli aerei. Un cammino, quello a fianco del popolo Yanomami, che la Consolata porta avanti oramai da 59 anni.
Se penso alla società yanomami, a lungo studiata da generazioni di missionari della Consolata, con la sua lingua (anzi, quattro), le sue credenze, la sua cultura, credo che sia quella meno tecnologica, quella che vive maggiormente in simbiosi con la natura, con la quale i missionari della Consolata si siano confrontati da decenni. In un certo senso, una struttura sociale delicata, che rischia in ogni momento di essere sopraffatta dalla società dominante, quella dei «bianchi», come dicono in Brasile, quella moderna, dico io.
Due ambienti sociali che sembrano, o forse sono, in antitesi. Due culture entrambe distanti da quelle dei missionari che le affrontano, difficili da comprendere e far proprie con un processo di inculturazione, a partire dalle lingue, dai costumi e dalla spiritualità.
Eppure due contesti nei quali i missionari della Consolata sono presenti con il loro approccio ad gentes, ma anche di promozione umana, sociale e dei diritti che da sempre li contraddistingue.
Questo mi fa credere che la missione pensata e maturata da san Giuseppe Allamano prima, e dai suoi missionari e missionarie poi, sia a tutti gli effetti universale e senza confini.