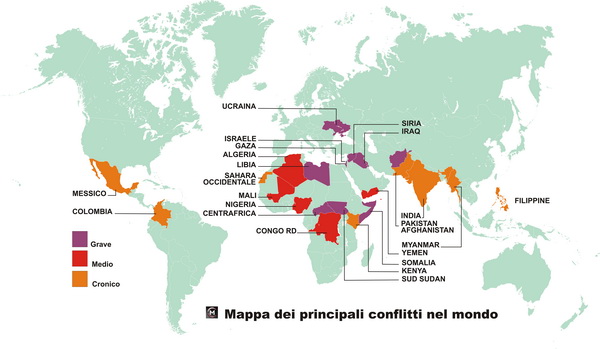L’Islam e la guerra del Califfo.
Dietro lo «Stato
islamico» (Is – Islamic State)
Clicca sull’immagine per leggere tutto il dossier inclusivo dei box nello sfogliabile pdf
 Nessuna compassione per
Nessuna compassione per
gli «infedeli»
L’islamismo radicale
si sta diffondendo in molte regioni. Gli attori sono molti, ma oggi il
principale si chiama «Stato islamico» (Is). Guidato dal califfo
(autoproclamato) al-Baghdadi, l’Is si basa su alcuni concetti chiave: l’Islam è
la soluzione e l’Is ne è l’unico vero custode; i paesi occidentali, guidati da
miscredenti, sono responsabili dei problemi in Medio Oriente; i governanti
locali sono agenti cornoptati dall’Occidente. In queste pagine cercheremo di
capire perché e come nasce l’Is. Tra alleanze cangianti e propaganda mediatica,
le sorprese non mancano.
Azioni di guerra, conquiste
territoriali, decapitazioni, esecuzioni, rapimenti, violenze di ogni genere.
L’islamismo radicale e conquistatore, si potrebbe dire «colonizzatore», si sta
diffondendo nel Maghreb, nell’Africa subsahariana e in ampie regioni
mediorientali, dalla Siria all’Iraq.
Il network di al-Qa‛ida (per comodità, d’ora in poi: al-Qaida) e le
sue nuove filiazioni, comprese le antagoniste (come vedremo), stanno diventando
un potentato, grazie alla conquista dei pozzi petroliferi in varie aree e alle
armi ricevute dai paesi occidentali (Stati Uniti, Europa) e sunniti (Turchia,
Qatar, Arabia Saudita).
In particolare, il 2014 è stato
segnato dalle gesta del gruppo che, lo scorso giugno, ha annunciato la nascita
dello «Stato islamico di Iraq e Siria»1 (Is, da Islamic State, come si legge anche in Dabiq,
la rivista in lingua inglese e grafica modea edita dall’organizzazione), e ha
invitato al-Qaida e altri gruppi a stipulare un’alleanza per una «nuova era di
jihad internazionale».
Quello attuale è un caso complesso
di fondamentalismo, nel quale si mescolano religione (nella sua visione più
oscurantista, arretrata e reazionaria), un uso sfrontato dei mezzi di
comunicazione di massa (video, internet, social network, riviste come il già
citato Dabiq), un ampio arsenale bellico, ingenti capitali provenienti
anche dall’accaparramento delle fonti petrolifere, rabbia e aggressività verso
l’Occidente invasore e «infedele» (kafir), odio settario contro le
minoranza religiose e etniche, e contro gli apostati (kuffar e murtadin)
musulmani (tutti coloro, cioè, che non condividono la linea politico-religiosa
dell’Is), lotte intee, vendette e orgoglio sunnita dopo anni di dominazione
sciita e alawita in Iraq e Siria, e altro ancora. Si tratta di un fenomeno
aggressivo, spettacolare fino alla teatralità più macabra che riscuote successo
sia nel mondo arabo-islamico sia in Occidente, in particolare tra le giovani
generazioni di immigrati musulmani.
Così, tra i jihadisti, troviamo:
benestanti e laureati (molti arrivano dall’Europa e dagli Usa); giovani
emarginati delle periferie urbane occidentali e arabe alla ricerca della
propria identità e dai progetti di integrazione falliti; poveri e disperati
delle città e villaggi del mondo arabo-islamico invaso dalle truppe americane;
oppressi da regimi dispotici locali o stranieri; notabili e membri di tribù
sunnite che vogliono vendicarsi dei loro vicini o di leader di altre fazioni
islamiche; ovviamente mercenari e larghe schiere di criminali e psicopatici. È
un «melting pot» trasversale a luoghi, censo e età, e catalizzatore di
sentimenti e aspirazioni contrastanti e differenti. Indubbiamente, ciò che li
contraddistingue è la rabbia e la ferocia con la quale si abbattono su città e
villaggi e su chi osa rifiutarli, e contro le minoranze etniche e religiose.
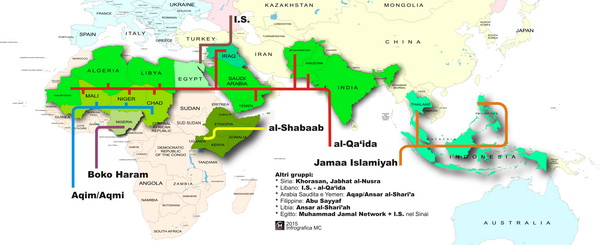
Il nuovo
fondamentalismo dell’Is
Questo fondamentalismo non è più
solo un luogo semantico in cui sono verbalizzate le differenze tra Occidente e
Oriente, tra «voi» e «noi», tra «infedeli» e «credenti». È una separazione
materiale, un’esclusione e eliminazione fisica della «differenza», dell’alterità,
nel nome di una credenza soggettiva di un’appartenenza a un gruppo religioso
ritenuto «eletto» e per tanto migliore e più fedele alla «Verità» rispetto a
tutti gli altri. È un’adesione a una linea di «parentela» religiosa stretta,
escludente e discriminante, che, attraverso un «patto» di fedeltà, crea una
sorta di «coscienza storica» di gruppo che include chi vi aderisce rispettando
alla lettera norme e vincoli, e elimina chiunque non vi si riconosca del tutto.
 Tuttavia, il patto in sé può non
Tuttavia, il patto in sé può non
essere sufficiente. L’unità della «comunità» deve fondarsi su un insieme di
riferimenti identitari, nel caso dell’Is, politico-culturali e religiosi. Ne
risultano, così, un senso di appartenenza e un sentimento tanto potenti quanto
irrazionali, che creano razzismo e xenofobia verso tutti gli altri, ma che
foiscono al movimento un’identità e una coesione forti, dai caratteri
specifici: la religione è l’Islam (nella versione radicale e intollerante), la
lingua comune è l’arabo (lingua sacra, in quanto emanata dal Corano), il
territorio è lo Stato islamico di Iraq e Siria, ma con una velleità di Dar
al-Islam (Casa dell’Islam, in contrapposizione al Dar al-Kuffar,
Casa della Miscredenza, cioè i territori non ancora islamizzati) in continua
espansione, e dunque in versione «colonizzatrice».
Il prodotto finale assomiglia,
quindi, più alla concezione modea di nazione, con tutto l’apparato coloniale
al seguito, che a un neocaliffato nello stile del vecchio Impero
arabo-islamico, dove alla conquista di immensi territori non corrispondeva
l’assimilazione forzata dei popoli vinti, bensì quella dei conquistatori alle
culture dei paesi conquistati.
Al confronto dei grandi Imperi
omayyade (661 – 750), abbaside (750 – 1258) e ottomano (1281 – 1923),
l’intollerante e escludente Is risulta velleitario nei suoi progetti. E,
soprattutto, poco musulmano, in senso tradizionale.
L’introduzione di fattori di
modeità è, infatti, evidente in alcuni suoi elementi: 1) la concezione dello
Stato-nazione fondato sull’origine comune e mitizzata di una «Medina, città
ideale» (in quanto è la città dove emigrarono nel 622 i primi musulmani,
perseguitati dai politeisti de La Mecca, e dove crearono la prima comunità di
fedeli, la ummah), stretta intorno al suo novello capo, Abu Bakr
al-Baghdadi che, nonostante non si sappia veramente chi sia, viene fatto
discendere dalla famiglia di Muhammad, attraverso il nome al-Qurashi (la tribù
cui apparteneva il profeta dell’Islam). 2) L’accaparramento e lo sfruttamento
delle risorse petrolifere dei territori conquistati, del denaro (transazioni
economiche di varia natura). 3) L’uso dei mezzi di comunicazione di massa. Il
progetto di jihad (inteso come sforzo bellico, guerra) globale, infatti, è
ripreso nei social network, dove si spazia dal proselitismo al reclutamento di
combattenti, dall’incoraggiamento della lotta contro gli infedeli (dai non
musulmani fino ai musulmani sciiti, ai sunniti non allineati o ad altre
minoranze) fino alla lotta contro i «corrotti costumi occidentali» e alla
certezza che l’Europa sarà islamica, e così via2.
Ciò che a fine Ottocento nell’Islam
fu una ricerca religiosa riformista, di ritorno alla purezza delle origini, ai
fondamenti della fede (questo significa «fondamentalismo» e, in particolare, in
uno dei suoi aspetti che è il salafismo, da salaf, «pii antenati», cioè
i primi fedeli della neonata comunità musulmana), anche in reazione al
colonialismo occidentale, è stata trasformata in una ideologia
politico-religiosa con tre direttrici differenti: 1) la quietista, quella dei
puristi, dedita più che altro alle opere caritatevoli e alla missione (da’wa)
catechistica; 2) l’Islam militante che mira a ristabilire il «califfato», senza
l’uso della violenza ma attraverso il cambiamento pacifico dei governi (come
avvenuto con la Fratellanza musulmana); 3) il salafismo jihadista, o
neosalafismo, che ha l’obiettivo di ricreare il califfato attraverso il jihad,
inteso come guerra e violenza. È quest’ultimo il caso del network di
al-Qaida nelle sue varie sigle e filiazioni sparse tra Africa e Asia, e del
figlio ribelle, l’Is, ovvero il Califfato islamico di Siria e Iraq.
Quest’ultimo gruppo, in
particolare, è considerato dall’Islam ortodosso una deviazione dal «giusto
sentirnero», dalla tradizione profetica, in quanto, come abbiamo visto, introduce
notevoli elementi di modeità, rifacendosi a un Islam wahhabita (secolo
XVIII), considerato una sorta di deriva politico-religiosa.
Nascita e diffusione
del wahhabismo
«Non si può capire l’Is se non si
conosce la storia del wahhabismo in Arabia Saudita»: è il titolo di
un’interessante analisi di Alastair Crooke3. L’autore, un ex agente dei
servizi segreti britannici, spiega come l’attuale Stato islamico di Iraq e
Siria prenda origine dal pensiero di Mohammad ibn Abd al-Wahhab, studioso e
riformatore arabo vissuto tra il 1703 e il 1792, legato, a sua volta, alla
dottrina predicata da Ibn Taymiyyah (1263-1328).
Abd al-Wahhab, così come Taymiyyah
prima di lui, era convinto che la società musulmana dovesse rifarsi al periodo
trascorso dal profeta Muhammad a Medina, i cosiddetti «Tempi d’oro»: questa è
la base della corrente del salafismo.
Taymiyyah condannò sciismo, sufismo
e filosofia greca e si dichiarò contrario alle visite alla tomba del profeta e
alla commemorazione del suo compleanno, definendo tali comportamenti come shirk,
politeismo e idolatria, una imitazione, cioè, della venerazione cristiana di
Gesù considerato come figlio di Dio.
Abd al-Wahhab adottò questi
insegnamenti, affermando che «qualunque dubbio o esitazione da parte dei
credenti», rispetto a questa sua personale interpretazione dell’Islam, dovesse «privare
un uomo dell’immunità, delle sue proprietà e della sua vita».
Uno dei principali precetti della
dottrina di Abd al-Wahhab, ci ricorda Crooke, è l’idea cardine di takfir.
«Abd al-Wahhab denunciava tutti i musulmani che onoravano i defunti, i santi o
gli angeli. Riteneva che tali sentimenti sminuissero la completa sottomissione
nei confronti dell’unico Dio. Esigeva conformismo, che doveva essere dimostrato
in modo fisico e tangibile. Sosteneva che tutti i musulmani dovessero
individualmente giurare fedeltà a un unico leader musulmano (un Califfo, se ce
n’era uno). Egli scrisse: “Coloro che non si adegueranno a questi precetti
dovranno essere uccisi, le loro mogli e figlie stuprate e i loro possedimenti
confiscati”». Ed è ciò che affermano e praticano i membri dell’Is e le altre
bande di al-Qaida.
Tra gli apostati degni di morte
c’erano (e ci sono ancora oggi) sciiti, sufi e altre scuole islamiche, che i
wahhabiti non ritengono musulmani».
L’alleanza tra Abd al-Wahhab e Ibn
Saud (fondatore e primo sovrano dell’Arabia Saudita) e la sua tribù, nel 1741,
portò il wahhabismo al potere. «Il clan di Ibn Saud – afferma Crooke -,
riprendendo la dottrina di Abd al-Wahhab, poteva fare quello che aveva sempre
fatto, cioè razziare i villaggi vicini e impossessarsi dei loro beni. Solo che
ora lo stava facendo non più nell’ambito della tradizione araba, ma sotto la
bandiera del jihad. Ibn Saud e Abd al-Wahhab introdussero nuovamente l’idea del
martirio nel nome del jihad, garantendo ai martiri immediato accesso in
Paradiso.
All’inizio, conquistarono poche
comunità locali e imposero le loro leggi. I popoli sottomessi non avevano molta
scelta: la conversione al wahhabismo o la morte. (…) La loro strategia – come
quella dell’Is oggi – consisteva nel sottomettere i popoli conquistati, mirando
a instillare il terrore».
Risulta dunque abbastanza evidente
che non ci sono grandi differenze tra wahhabismo e ideologia dell’Is se non
quando emerge l’istituzionalizzazione della dottrina di Muhammad ibn Abd
al-Wahhab: «una regola, una autorità, una moschea».
«Questi tre pilastri fanno
esplicito riferimento al re saudita, autorità assoluta del wahhabismo ufficiale
e al suo controllo “della parola” (cioè, la moschea).
La negazione da parte dell’Is di
questi tre capisaldi, sui quali l’intera autorità sunnita poggia tuttora, è la
frattura che rende l’Is – gruppo che sotto ogni altro aspetto rispetta e si
conforma al wahhabismo – una minaccia per l’Arabia Saudita».
Gli interessi
divergenti di Arabia Saudita e Stato islamico
Chi ha familiarità con questa parte
di storia del mondo arabo-islamico non ha difficoltà a comprendere il legame
tra gli eventi del passato e le gesta dell’Is nell’Iraq odierno. Dopo un
periodo di eclissi, il wahhabismo toò a imporsi con il crollo dell’impero
ottomano, durante la prima guerra mondiale.
Spiega Crooke: «Gli Ikhwan4 erano la reincarnazione di quel
movimento feroce e semi-indipendente, dei “moralisti” wahhabiti, armati, che
quasi erano riusciti a conquistare l’Arabia nei primi anni del XIX secolo. (…)
Il wahhabismo subì una trasformazione forzata da movimento di rivoluzione
jihadista e di purificazione teologica takfiri a movimento di
conservazione sociale, politica, teologica e da’wa religiosa
(proselitismo islamico) e per giustificare l’istituzione che sosteneva la lealtà
alla famiglia reale saudita e al potere assoluto del re».
Con l’era del petrolio e dei suoi
enormi proventi, i sauditi cominciarono a diffondere e divulgare il wahhabismo
all’interno del mondo musulmano, a «wahhabizzare» l’Islam, creando una
religione a parte, chiusa e unificata in un’unica visione non più pluralista.
Aggiunge Crooke: «Miliardi di
dollari furono investiti – e lo sono tuttora – in questa manifestazione di soft
power. Tutto ciò, unito alla volontà saudita di orientare l’Islam sunnita
secondo gli interessi americani (…) creò una politica occidentale di dipendenza
dall’Arabia Saudita, una dipendenza che dura dall’incontro di Abd-al Aziz con
Roosevelt a bordo di una nave da guerra statunitense (di ritorno dalla
Conferenza di Yalta) fino ad oggi».
L’Is è wahhabita, ma con un
radicalismo diverso. Vari studiosi ritengono che potrebbe essere definito come
un movimento neo-wahhabista o una sorta di «correzione» del wahhabismo.
«L’Is – scrive Crooke – è un
movimento “post-Medina”: si rifà alle pratiche dei primi due califfi, piuttosto
che al profeta Muhammad in persona, come fonte di emulazione, e nega fermamente
l’autorità saudita. Mentre la monarchia saudita fioriva nell’era del petrolio
come istituzione sempre più vasta, l’interesse verso il messaggio Ikhwan
guadagnò terreno (a dispetto della campagna di modeizzazione di Re Faisal).
L’approccio Ikhwan ha goduto – e gode tuttora – del sostegno di molti uomini,
donne e sceicchi di spicco. Da un certo punto di vista Osama bin Laden
incarnava perfettamente l’approccio Ikhwan nella sua tarda fioritura.
(…) Nella collaborazione alla
gestione della regione da parte dei Sauditi e dell’Occidente, all’inseguimento
dei tanti progetti occidentali (la lotta al socialismo, al ba’athismo, al
nasserismo, al sovietismo e all’influenza iraniana), i politici occidentali
hanno sostenuto la loro interpretazione preferita dell’Arabia Saudita (la
ricchezza, la modeizzazione e l’influenza), scegliendo tuttavia d’ignorae
l’impulso wahhabita».
Il radicalismo islamico era
considerato dai servizi segreti statunitensi come un utile strumento (useful
asset)5 per destabilizzare e sconfiggere
l’Urss in Afghanistan e, negli anni delle «Primavere arabe»6, è stato usato per abbattere
regimi arabi che ormai non erano più sostenibili o utili.
Si chiede dunque Crooke, e con lui
molti altri analisti e studiosi di geopolitica del Medio Oriente: «Perché
dovremmo essere sorpresi se dal mandato saudita-occidentale del principe Bandar
di gestire l’insorgenza siriana contro il presidente Assad sia poi emerso un
tipo movimento d’avanguardia neo-Ikhwan, violento e spaventoso come l’Is? E
perché mai dovremmo stupirci – conoscendo un po’ il wahhabismo – se i rivoltosi
“moderati” siriani sono diventati più rari del mitico unicorno? Perché avremmo
dovuto immaginare che il wahhabismo radicale avrebbe generato dei moderati?».
Si tratta certamente di un calcolo
che gli strateghi statunitensi avranno fatto, machiavellicamente, scegliendo
nuovamente un utile strumento per giustificare un’altra fase dello «scontro di
civiltà».
Coltelli e cellulari
satellitari: il Medioevo tecnologico dello Stato islamico
«Arriveremo fino a voi, invaderemo
l’Europa e distruggeremo l’America, renderemo schiave le vostre donne e orfani
i vostri figli come voi avete fatto con noi», così dichiara, quasi piangendo,
un combattente nel video sull’Is prodotto dall’agenzia Vice News nell’estate
del 20147. È un interessante, e inquietante,
servizio giornalistico embedded sul «Califfato islamico di Iraq e Siria»,
che spiega abbastanza chiaramente su quali punti si basino la propaganda e le
azioni delle bande islamiste: rabbia anti occidentale e orgoglio ferito dalle
politiche neocoloniali di Stati Uniti ed Europa, e uso strumentale della
religione come arma di vendetta, riscatto e conquista o «riconquista» dei territori
un tempo appartenenti agli Imperi omayyade (con capitale Damasco) e abbaside
(con capitale Baghdad) – da cui fanno derivare il nome di Califfato di Siria e
Iraq.
Le parole piene di collera e
rancore dell’uomo nel video ci rimandano immediatamente a 20 anni di guerra
contro l’Iraq da parte di Stati Uniti e alleati, alle vergognose immagini di
Abu Ghreib (il carcere statunitense nei pressi di Baghdad, dove i detenuti –
tra cui molti innocenti – venivano torturati e umiliati) o a quelle di
Guantanamo, o alle tante donne, anche bambine, stuprate dalla soldataglia delle
truppe di invasione.
Migliaia e migliaia di morti,
feriti e immane distruzione per portare la «civiltà occidentale» in Medio
Oriente, o meglio, per controllae le fonti petrolifere.
Da tutto ciò deriva una rabbia
immensa, un combustibile pronto a essere utilizzato alla prima occasione.
Occasione colta dall’abile califfo Abu Bakr al-Baghdadi.
Nella rivista online Dabiq,
l’Is incita alla conquista del mondo islamico e alla guerra contro l’Occidente,
alla segregazione delle donne, alla violenza contro le minoranze religiose e
etniche, e i sunniti che non condividono il progetto di jihad.
La tecnologia è usata come mezzo
per espandere la colonizzazione dei territori e per fare proseliti. Si tratta,
come abbiamo accennato, di una islamizzazione della modeità, che crea una
sorta di paradosso: i cellulari satellitari convivono con i coltelli per
sgozzare i nemici; i social network con le donne costrette a nascondersi in
casa. L’età della pietra e il futuro mescolati insieme nel jihad globale
contro i kuffar di ogni fede, musulmani compresi, in un delirio di
onnipotenza.
In questo scenario, l’aspetto
religioso, sempre presente e molto potente, agisce da catalizzatore di elementi
pronti al martirio per liberare il mondo islamico, e magari anche l’Europa,
dagli infedeli (kuffar) e dagli apostati (rafid o murtad).
È un progetto di fitna, di separazione e zizzania nella grande ummah
islamica. Per l’Is il mondo non si riduce più a «musulmani» e «non credenti»
(cristiani, ebrei, buddisti, atei, ecc.), ma a «credenti veri» (loro) e «miscredenti»
(tutti gli altri, musulmani compresi).
Questo progetto di divisione è
portato avanti anche dal neocolonialismo statunitense: il «nuovo ordine
mondiale», rilanciato dall’amministrazione Obama che propone la divisione in
piccoli stati a base etnico-religiosa di gran parte del Medio Oriente8. È un’evoluzione successiva,
sempre in ambito coloniale, dei vecchi accordi anglo-francesi di Sykes-Picot
per la spartizione del mondo arabo e islamico (19 maggio 1916).
Da Camp Bucca alla
moschea di Mosul: la carriera del califfo al-Baghdadi
Dell’autoproclamato «Califfo dello
Stato islamico di Iraq e Siria», ovvero di Abu Bakr al-Baghdadi al-usayni
al-Qurashi, nato a Samarra, Iraq, nel 1971, si sa poco. Sembra esistano
pochissime foto (una fu scattata quando era prigioniero degli Stati Uniti nel
campo iracheno di Bucca), e la sua apparizione pubblica nota è quella che lo
ritrae in un video9 durante un sermone nella grande
moschea di Mosul, andato in onda in streaming, dove lancia l’appello
alla guerra contro gli infedeli.
Ha fama di essere un violento e
tiene un «basso profilo», che accresce il mistero attorno a lui. Viene
descritto come il nuovo Osama bin Laden. Di lui si legge in vari documenti su
internet: «Secondo le registrazioni del dipartimento statunitense della difesa,
Abu Bakr al-Baghdadi è stato detenuto nel Camp Bucca come “inteato civile”
dalle forze iracheno-statunitensi dai primi del febbraio 2004 fino al 2009,
quando fu rimesso in libertà grazie all’indicazione di una commissione,
definita Combined Review and Release Board, che ne raccomandò il “rilascio
incondizionato”. (…)
Il 16 maggio 2010, ad appena un
anno dal rilascio, un comunicato del Consiglio consultivo dello Stato islamico
dell’Iraq annuncia la nomina a leader di al-Baghdadi al posto di Abu Omar
al-Baghdadi, ucciso il 18 aprile di quello stesso anno in un’operazione
congiunta delle forze irachene e statunitensi. Dall’ottobre 2011 figura tra i
tre terroristi maggiormente ricercati dal governo statunitense, che ha offerto
per la sua cattura una taglia di 10 milioni di dollari, inferiore solo alla
taglia posta su Ayman al-Zawahiri, di 25 milioni di dollari».
È lecito, dunque, porsi
interrogativi su questo individuo e sulla sua organizzazione. Esistono foto che
lo ritraggono insieme a John McCain, senatore Usa, e a altri leader dei ribelli
dell’opposizione siriana (tra cui noti personaggi di al-Qaida), in una riunione
definita «segreta», nel 2013.
Secondo un’altra teoria, che
circola dal luglio del 2014, e che viene fatta risalire a rivelazioni di Edward
Snowden, al-Baghdadi sarebbe un agente del Mossad, il cui vero nome sarebbe
Shimon Elliot10.
Tra tutte queste informazioni
contraddittorie, l’unico dato certo è che è riuscito a catalizzare il consenso
di migliaia (milioni?) di sunniti tra Iraq, Siria, mondo arabo-islamico e
Occidente, e che le sue bande ammazzano con una crudeltà assoluta.
Il califfato nella
tradizione islamica
Il ruolo arrogatosi da al-Baghdadi,
che nel già citato video del sermone alla grande moschea di Mosul appare
vestito di nero e con il turbante, a indicare il legame con la tradizione del
califfato, rappresenta un’importante istituzione nella storia della civiltà
islamica. Secondo la tradizione, nella figura del califfo (khalîfa, «vicario»)
convergono le funzioni di comando/conduzione dello «stato» (imâra) e
quella religiosa «sacerdotale» (imâma). «Stato» e «Chiesa», «secolare» e
«religioso», in arabo: dunya wa din. Per espletare tale compito egli
deve possedere caratteristiche specifiche.
Nel trattato «al-Ahkâm al-sultâniyya»
(Le leggi del governo/governance islamico)11, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn
Habib al-Basri al-Mawardi, noto giurista musulmano vissuto nell’anno Mille, in
Iraq, traccia un elenco di doti necessarie al califfo, tra cui: 1) giustizia;
2) sapere e conoscenza dell’arte di governare; 3) sanità di corpo e mente; 4)
capacità di governare e agire per il bene collettivo (e non per i propri
interessi, della propria famiglia, clan o gruppo); 5) coraggio nel tutelare e
proteggere il proprio paese, e condurre l’eventuale jihad contro il nemico o
chi attenti all’incolumità del watan (territorio, paese) o della ummah
(comunità); 6) discendenza dai Banu Quraysh (il clan cui apparteneva il profeta
Muhammad).
Nonostante il suo successo presso
certi ambienti musulmani, al-Baghdadi non sembra proprio possedere alcuna di
queste caratteristiche, anzi, le sue azioni criminali contro i «deboli» e le
minoranze, da sempre protette nella tradizione islamica, lo collocherebbero
fuori dalla via ortodossa. E ricorderebbero più un dajjal (mentitore,
impostore) che un khalifa. È in questa ottica, forse, che oltre 126 tra
teologi, mufti e dottori in scienze
islamiche di tutto il mondo hanno scritto una lettera aperta a al-Baghdadi
accusando lui di essersi autoproclamato califfo, il suo movimento di pratiche
che «non hanno nulla a che vedere con l’Islam», e entrambi di «atroci crimini
di guerra e violazione dei principi fondamentali dell’Islam, di uso ignorante
delle scritture islamiche separate dal loro contesto, di perversione delle
regole morali e della shari’a (la legge islamica).

Le colpe dell’Occidente: ieri finanziati, oggi terroristi
Nonostante l’Islam predicato da
questi gruppi violenti e intolleranti si ponga al di fuori della tradizione
ortodossa islamica, al-Baghdadi, attrae migliaia di persone in tutto in mondo.
Dalla stessa Europa in questi anni sono partiti centinaia di ragazzi musulmani,
tra immigrati e convertiti, per fare il «jihad» contro la Libia di Gheddafi e
poi contro la Siria di Assad.
Non è stato difficile, fino ad ora,
trovare su internet e nei social network commenti e post di giovani e adulti
che sostenevano le operazioni belliche contro questi paesi, e che, incoraggiati
da predicatori via Tv e web, si dicevano pronti a partire per la «guerra santa»
contro il nemico di tuo.
Fino all’inizio del 2014, non c’era
quasi nessun quotidiano o Tg che fosse disposto a fare reportage sulle stragi
delle organizzazioni jihadiste anti-Assad, in Siria, in quanto ai tempi esse
lavoravano in collaborazione con la coalizione occidentale e araba.
È solo recentemente, con
l’occupazione da parte delle truppe di al-Baghdadi di vaste porzione dei
territori siriani e iracheni, che l’ex alleato è diventato il «nemico n. 1»
dell’Occidente e dell’umanità intera.
Come scrive Ghassan Michel Rubeiz
in The Arab daily news12, «la radice-causa del sistema di terrore in Medio
Oriente è difficile da sradicare. La causa è alimentata dalle rivalità tra
sunniti e sciiti, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle dinastie
dispotiche, dalle umiliazioni politiche e dalle interferenze straniere negli
affari locali. Il sistema di credenza dell’Is si basa su tre idee: l’Islam è la
soluzione; l’Occidente è responsabile per la maggior parte di ciò che va storto
in Medio Oriente; i governanti locali sono agenti cornoptati dall’Occidente».
In un video, l’ex segretario di
stato Usa Hillary Clinton afferma che al Qa’ida fu creata dalla Cia: «La gente
con cui combattiamo oggi l’abbiamo finanziata 20 anni fa»13.
Analogamente, alla domanda se non
fossero dispiaciuti di aver sostenuto il fondamentalismo islamico e i futuri terroristi con armamenti e
addestramento, Zbigniew Brzezinski ha risposto: «Cos’è stato più importante per
la storia del mondo? I Taliban o il collasso dell’impero sovietico? Alcuni
musulmani agitati o la liberazione dell’Europa centrale e la fine della guerra
fredda?»14.
Secondo l’economista e storico
canadese, Michel Chossudovsky15, ci sono prove della cornoptazione del fondamentalismo
islamico nel progetto di «nuovo ordine mondiale», rilanciato
dall’amministrazione Usa durante il discorso del Cairo, il 4 giugno del 200916.
Alla fine del 2010 cominciarono i
preparativi per far sì che la religione islamica diventasse uno strumento della
politica estera degli Stati Uniti, attraverso la manipolazione di partiti e
movimenti musulmani.
Per raggiungere tale obiettivo, nel
2011 fu ripresa l’alleanza statunitense con i gruppi deviati di militanti che
affermavano di lottare sotto la bandiera dell’Islam. L’alleanza si esplicitò
nella guerra contro Gheddafi in Libia e poi contro Assad in Siria17.
Dal 2001 in poi, gli Usa e i loro
alleati avevano condotto guerre limitate a qualche territorio islamico: Afghanistan,
Iraq, Somalia. Oggi siamo al conflitto globale e simultaneo contro diversi
stati.
Si tratta della terza fase dello
scontro di civiltà con il mondo islamico: la prima iniziò nella seconda metà
degli anni ‘90 del secolo scorso, con la creazione del progetto del nuovo
ordine mondiale-nuovo Medio Oriente, che passò attraverso la tragedia delle
Torri Gemelle, l’11 settembre del 2001, e le sopracitate guerre. Poi ci fu la
seconda fase, quella avviata con il discorso di Obama al Cairo, A New
Beginning (Un nuovo inizio)18, quando, con una retorica forbita e colta, affascinò e
sedusse il mondo islamico, in particolare quello legato alla Fratellanza
islamica, e diede il via alle Primavere arabe, rivolte popolari infiltrate e
pilotate dall’esterno.
La terza fase ha come sfondo il
collasso e la trasformazione delle Primavere in colpi di stato (Egitto),
tentativi di golpe e guerra civile (Siria), instabilità in Tunisia, guerra in
Yemen, repressioni governative in Bahrayn, Qatar e Arabia Saudita, la creazione
del Califfato Islamico di al-Baghdadi in
Iraq e Siria e la dichiarazione di guerra degli Usa al «terrorismo islamico»,
che vede impegnati diversi stati arabi, tra cui le petromonarchie del Golfo e
la Turchia.
Le mosse e gli
obiettivi
Enrico Galoppini, storico del mondo
arabo-islamico, scrive19: «La fase finale della guerra dell’Occidente contro
l’Islam è finalmente cominciata. Tanto più che quest’ultimo s’è dotato d’un “medievale”
e terrificante “Califfato”.
Da quando è stato proclamato un
improbabile califfato a cavallo della Siria orientale e dell’Iraq
centro-settentrionale, l’Islam è tornato prepotentemente nelle case degli
occidentali, sottoposti a dosi da cavallo di messaggi sensazionalistici e
allarmistici capaci di provocare sconcerto e preoccupazione persino tra gli
stessi musulmani. Ma prima di giungere a tanto, serviva la cosiddetta “Primavera
araba”, il cui obiettivo principale è stato l’eliminazione dei “regimi arabi
moderati” che almeno ufficialmente l’Occidente sosteneva da anni contro gli “estremisti”
(…).
Tutto però è cominciato con
l’azione terroristica in territorio americano attribuita alla fantomatica
al-Qaida. (…) A garantirci dall’orda famelica dell’Islam guerrigliero e
spietato sussistevano i “regimi arabi moderati”, i quali, dal 2011, dopo il
celebre discorso di Obama al Cairo (giugno 2009) nel quale, astutamente, “tendeva
la mano all’Islam”, sono stati rovesciati con le note tecniche di sovversione
dall’interno denominate “Primavera araba”, altrove note come “rivoluzioni
colorate”. Quando non bastava l’azione di prezzolati del posto, perlopiù tratti
dai ranghi del cosiddetto “Islam politico” preceduti da sinceri ma sprovveduti “liberali”
(oltre alla solita teppaglia che si trova sempre), l’Occidente interveniva col
classico apparato di cannoniere e bombardieri (si veda il caso libico).
Ad una prima fase islamofobica
dominata dalla figura di Osama bin Laden, del suo vice al-Zawahiri e degli
altri luogotenenti (tipo al-Zarqawi), con tutto il corredo di “attentati terroristici”
(Londra, Madrid ecc.) e teste mozzate cui facevano da contraltare le sparate da
cowboy di Bush, le tute arancioni di Guantanamo e le torture di Abu Ghraib, ha
fatto seguito la “fase della speranza”, col pubblico occidentale illuso sulle
magnifiche sorti e progressive alle quali avrebbero aspirato le masse arabe e
islamiche desideranti la “democrazia”. Una “democrazia islamica” sotto
l’insegna dei Fratelli musulmani e delle varie sigle ad essi riconducibili che
qua e là hanno preso il potere.
L’apice di questa seconda fase
nella quale anche i peggiori tagliagole diventavano araldi della libertà ha
coinciso con la prima parte della cosiddetta “rivolta siriana”, che – pur
inscrivendosi nella “Primavera araba” – ha posto in inevitabile risalto, data la
posizione strategica della Siria, la portata strategica di un’operazione mirata
al rovesciamento del regime di Damasco.
(…) Ad un certo punto, però, col
rovesciamento del presidente egiziano tratto dai ranghi della Fratellanza
musulmana, Muhammad Morsi, qualcosa nel dispositivo sovversivo innescato dagli
occidentali s’è inceppato. La “rivolta siriana” è entrata in crisi, così come
s’è incrinato il meccanismo sin lì tetragono della propaganda unilaterale
occidentalista, anche se, a dire il vero, le voci discordanti rispetto al mainstream
vertevano soprattutto sul “massacro dei cristiani” da parte dei fanatici
islamici delle formazioni “jihadiste”; il che prefigurava la piega da “Nuova
crociata” che finalmente s’è manifestata con l’emergere di quest’inedito “Califfato”.
Con la Libia consegnata alle bande
fondamentaliste ed enormi bacini petroliferi di Siria ed Iraq in mano ai
seguaci del “califfo”, il volto più terrificante dell’Islam può finalmente
entrare nelle case degli italiani e degli altri sudditi dell’Occidente.
Ed è questa la fase numero tre del
progetto che punta a destabilizzare definitivamente tutto il Mediterraneo ed il
Vicino Oriente, con la non troppo remota possibilità di vedersi coinvolti
militarmente in una guerra.
Da un punto di vista propagandistico,
il terrore islamofobico che questa nuova fase è in grado di suscitare negli
animi di persone ingenue, manipolate e conquistate ai “valori occidentali” è
senz’altro più elevato di quello della prima fase con Bin Laden e soci a “bucare
lo schermo”.
(…) Il temibile “Califfato”, coi
suoi alleati posizionati sulla costa libica, novelli saraceni, sta lì a
minacciarci col suo “Medio Evo”; pertanto, se si vuol salvare la “modeità”
con tutti i suoi “valori”, non è più possibile sottrarsi al richiamo alle armi
dell’Occidente a guida anglo-sionista.
Frotte di “migranti” tra i quali
potrebbero nascondersi dei “terroristi” vengono rovesciate sulle nostre
indifese coste, mentre tra i figli della cosiddetta “seconda generazione”
spopola il richiamo alla “guerra santa”. Da qualche parte, nel Levante, c’è un “Califfo”
che vagheggia di conquistare Roma, mentre “i cristiani” e le minoranze
subiscono massacri, e poco importa ai fini propagandistici se musulmani di
vedute diverse da quelle dell’Is sono sottoposti a medesimo trattamento. Questo
è quanto trasuda da giornali e tg, che in due minuti frullano tutto in un
cocktail terrificante al termine del quale il malcapitato ed impreparato
spettatore non potrà che augurarsi una selva di bombe atomiche sull’intero
Medioriente».
Le contromosse di
al-Qaida
È notizia del settembre 2014
l’apertura di una «filiale» di al-Qaida in India: «al-Qaida in the Indian
Subcontinent» (Aqis) da parte di Ayman al-Zawahiri.
In un lungo video postato in
internet, al-Zawahiri20, che è subentrato nella direzione del gruppo terrorista
dopo la morte di Osama bin Laden, nel 2011, ha lanciato un appello a tutti i
musulmani indiani a «unirsi alla carovana del jihad», ribadendo la lealtà al
mullah Omar, capo dei Talibani afghani, e attaccando l’Is di al-Baghdadi per
aver osato sfidare l’egemonia internazionale dell’organizzazione-madre,
al-Qaida.
Aqis dovrà farsi «portatrice
standard del messaggio globale di Bin Laden per unire il mondo islamico nella
guerra contro il nemico e liberare le terre occupate e stabilire il califfato»,
afferma al-Zawahiri nel video. Un altro, dunque, che vuole stabilire il
califfato islamico, e in competizione con l’Is.
Siamo di fronte a una nuova fase
del fondamentalismo islamico violento: la lotta intestina tra gruppi e fazioni
rivali, tra jihadisti salafi e jihadisti takfiri. I primi, legati alla rete di
al-Qaida, hanno come obiettivo bellico l’Occidente miscredente. I secondi
lottano (anche) contro gli stessi musulmani – sciiti, alawiti e sunniti – che
non condividono la loro linea di pensiero e azione.
L’organizzazione di al-Qaida e l’Is
di al-Baghdadi, quindi, sono in conflitto tra di loro sul piano della
spartizione delle aree di influenza.
È in particolare in Siria che tale
situazione si manifesta in modo drammatico: l’alleanza del terrore tra i vari
gruppi che si oppongono al regime Assad è saltata proprio sulla decisione di
al-Baghdadi di creare un «califfato islamico» arrogandosi potere e territori
per sé e il suo gruppo e attaccando tutte le altre formazioni.
La Fratellanza musulmana, che nel
2011 è stata promotrice, insieme ad altri movimenti e gruppi e a vari paesi
occidentali, della rivolta contro il regime di Damasco, è stata messa da parte
e quasi estromessa dalla lotta proprio dalle fazioni qaediste con cui si era
alleata, subendo violenze e persecuzioni.
L’esito sono le guerre in corso in
Libia, Siria e Iraq, e i bombardamenti decisi a settembre dal presidente Barack
Obama contro il «terrorismo islamico», in parallelo alla decisione paradossale
dell’amministrazione Usa di continuare a finanziare le formazioni islamiche «moderate»,
ma sempre legate al-Qaida, nella consueta logica apparente del divide et
impera o del «male minore».
La lotta di al-Qaida è bifronte:
contro l’Occidente miscredente e conquistatore e contro il figlio traditore,
l’Is che si sta accaparrando aree sempre più ampie di influenza (oltre a armi,
pozzi e rotte petrolifere) in Medio Oriente e Nordafrica, in un appeal
crescente tra le tribù arabe irachene, i giovani musulmani in Europa e in altri
continenti.
La sua presenza, dunque, in regioni
come India, Pakistan e Bangladesh, con mezzo miliardo di musulmani, potrebbe
garantirle di nuovo visibilità e potere. Insomma, la nuova formazione
terrorista, non promette nulla di buono, anzi, fa prevedere scenari di
destabilizzazione e caos ancora maggiori.
Un futuro di guerre e
terrorismo
A settembre del 2014, il segretario
di stato Usa, John Kerry, ha dichiarato: «Nella nostra campagna contro l’Is,
non ci lasceremo fermare dalla geografia e dai confini nazionali»21. Ridisegnare il Medio Oriente,
scavalcando il diritto internazionale, è uno degli obiettivi della nuova guerra
statunitense. Chiunque egli sia, il califfo al-Baghdadi, con le sue orde
brutali, è il rivale d’armi ideale per chi voglia destabilizzare il mondo e
accapparrarsi le fonti energetiche di Africa e Medio Oriente. Una nuova
stagione di conflitti si è aperta.•
Angela Lano
 Le Suore di Maria
Le Suore di Maria![]() «Il nostro fondatore è
«Il nostro fondatore è



 Nato a Caramagna Piemonte (Cn) l’8 febbraio 1873, nel 1902
Nato a Caramagna Piemonte (Cn) l’8 febbraio 1873, nel 1902 Ai confini dell’Europa (5): La Bulgaria
Ai confini dell’Europa (5): La Bulgaria 






 IV CONVEGNO MISSIONARIO NAZIONALE /1
IV CONVEGNO MISSIONARIO NAZIONALE /1





 USCIRE.
USCIRE. Immaginiamo quel vecchio gioco in cui un bambino comincia
Immaginiamo quel vecchio gioco in cui un bambino comincia Il rapporto tra centro e periferia non dipende più solo da fattori geografici.
Il rapporto tra centro e periferia non dipende più solo da fattori geografici. Le parole chiave del Convegno sono quindi questi verbi che
Le parole chiave del Convegno sono quindi questi verbi che I nostri verbi quindi devono essere declinati «con
I nostri verbi quindi devono essere declinati «con
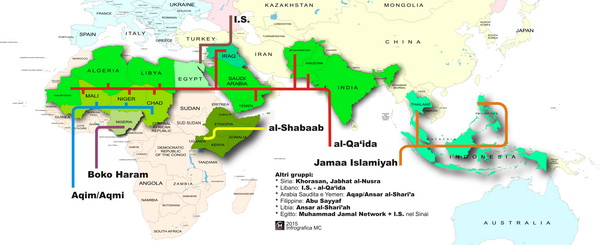
 Tuttavia, il patto in sé può non
Tuttavia, il patto in sé può non





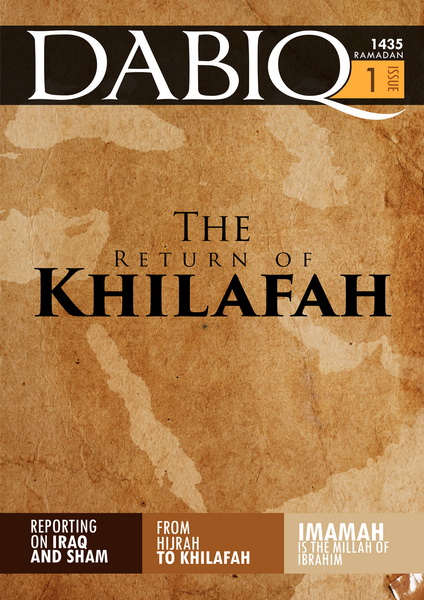



 Tosolini, che ha fatto la sintesi
Tosolini, che ha fatto la sintesi Gutiérrez ha ricordato (la citazione
Gutiérrez ha ricordato (la citazione.jpg)
 Ai confini dell’Europa (3):
Ai confini dell’Europa (3):
 Se Grozny sta rinascendo dal punto di vista architettonico,
Se Grozny sta rinascendo dal punto di vista architettonico,
 I missionari della Consolata sbarcano in un nuovo paese africano
I missionari della Consolata sbarcano in un nuovo paese africano

 Le realtà laicali del mondo missionario italiano
Le realtà laicali del mondo missionario italiano

 Nel mondo un’inflazione di conflittualità
Nel mondo un’inflazione di conflittualità Quanti conflitti si stanno consumando nel mondo? Non è
Quanti conflitti si stanno consumando nel mondo? Non è