Serve anche la pipì. Huaycán, il centro di medicina olistica «Anna Margottini»

Siamo stati a
Huaycán, una delle periferie di Lima, per visitare il «Centro medico Anna
Margottini» gestito dalla suora italiana Goretta Favero. Abbiamo scoperto un
modo diverso di curarsi, al di là dei dettami della medicina ufficiale e delle
imposizioni delle multinazionali farmaceutiche…
chilometri da Lima, sorge Huaycán, tipico esempio di pueblo joven,
espressione con cui in Perú si indica un centro urbano di recente costituzione.
In realtà, il termine è un eufemismo per indicare un insediamento cresciuto in
luoghi inospitali e senza servizi primari per mano di gente povera o poverissima,
di solito emigrata dall’interno del paese.
In 30 anni – la sua fondazione risale al 1984 – la città
di Huaycán è cresciuta e migliorata, ma rimane un luogo dove vivere è
difficile. Soprattutto se si abita una casa di esteras1 (o di altri materiali
poveri: lamiera ondulata, cartoni, teloni) costruita in alto, sulle aridissime
pendici della montagna. Eppure è in luoghi come questi che la speranza può
prendere forma e concretezza, anche in modi inusuali. Lo testimonia la «Casa naturista
peruano-italiana Anna Margottini», un centro di medicina nato e cresciuto sulle
sabbie desertiche della città2.

Nella parte bassa di Huaycán la concentrazione di
abitazioni – cresciute una a ridosso dell’altra – è altissima ma, grazie al suo
colore bianco, la Casa Margottini s’individua facilmente. È una struttura a tre
piani, modea e semplice ad un tempo. L’ingresso per il pubblico si trova
accanto all’omonimo negozio di prodotti naturali ed erboristici. Varcata la
soglia, ecco il banco dell’accettazione e, davanti a esso, una serie di sedute
per la gente in attesa. Sulla parete di fronte al bancone una targa ricorda il
giorno dell’inaugurazione ufficiale – era l’11 gennaio del 2008 -, avvenuta
alla presenza del presidente della Camera dei deputati italiana e
dell’ambasciatore in Perú.
L’ambiente è accogliente e rilassante, pur
nell’andirivieni delle persone. Pannelli e poster colorati raccontano a
pazienti e visitatori filosofia e pratica della Casa Margottini: le consulenze
mediche e le terapie (dall’agopuntura all’odontologia) sono fatte nell’ottica
dei saperi naturali e della metodologia olistica3. Visite e terapie sono
a pagamento ma i prezzi sono bassi o comunque accessibili.
Nel Centro di Huaycán la medicina vuole essere naturale,
alternativa, semplice, ma anche popolare, economica e solidale ovvero l’esatto
contrario di quella che conosciamo. Siamo curiosi di scoprirla.
Curarsi (rompendo schemi, preconcetti e
tabù)
Ci viene incontro una donna tutta verve ed entusiasmo.
Sorride con la bocca ma soprattutto con gli occhi. Lei si chiama suor Goretta
Favero Miotti, padovana, infermiera, cofondatrice e attuale responsabile della
Casa Margottini.
Il percorso peruviano di suor Goretta inizia nel 1980.
Dieci anni dopo è a Huaycán. «Dal 1991 abbiamo lavorato a San Andres4, la parrocchia di Huaycán,
per formare promotrici di salute con le quali rispondere alle esigenze di
attenzione medica primaria. Con attenzione particolare per la prevenzione di
diarree, bronchiti, disidratazione, le patologie più diffuse». Suor Goretta e
le promotrici davano aiuto, ma allo stesso tempo ricevevano, scoprendo ad
esempio la medicina ancestrale della gente che veniva dalle Ande. «Abbiamo
recuperato e riscattato la fitoterapia, le cure con l’argilla e con l’urina».
Forse non abbiamo sentito bene. «Con l’urina?», chiediamo, facendo finta di non
essere troppo sorpresi. «Sì – spiega la suora -, bere la propria urina è una
chiave per rivoluzionare la nostra salute e la nostra vita. È una terapia
applicabile a tutte le età e per quasi tutte le malattie. È economica e
inesauribile»5.
Premesso che la medicina «ufficiale» è geneticamente
scettica (perlomeno) rispetto a qualsiasi strada alternativa, secondo la
medicina olistica le malattie vanno affrontate guardando all’uomo nella sua
globalità. Dunque, non soltanto nei suoi aspetti fisici. «Siamo convinti che
dietro ogni malattia, anche grave come un tumore, ci sia sempre un problema
emozionale e spirituale su cui occorre lavorare».
Diversa la ricerca delle cause, diversa la ricerca delle
soluzioni. «Tutti noi dentro il nostro organismo abbiamo le risorse per
curarci, per autosanarci. Basta dare al corpo un aiuto». Chiediamo in cosa
dovrebbe consistere questo aiuto. «Ad esempio, cambiando gli stili di vita,
seguendo un’alimentazione più organica e naturale, eliminando tutti gli
alimenti sofisticati e trattati (come lo zucchero, il pane bianco, il riso
bianco), facendo più movimento, adeguando la respirazione, aprendosi a
relazioni nuove, avendo più rispetto per i propri bioritmi».
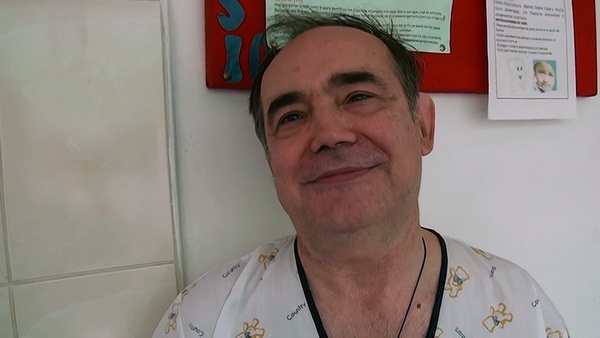

È sempre
una questione di fegato
La struttura di Casa Margottini è divisa in tre aree
distinte. Nella prima ci sono la reception e gli ambulatori medici; nella
seconda, collegata da un elegante patio fiorito, ci sono gli ambienti per i
corsi e per i ritiri disintossicanti; nella terza, infine, c’è il laboratorio
erboristico.
Guidati da suor Goretta, sbirciamo nell’ambulatorio di
agopuntura dove quasi tutti i lettini sono occupati da pazienti in terapia.
Bussiamo quindi all’ambulatorio della dottoressa Yolanda Anco Torres, che è
anche direttore medico del centro. Pur essendo occupata con una donna e i suoi
due bambini piccoli, ci invita a entrare. Lei lavora qui da 4 anni ed è
convinta che la medicina naturale sia la migliore. «Mi sono convinta vedendo i
risultati ottenuti con i pazienti», ci dice.
Saliamo al piano superiore dove c’è l’ambulatorio di
odontologia. Ferruccio Fasanelli, di Conegliano Veneto (Treviso),
dentista italiano di 62 anni, si è trasferito a Huaycán con la moglie
peruviana. Due figli minori qui e ben sei in Italia. Il dottor Fasanelli segue
una odontologia olistica, escludendo l’uso di prodotti potenzialmente dannosi
per l’organismo. È molto felice della scelta di vita e professionale che ha
fatto. «La Casa è molto attenta agli aspetti umani, fa un ottimo lavoro medico
e la gente mi pare contenta. E poi si cerca di portare la salute dove ci sono
gli ultimi».
Lasciamo il dottor Fasanelli ai suoi pazienti
e proseguiamo lungo il corridoio del secondo piano. Ecco l’ambulatorio degli
psicologi. «Dietro a una malattia c’è spesso depressione, paura, collera. È
essenziale – ci spiega suor Goretta – sostenere la gente dal punto di vista
emozionale. Non soltanto il malato ma anche la sua famiglia».
Vicino c’è l’ambulatorio della massoterapia
dove Ines sta trattando un paziente. Accanto c’è la sala per la riflessologia
plantare, tecnica olistica tra le più note. Infine, l’ambulatorio della
idrocolonterapia, nella quale suor Goretta ripone molta fiducia. «Si fa con
acqua e ozono. Per noi è fondamentale perché con essa si previene e si cura.
Quando si fa una pulizia accurata del colon, l’organismo ha più difese»,
spiega. Corridoi, sale d’attesa, ambulatori: tutto è ordinato e lindo come si
conviene a una struttura sanitaria. Ma l’aria che si respira è rilassata «per
favorire – racconta la religiosa – un’attitudine mentale positiva».
In un’altra ala dell’edificio, accanto alla
cappella e alla ariosa sala dei corsi (biodanza, reiki), ci sono le stanze per
gli ospiti. La struttura può accogliere fino a 60 persone. «Non c’è una vera e
propria degenza. Facciamo inteamenti soltanto per i ritiri depurativi,
digiuni e massaggi, e soprattutto per motivi di prevenzione. La
disintossicazione del fegato e delle vie biliari è un trattamento a cui
attribuiamo molta importanza. Abbiamo infatti notato che la maggioranza delle
malattie viene a causa di un fegato sporco. Così, dopo un mese di preparazione,
alle persone in cura chiediamo di intearsi per tre giorni».

Terminato il tour conoscitivo della Casa
Margottini, lasciata momentaneamente suor Goretta ai suoi impegni lavorativi,
andiamo al piano dove si trova il ristorante naturista «Sapori della vita».
Nome italiano come italiana è la volontaria che lavora con le cuoche peruviane.
Il menù è (ovviamente) coerente con la filosofia del luogo, perché
un’alimentazione sana è essa stessa una medicina. Mangiamo una minestra di quinua6, un
tortello di zucchini e, come bevanda, un bicchiere di chicha morada7.
Dopo il pranzo, messi da parte lo
scetticismo, il recondito senso di superiorità (o forse la banale spocchia
occidentale) e una certa sudditanza al determinismo scientifico, siamo pronti
per sottoporci alla visita medica. Ci accoglie la dottoressa Heliana Febres.
Usciamo dopo oltre un’ora di colloquio con in
mano il nostro «Manuale pratico di orientamento per una vita sana». Per
iniziare il nostro nuovo corso, come a tutti, ci è stata suggerita una fase di
disintossicazione: 15 giorni di dieta rigorosa (soltanto verdure crude e
frutta), una serie di piante medicinali e anche la prescrizione più temuta
(…).

Toa suor Goretta per mostrarci l’ultima
parte del progetto. Lei e i suoi collaboratori non si limitano infatti a offrire
un servizio di cure mediche. In coerenza con una visione dell’uomo nella sua
globalità, davanti al centro Margottini funziona anche una struttura
assistenziale di stampo (apparentemente) più convenzionale: la Casa hogar Niños
esperanza de Huaycán. L’edificio ospita una casa famiglia (casa hogar)
con una decina di bambine, un piccolo istituto educativo per il doposcuola, una
mensa per bambini ma anche un’aula dove si insegna agli adulti a produrre
saponi naturali e una grande cucina dove alcune donne (comprese mamme con
bambini al seguito) sfoano pane e torte. «Con soia e farine integrali», ci
spiega suor Goretta.
Prima di lasciare Casa Margottini ci fermiamo
nella bottega dei prodotti naturali, in gran parte usciti dal laboratorio
interno. Le erbe sono contenute in sacchettini di carta con un’etichetta bianca
che ne descrive il contenuto; i prodotti liquidi sono in piccole boccette
scure. Yolanda, la signora addetta alla vendita, ci prende dagli scaffali
quanto richiesto. Quando ci saluta, suor Goretta ci ricorda che «la prima cosa,
la più importante, è decidere di cambiare». Poi il cammino da seguire sarà
identico in Perú come in Italia o in qualsiasi altro paese del mondo.
2 – Occorre ricordare che, dopo Il Cairo, Lima è la seconda città
più grande del mondo nata e cresciuta su un deserto.
3 – Dal greco όλος = totalità. Un sistema – e dunque anche
un corpo umano – non va mai visto come una semplice sommatoria delle parti che
lo compongono.
5 – Dopo la visita al Centro Anna Margottini, abbiamo scoperto che
esistono molti libri dedicati all’urinoterapia.
6 – Coltivata sulle Ande da tempi antichissimi, la quinua è uno pseudocereale ad
alto valore nutritivo. Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2013 anno
internazionale della quinua.
7 – La chica morada è una tipica bevanda peruviana risalente all’epoca inca. È fatta
con una varietà di mais di colore viola scuro.
Nella
prossima puntata:
racconteremo di Tablada del Lurín,
un’altra periferia di Lima metropolitana; a Tablada abbiamo visitato il centro
medico «Jampi Wasi».
suor Goretta Favero ci guida all’interno del «Centro
medico Anna Margottini» di Huaycán.
Luogo: Huaycán, distretto di Ate (Lima
est).
Nome completo: «Casa naturista peruano-italiana
Anna Margottini».
Inizio attività: gennaio 2008.
Responsabile: suor Goretta Favero Miotti.
Responsabile medico: dott.ssa Yolanda Anco Torres.
Servizi principali: medicina naturale, psicologia,
odontologia, ecografia, agopuntura, idrocolonterapia, terapie energetiche e
massaggi, neuralterapia, bagni di ipertermia alle erbe, zapper, biodanza, soggiorni
per disintossicazione epatobiliare.
Altri servizi: laboratorio e bottega di prodotti
fitoterapici, ristorante naturista.
Personale e
collaboratori: Yolanda Anco,
Heliana Febres, Ferruccio Fasanelli, Carolina Morillo (medici); Violeta
Carranza, Maggie Palacios, Carola (psicologhe); Carlos Luyando (agopunturista);
Ines (massoterapista); addetti al laboratorio erboristico; personale
amministrativo e di pulizia; volontari provenienti dall’Italia.
(*) Il sito fornisce un’idea del
Centro Margottini, ma – all’ottobre 2013 – non risulta adeguatamente
aggiornato.


Vivere in salute e curarsi in Perù
Come in troppi paesi del mondo, anche in Perù la salute è un
diritto più teorico che effettivo. Da anni il paese registra una elevata
crescita economica e un livello di povertà in diminuzione. Tuttavia, ai dati
macroeconomici positivi non sempre corrisponde un identico miglioramento della
sanità. In Perù, come altrove, per vivere in salute e curarsi disporre di
denaro rimane un prerequisito essenziale.
Lima. La
lunghissima Avenida Arequipa collega il centro con San Isidro e Miraflores, due
tra i quartieri più esclusivi della capitale peruviana. La via, sempre
trafficatissima e inquinata, è un susseguirsi di scuole e istituti educativi
privati, che cercano di accaparrarsi i clienti-studenti con giganteschi e
coloratissimi cartelloni pubblicitari. A San Isidro e Miraflores le scuole
private lasciano il posto alle cliniche private, dove i clienti-pazienti
vengono attratti anche aggiungendo al nome una provenienza extranazionale
(clinica svizzera, angloamericana, italiana e via così), come se l’aggettivo in
questione fosse garanzia di maggiore serietà.
Per curarsi, il cittadino di Miraflores
o San Isidro ha dunque un ampio ventaglio di scelte. Ma siamo in quartieri
ricchi. Usciti da questi ambiti territoriali, la situazione è diversa.
A parte i militari e le forze di
polizia (che hanno strutture sanitarie proprie), ogni cittadino peruviano può
farsi curare in strutture pubbliche. Ci sono gli ospedali del ministero della
salute (Minsa) e quelli di EsSalud. Negli ospedali del Minsa
tutto è a pagamento e la qualità del servizio è molto variabile. Agli ospedali
di EsSalud possono accedere soltanto i cittadini che hanno un regolare
contratto lavorativo (e dunque pagano i contributi) o che si sono affiliati su
base volontaria (da 64 soles al mese). Gli unici utenti esentati dal
pagamento sono quelli che rientrano nel «Seguro integral de salud» (Sis)1,
servizio creato dallo stato per la popolazione più povera (e aperto agli altri
tramite affiliazione volontaria: circa 15 soles al mese). Per gli
affiliati al Sis la qualità delle cure è sovente molto scarsa e non vengono
coperte tutte le patologie.
In questo quadro variegato, dal
2004 a Lima è entrato in funzione il «Sistema metropolitano de la
solidaridad» (Sisol). Negli Ospedali della solidarietà – sono 20 nella
capitale e pochi altri nel resto del paese – gli utenti hanno un buon servizio
a un costo abbordabile. Ma comunque, anche in questo caso, visite mediche,
esami e medicine si pagano.
Da anni il Perù è in crescita economica. Anche la povertà,
pur rimanendo alta (27,8%), si è ridotta notevolmente (vedi riquadro).
Tuttavia, nonostante questi dati positivi, il sistema sanitario peruviano non è
cresciuto in maniera equivalente. In generale, fuori dalle città e nelle
regioni di montagna (sierra) e di foresta (selva) curarsi è
complicato e a volte impossibile.
«La diseguaglianza, la esclusione e
la povertà – scriveva la rivista peruviana Otra Mirada in un’ottima
monografia del 20092 – sono fattori che rendono le persone più vulnerabili
ai problemi di salute e, a loro volta, diventano barriere all’accesso a servizi
sanitari adeguati. (…) Il diritto alla salute, identicamente al diritto
all’istruzione e altri diritti sociali, non è stato attivamente protetto dallo
stato negli ultimi decenni».
In Perù il diritto alla salute è riconosciuto (senza
enfasi) dalla Costituzione del 1993, una carta di netta impronta neoliberista.
Se è vero che la protezione della salute è un diritto riconosciuto a tutti
(art.7), è altrettanto vero che lo stato si limita a garantire il libero
accesso alle prestazioni attraverso entità pubbliche, private e miste (art.11).
Il risultato è che troppo spesso il diritto alla salute rimane teorico per la
maggioranza della popolazione. Difficile dunque negare l’esistenza
dell’equazione «più denaro, più salute». Un’equazione valida – magari in gradi
diversi – in moltissimi paesi, soprattutto in quelli dove lo stato sociale non è
mai arrivato o è stato schiacciato dall’avvento del modello neoliberista.
1 – Per maggiori informazioni,
di seguito riportiamo i siti delle varie organizzazioni: www.minsa.gob.pe; www.essalud.gob.pe;
www.sis.gob.pe; www.sisol.gob.pe.
2 – Otra Mirada, La democracia no goza de buena salud, novembre 2009: www.otramirada.pe.
•
Tasso di crescita annuale (stima 2013): 5,9%.
•
Tasso di povertà (2011): 27,8% (era 48,7 nel 2005).
•
Spesa sanitaria (pubblica+privata) (2010): 5,08% del Pil (media dei paesi latinoamericani: 7%; in
Italia, sempre nel 2010: 9,2%, di cui 7,3% pubblica).
•
Spesa sanitaria annuale procapite:circa 400 dollari (suddivisi a metà tra pubblici e privati).
•
Mortalità infantile (ogni 1.000 nati vivi, 2010): 17,0 (era 75 nel 1990;
in Italia, nel 2010: 3,3).
•
Mortalità matea (ogni 100.000 nati vivi, 2011): 92,7 (in Italia: 3
ogni 100.000 nati vivi).
• Denutrizione cronica infantile (2012): 19,5%
(era 30% nel 2000).
• Principali cause di mortalità prima dei 5
anni di vita (2013): infezioni vie respiratorie (40,5%), infezioni intestinali
(7,7%), denutrizione (5,2%).
• Principale causa di morte da agente
infettivo dopo l’Aids: tubercolosi, 96 casi ogni 100.000 abitanti nel 2013
(erano 198 nel 1990; in Italia: 10 ogni 100.000).
Fonti: Banco mondial, Organización Panamericana de la Salud, Minsa,
Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), Oms, Istat (Italia).
Paolo Moiola





.jpg) Fatuma è
Fatuma è.jpg)

.jpg)
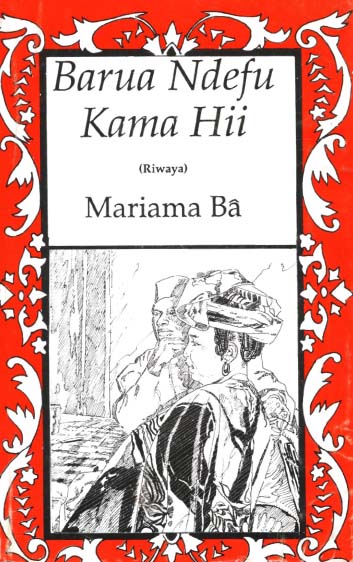 «Mamma – dichiara Aisatu -, Iba verrà a
«Mamma – dichiara Aisatu -, Iba verrà a Anni Sessanta.
Anni Sessanta.














 Sono tre. Un italiano, veterano del Mozambico, un colombiano
Sono tre. Un italiano, veterano del Mozambico, un colombiano
















 Paese di emigrati, l’Australia ha adottato una politica
Paese di emigrati, l’Australia ha adottato una politica














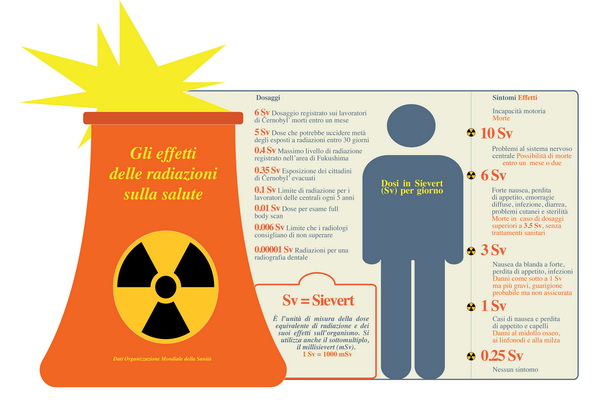
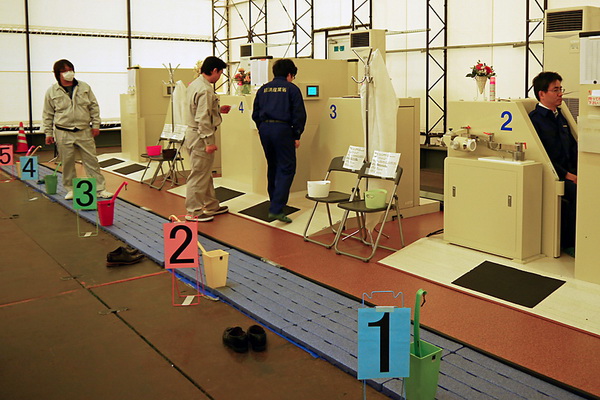



 Ma forse, e più coraggioso di tutti, è stato
Ma forse, e più coraggioso di tutti, è stato.JPG)

.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
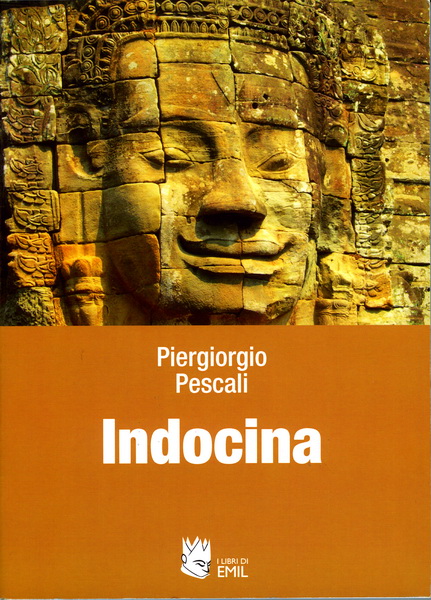 • Piergiorgio Pescali – Gioalista e scrittore, si occupa di Estremo Oriente, in particolare di Sud Est Asiatico, penisola coreana e Giappone. Suoi articoli e foto sono stati pubblicati da Bbc, Cnn, Avvenire, Il Manifesto, Panorama e riviste specializzate. Dal 2010, cura per Asia Maior (www.asiamaior.org) il capitolo sul Myanmar. Ha scritto il saggio Indocina, Edizioni Emil, Bologna 2010.
• Piergiorgio Pescali – Gioalista e scrittore, si occupa di Estremo Oriente, in particolare di Sud Est Asiatico, penisola coreana e Giappone. Suoi articoli e foto sono stati pubblicati da Bbc, Cnn, Avvenire, Il Manifesto, Panorama e riviste specializzate. Dal 2010, cura per Asia Maior (www.asiamaior.org) il capitolo sul Myanmar. Ha scritto il saggio Indocina, Edizioni Emil, Bologna 2010.