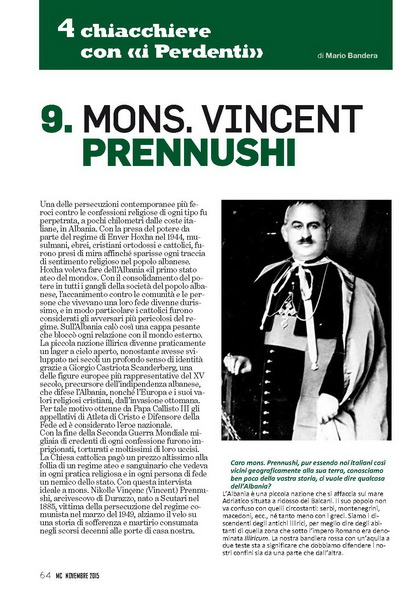Storia del Giubileo 1. Francesco, papa profeta

Con la Bolla «Misericordiae Vultus»
(MV) dell’11 aprile 2015, Papa Francesco ha indetto un Giubileo Straordinario dedicato alla Misericordia. Il
Giubileo durerà un anno, dall’8 dicembre 2015, cinquantesimo anniversario della
chiusura del concilio Vaticano II, al 20 novembre 2016, memoria liturgica della
festa di «Cristo Re dell’universo». Il Papa ha esteso a tutte le chiese
cattedrali diocesane e a quelle più significative di tutto il mondo le stesse
prerogative delle Basiliche vaticane di Roma, per cui – e questo è anche il
desiderio di Papa Francesco – non sarà necessario andare a Roma, come per tutti
gli altri Giubilei, ma si potrà partecipare intimamente anche dalle proprie
città e diocesi.
Questa
scelta è importante perché il Papa, in questo modo, afferma «l’ekklesìa»
universale che si realizza ovunque si celebri la Misericordia di Dio che lo
stesso Francesco nella Bolla di indizione definisce «l’architrave che sorregge
la vita della Chiesa» (MV, n. 10), la quale «vive un desiderio inesauribile di
offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del
Padre e la sua forza diffusiva».
La
rivista MC ha deciso di predisporre dieci puntate (una al mese e quindi per
l’intero anno giubilare) per approfondire il significato del Giubileo nella
Bibbia, quali sono i suoi contenuti, e quale ne è stato lo sviluppo nella
storia della Chiesa, che vide il primo Giubileo nel 1300, indetto da Papa
Bonifacio VIII con intenzioni ben diverse da quelle di Papa Francesco.
Cercheremo di capire meglio – almeno lo speriamo – le ragioni e le motivazioni
interiori che hanno spinto il Papa a fare questo gesto e con modalità diverse
da quelle degli altri Giubilei. Sono grato a MC di avermi affidato questo
compito che, pur essendo impegnativo, mi permette di compiere un atto di
devozione e di ossequio ai nostri lettori, verso i quali MC non può che nutrire
sentimenti di gratitudine.
Non
possiamo però cominciare il racconto della storia del Giubileo senza domandarci
chi sia Papa Francesco. Se è vero, come lui stesso ha detto la sera della sua
elezione a vescovo di Roma (13 marzo 2013), che i «cardinali sono andati a
prenderlo quasi alla fine del mondo», è anche vero che fin dall’inizio egli ha
compiuto gesti e ha detto parole incisive per le persone, per lo stesso papato
e anche per chi non crede. Questo Papa non lascia indifferenti.
Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabella normale";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
}

Una profezia scontata
Devo iniziare con un riferimento personale. Me ne scuso, ma è
necessario. Nel 1999, quando vivevo a Gerusalemme, pubblicai un romanzo dal
titolo «Habemus Papam, Francesco». Alla vigilia del Giubileo che segnava il
passaggio tra il II e il III Millennio, immaginavo l’arrivo di un papa che
prendesse il nome «Francesco» e cominciasse a riformare sul serio la Chiesa che
già allora, nel declino del pontificato di Giovanni Paolo II, viveva i sintomi
di un sistema ecclesiastico che iniziava a precipitare.
Nel 2012, a richiesta dei lettori, il romanzo fu ripubblicato
dall’Editore Gabrielli con il titolo «Habemus Papam. La leggenda del Papa che
abolì il Vaticano». Questa seconda edizione fu aggiornata al pontificato di Papa
Ratzinger, durante il quale il Vaticano fu teatro di fatti scandalosi e di
corruzione, così gravi da portare lo stesso Papa a rassegnare le dimissioni, le
prime dopo quelle del 1294 di Celestino V, il Papa che con l’istituzione della «Perdonanza»
di Collemaggio (L’Aquila), anticipò di quattro anni il primo Giubileo della
Chiesa Cattolica, proclamato per l’Anno Santo del 1300 dal suo successore, Papa
Bonifacio VIII della famiglia «Cajetani».
L’idea di un papa che prendesse il nome Francesco, anticipata di
tredici anni e poi ribadita l’anno precedente la sua realizzazione, non fu una
preveggenza perché il cristiano non ha bisogno di arti magiche per leggere il
futuro, gli è sufficiente avere gli strumenti adatti alla lettura dei «segni
dei tempi» (Mt 16,2-3; cf Lc 12,54-56; Vangelo [apocrifo] di Tommaso,
n. 91) che sono il Vangelo e la Storia, accostati senza prevenzioni. Usare
questi strumenti è il modo «ordinario» per conoscere il senso e la profondità
di ciò che accade e anche di quello che verrà.
Oggi, ascoltando il papa, spesso gli sento pronunciare le stesse
parole del Papa del romanzo o vedo che compie gesti simili al Francesco
letterario, e non mi meraviglio perché il Papa crede che lo Spirito Santo guidi
la storia e le ragioni profonde dell’agire. Non ha quindi idee o interessi o
privilegi da difendere. Con il cuore libero sa disceere le esigenze del Regno
di Dio, distinte dagli schemi dei propri convincimenti. Papa Francesco è
isolato all’interno del «sistema clericale» e alcuni non lo nascondono nemmeno:
sono gli stessi che prima difendevano il «primato del Papa», ma solo perché il
pensiero del Papa di tuo coincideva con il loro. È sufficiente che un Papa
pensi secondo Dio con spirito di servizio, combattendo la perversione del
potere e lo spirito di casta, che di solito degenera nella corruttela, ed ecco
montare un muro di resistenza strisciante.
Papa Francesco ha il senso di Dio perché è affamato di umanità e
sa di rappresentare sulla terra quel Cristo, che è «Lògos [che] carne fu fatto»
(Gv 1,18). Si presenta all’umanità non come maestro di princìpi e dispensatore
di dottrina, difensore di tradizioni passate e fustigatore di costumi, ma
semplicemente come il servo del Dio incarnato che viene a misurarsi con il
passo delle persone alle quali prospetta e offre un orizzonte che solo nella
libertà e nell’amore è possibile.
Si può dire che Papa Francesco esprima l’anelito e l’ansia
pascaliani di non preoccuparsi del Dio della filosofia e delle dimostrazioni
apologetiche, ma unicamente del Dio incontrato e sperimentato nella sua storia
e in quella dei suoi compagni e compagne di viaggio: «Fuoco. Dio di Abramo, Dio
di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei dotti … Dio di Gesù Cristo»
(B. Pascal, Memoriale; cf anche Pensieri, 5, 362, 366, 556; 602,
730).
cucito nella fodera di un suo indumento, un foglio autografo in cui filosofo e
scienziato faceva riferimento a un’esperienza, forse mistica, avvenuta nella
notte del 23 novembre 1654. Il breve documento è conosciuto come «Memoriale» e
riporta la celebre frase: «Fuoco. Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di
Giacobbe, non dei filosofi e dei dotti … Dio di Gesù Cristo».
Da sommo pontefice a «servo
dei servi»
Per capire Papa Francesco e la scelta d’indire un Giubileo
Straordinario sulla Misericordia, bisogna ritornare a quella sera straordinaria
del 13 marzo 2013, quando dopo la fumata bianca e l’annuncio del cardinale
protodiacono: «Habemus Papam … Franciscum», il primo latinoamericano della
storia e il primo gesuita papa, si è affacciato alla loggia delle benedizioni.
Da subito gli addetti del mestiere hanno capito che molto era cambiato, già
solo al vederlo vestito di bianco e senza la mozzetta scarlatta e la stola
cosiddetta di «Pietro e Paolo». Accanto al Papa, alla sua sinistra, stava
terreo e sudato il cerimoniere pontificio che sul braccio teneva piegata la
stola pontificia. È
stata una scena indimenticabile perché ha segnato il confine irreversibile tra un
«prima» e un «poi» (cf V. Gigante – L. Kocci, La Chiesa di tutti,
prefazione di Paolo Farinella, Altraeconomia, Milano 2013). Per la prima volta
nella storia, un Papa appena eletto non si presentato come «pontefice», ma come
Vescovo di Roma e ha voluto mostrarlo in modo visibile perché nella Chiesa i
simboli sono essenziali. Egli ha rinunciato alla «mozzetta rossa, oata di
ermellino», residuo della clamide rossa indossata l’imperatore come simbolo
della sua autorità di massimo magistrato dello stato. Rinunciando all’indumento
imperiale, il Papa rinunciava a presentarsi come «Sommo Pontefice», titolo
riservato all’imperatore e simbolo del potere temporale. Non indossando la
stola che di solito i Papi portano quando esercitano la loro funzione di capi
di stato, il Papa si è offerto al suo popolo «nudo» come Francesco di Assisi e
ha trasformato in un colpo solo il potere in servizio.
L’ultimo gesto sconvolgente è stata la richiesta al popolo
romano, cioè il «suo» popolo ecclesiale, d’invocare la benedizione di Dio su di
lui vescovo, prima che questi benedicesse il popolo, dando corpo alle parole di
sant’Agostino che nell’anniversario della sua ordinazione diceva ai cristiani
di Ippona: «Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano» (Sermones,
340, 1 PL 38, 1483). La sera del 13 marzo 2013 dalla loggia centrale del
Vaticano non si è presentato il rappresentante del potere temporale, anche se
stilizzato, il Papa-Re, anche se di un minuscolo Stato di 0,44 km2, ma «il servo
dei servi di Dio». Non si è presentato soltanto. Ne ha anche avuto coscienza.
Gregorio I (1145-1241) in risposta al Patriarca di Costantinopoli Giovanni IV Nesteutés,
che significa Digiunatore (582-595), che nel 587 aveva assunto il titolo di
Patriarca «Ecumenico». Papa Gregorio si definì «Servo di Dio» che nell’Amtico
Testamento è un titolo onorifico, sinonimo di ambasciatore/rappresentante, e
per sottolineare l’umiltà del ministero aggiunse «dei servi di Dio», cioè il
Popolo santo dei credenti. L’appellativo, per le circostanze in cui è nato, ha
un richiamo esplicito al profeta Samuele: «Parla, Signore, perché il tuo servo
ti ascolta» (1Sam 3,9-10).
La misericordia nel sangue
Francesco di Assisi andava in giro per la città predicando
il Vangelo «sine glossa», cioè senza alcun commento, ma testimoniandolo con la
vita e l’esempio e assumendo la povertà assoluta come misura della sequela di
Cristo. Papa Francesco, che prende il nome del poverello di Assisi, si condanna
da sé a essere inchiodato a una vita di austerità e povertà, anche esteriore,
perché quel nome non è un nome qualsiasi, ma quello di uno che «fece sul serio».
Papa Francesco è coerente e due anni di servizio petrino lo dimostrano: egli è
quello che appare e fa quello che dice (cf Mt 23,3).
Nell’esortazione apostolica «Evangelii Gaudium», Papa
Francesco scrive facendo eco al Santo suo ispiratore e facendo suo il metodo
del «sine glossa»:
«È vero che, nel nostro rapporto con
il mondo, siamo invitati a dare ragione della nostra speranza, ma non come
nemici che puntano il dito e condannano. Siamo molto chiaramente avvertiti: “Sia
fatto con dolcezza e rispetto” (1 Pt 3,16), e “se possibile, per quanto dipende
da voi, vivete in pace con tutti” (Rm 12,18). Siamo anche esortati a cercare di
vincere “il male con il bene” (Rm 12,21), senza stancarci di “fare il bene”
(Gal 6,9) e senza pretendere di apparire superiori ma considerando “gli altri
superiori a se stesso” (Fil 2,3). Di fatto gli Apostoli del Signore godevano “il
favore di tutto il popolo” (At 2,47; cfr. 4,21.33; 5,13). Resta chiaro che Gesù
Cristo non ci vuole come principi che guardano in modo sprezzante, ma come
uomini e donne del popolo. Questa non è l’opinione di un Papa né un’opzione
pastorale tra altre possibili; sono indicazioni della Parola di Dio così
chiare, dirette ed evidenti che non hanno bisogno di interpretazioni che
toglierebbero ad esse forza interpellante. Viviamole sine glossa, senza
commenti. In tal modo sperimenteremo la gioia missionaria di condividere la
vita con il popolo fedele a Dio cercando di accendere il fuoco nel cuore del
mondo» (EG, 271).
Questo è l’uomo che ha indetto il Giubileo Straordinario
della Misericordia, parola che segnava la vita di Bergoglio già prima di essere
eletto. Quando nel 1992 era stato eletto Vescovo, secondo la tradizione come
suo motto episcopale scelse il motto latino: «Miserando atque eligendo». La
frase è tratta dalle Omelie di san Beda, detto il Venerabile (672-735),
il quale, commentando l’episodio evangelico della vocazione di san Matteo,
scrisse: «Vide Gesù un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimento di amore
[in latino: miserando = avendone misericordia] e lo scelse, gli disse:
Seguimi» (Omelia 21; CCL 122, 149-151).
Non è più tempo di difendere i princìpi a forza di
manifestazioni o urla, oggi è l’umile tempo del sacramento della testimonianza
con la vita, che è il vero martirio che il Vangelo chiede a quanti vogliono
avventurarsi per questa via, senza esaurirsi in una religiosità esteriore e di
convenienza. Annunciando il Giubileo, Papa Francesco, come novello Giona,
attraversa la Ninive della storia, annunciano a tutti non la «Misericordia di
Dio», ma che «Dio è Misericordia». In questo modo egli resta fedele alla sua
storia personale e alla sua vocazione, dando spazio alla Dimora/Shekinàh dello
Spirito nella sua vita. Da Papa ha coscienza di dovee testimoniare la realtà
davanti al mondo e davanti a chiunque incontri. D’altra parte anche Gesù ha
iniziato il ministero pubblico nella sinagoga di Nàzaret, scandalizzando i
cultori del Dio «castigamatti», annunciando per tutti un Dio dal Volto non solo
umano, ma amorevole e carico di tenerezza e di amore a perdere:
«18Lo Spirito del Signore è sopra di me; / per questo mi ha
consacrato con l’unzione / e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio,/ a proclamare ai prigionieri la liberazione/ e ai ciechi la vista;/ a
rimettere in libertà gli oppressi,/ 19a proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 1,18-19).
Ogni tempo è «anno di grazia» perché il tempo di ciascuno è
diverso dal tempo degli altri, ma il tempo di Dio è sempre un «kairòs –
occasione propizia» da afferrare, perché Dio ha tutta l’eternità per perdere il
suo tempo con noi, suoi figli e figlie, oggi e domani. Sempre.
Paolo Farinella, prete
Paolo farinella