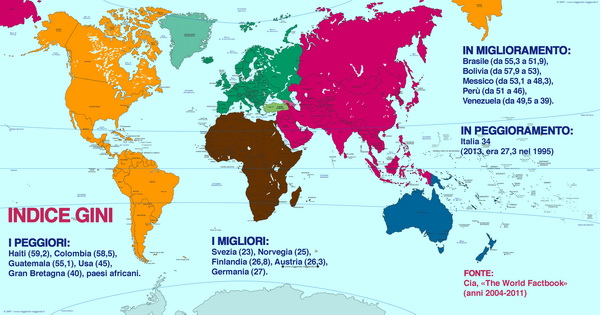Cari Missionari
Ho l’impressione
che si dicano un sacco di esagerazioni sulla vicenda degli orfani che non
vengono fatti partire dal Congo insieme ai genitori adottivi italiani. Per quel
che ne so, non esistono orfani nell’Africa nera, in quanto quando muore il
padre, oppure quando muoiono ambedue i genitori, i bambini non sono
abbandonati, ma vengono adottati dallo «zio», e pure da tutto il clan. Nel 1966
volevo adottare una bambina orfana di tre anni, Hélène, ma lo «zio» si oppose,
pur ringraziando, poiché in Congo non esistevano gli orfani. Ciò è stato
confermato sere fa in un dibattito pubblico a Corridonia da un missionario
della Consolata, da anni in Congo a Kinshasa.
Se le
autorità congolesi si oppongono, oppure ci vanno caute, è perché americani e
canadesi si stanno portando via i bambini congolesi senza alcun controllo. Ciò
sempre secondo quel missionario. Esiste, allora, una «tratta» dei bambini
congolesi, fatti passare per «orfani» da una organizzazione missionaria o
laica, o da burocrati governativi? Quanto è costato ai futuri genitori italiani
adottare un bambino congolese?
I bambini sono una ricchezza per l’Africa nera e in tale
maniera vengono considerati da quelle popolazioni. In questo caso gli Africani
si dimostrano più civili e umani di noi Occidentali.
Certe cose il ministro Kyenge dovrebbe
conoscerle; a meno che, stando nel mondo civilizzato, abbia dimenticato come la
pensano dalle sue parti.
Giorgio Rapanelli
Corridonia (Mc), 1/1/2014
Premesso che provo grande empatia e dispiacere per le coppie che si
trovano bloccate con le loro
adozioni in Congo, anche perché ho avuto modo di vederle e sentire la
loro situazione. E che nell’incontro tenutosi a Corridonia, a cui fa
riferimento l’amico Giorgio, si è parlato di altri temi, e solo di sfuggita di
adozioni. Voglio qui condividere alcuni punti che ritengo importanti come
contributo alla riflessione:1. È vero, almeno secondo la mia esperienza, che nella cultura africana è
inconcepibile affidare un bambino orfano a estranei, perché esiste la realtà
della famiglia
allargata, per cui
anche il parente più lontano ha una serie di diritti/doveri sul bambino, tanto
da rendere praticamente impossibile, per qualsiasi tribunale, dichiarare
l’adottabilità di un minore senza suscitare forte malcontento nella famiglia.
Purtroppo, a causa della povertà e delle guerre che assediano l’Africa, oggi
assistiamo anche a delle degenerazioni della questione, per cui c’è il caso, ad
esempio, degli orfani di guerra e dei bambini-stregoni. In quest’ultimo caso
essi sono considerati dei veri e propri rifiuti da parte delle famiglie che
addossano ai bambini tutte le colpe della loro triste situazione.2. Le adozioni inteazionali sono disciplinate dalla Convenzione dell’Aja, cui hanno aderito quasi tutti gli stati
del mondo tranne quelli africani e musulmani. Anche il Congo non ha
sottoscritto tale convenzione e non ha neppure un trattato bilaterale con
l’Italia in merito. Perciò le poche pratiche che si fanno in Congo dipendono
dai giudici locali che cercano più di spillare soldi che di aiutare e sistemare
i bambini. L’ideale sarebbe sempre che uno possa fiorire dove è stato seminato.
Anche la Convenzione
dell’Aja vede
l’adozione come una scelta estrema e sostiene la volontà di garantire al
bambino la possibilità di rimanere nel suo mondo culturale. Un’associazione che
coinvolga una coppia nell’adozione di un bambino in uno stato che non abbia
aderito alla Convenzione
dell’Aja o che
non abbia sottoscritto un trattato bilaterale compie un atto temerario, assai
rischioso sia per i bambini che per gli aspiranti genitori. Non ci si dovrebbe
fidare facilmente.3. Inoltre, per finire, l’intervento del governo Congolese, non è
direttamente contro le coppie italiane. è
dovuto al fatto che vogliono vederci chiaro su una situazione critica da anni
che ha favorito il commercio dei bambini da parte di funzionari, compagnie e
associazioni senza scrupoli. Per una volta che un governo si assume le sue
responsabilità lo facciamo passare come antiumano e crudele.Grazie, auguri e buona riflessione! Coraggio e avanti in Domino!
P. Stefano
Camerlengo
Roma 09/01/2014
Caro Signor Giorgio,
ho scomodato il nostro padre generale per questa risposta, perché ha avuto una
lunga esperienza in Congo ed è anche suo compaesano. Da parte mia posso solo
aggiungere che la situazione degli orfani in Africa si è aggravata, oltre che
per le ragioni sopra riportate – povertà, guerre e malattie -, paradossalmente
anche grazie agli effetti positivi di quello che impropriamente chiamiamo
sviluppo: miglioramento degli standard di vita, diminuzione della mortalità
infantile e scolarizzazione. Un tempo, nella società pastorale o agricola, un
orfano era sì una bocca in più da sfamare, ma ben presto diventava anche un
soggetto che poteva contribuire alla vita della famiglia e del clan attraverso
il lavoro nei campi o nella cura del bestiame. Ora invece moltissime famiglie
sono impoverite, vivono nelle periferie delle grandi città senza campi né
bestiame; in più i bambini devono essere mandati a scuola. E la scuola non è
gratuita, ma costa, e tanto. E in città il cibo è caro, non si raccoglie nel
campo, si compra. E non bastano più le medicine tradizionali quando uno è
malato, le medicine si pagano. Per questo, nonostante la grande solidità della
famiglia allargata africana, gli orfani aumentano.Oltre all’adozione vera e propria, che è una delle
risposte a questi problemi, c’è anche un altro modo di aiutare: l’adozione (o,
meglio, il sostegno) a distanza o a progetto, che permette ai bambini di
restare nel loro ambiente e aiuta una comunità a prendersi cura dei propri
figli.Noi come missionari, da oltre un secolo stiamo seguendo
questa strada, per altro proposta oggi da tantissime organizzazioni, alcune
molto serie, altre anche fraudolente. Il dramma degli orfani è così grave da
esigere la collaborazione di tutti, senza sterili polemiche.
.jpg) Se Natale è la festa della luce che scaccia le tenebre e
Se Natale è la festa della luce che scaccia le tenebre e
della verità che sconfigge la menzogna, quindi anche la cattiva informazione,
un regalo migliore dell’articolo sulla Siria, pubblicato proprio nel mese di
dicembre, non potevate farcelo.
Mi sembra superfluo aggiungere che condivido le critiche
da voi fatte ai grandi mezzi di comunicazione. Anche la nostra Rai, che molti
definiscono la maggiore industria culturale italiana, con pochissimi eguali in
Europa, poteva fare di più e di meglio: quella che ci ha raccontato finora
sulla Siria è una storia che lascia un po’ a desiderare. Eppure proprio la Rai,
con l’enfasi data a certi grandi eventi come la Fiera Aeronautica di Dubai di
metà novembre, ha confermato quanto pesino Arabia Saudita, Emirati Arabi e
Qatar nello scacchiere globale e quali ripercussioni abbiano le loro mosse
sull’economia, sulla finanza e, di riflesso, sulla politica.
Sono proprio i paesi arabi del Golfo, quegli stessi che
voi giustamente avete indicato come responsabili della catastrofe siriana, a
comprare le grandi società di calcio, a dare lavoro alle grandi imprese
dell’edilizia e dell’arredo, a ospitare i Gran Premi di Formula Uno, ad
acquistare compagnie aeree o parti di esse, e soprattutto a dare sbocchi di
mercato altrimenti introvabili ai grandi e costosissimi (anche in termini di
impronta ecologica e impatto ambientale…) consorzi dell’industria aeronautica
– l’americano Boeing e l’europeo Airbus -, dei quali è partner, specie per quel
che riguarda la realizzazione delle fusoliere, la nostra Alenia Aeronautica.
Quando, in appena due giorni, tre compagnie aeree arabe
riescono, da sole, ad acquistare duecento grandi aerei, tra cui i Boeing 787
Dreamliner («aereo dei sogni»…) e Airbus 380, facendo finire nelle casse di
Seattle, Tolosa, Amburgo, Londra, Madrid, Grottaglie e Nola la bellezza di
cento miliardi di dollari, possiamo farci un’idea di quale sia il potere
contrattuale degli Arabi e del grado di dipendenza del Pil mondiale dallo
shopping degli sceicchi. Possiamo farci un’idea però anche di quanto sia
urgente procedere a una drastica correzione dell’attuale modello di sviluppo,
affinché quello con gli Arabi non diventi un abbraccio mortale, per noi e per
loro.
La pace non può non essere il primo degli obbiettivi e il
primo dei sogni di paesi che si dicono civili, democratici, evoluti,
progrediti: pazienza se questo significherà qualche affare in meno con i
nababbi del Golfo Persico, pazienza se ci sarà qualche punto di Pil in meno e
qualche mugugno in più di industriali e sindacati.
Se poi anche Papa Francesco dice che «la pace è
artigianale» e quindi né industriale, né petrolchimica, né avionica, né
imprenditorial-finanziaria, né agrobusiness… Buon Natale e Buon Anno.
Francesco Rondina
Fano, 25/12/2013
Alle pagine 30-32 della rivista del dicembre scorso ho
letto con grande interesse l’articolo di don Paolo Farinella. Ho una domanda:
che età poteva avere il Cristo quando è morto? Là trovo scritto 36 anni circa,
mentre ci hanno sempre insegnato che ne aveva 33. Posso contare su una risposta
sia pur telegrafica? Grazie
cav. Sergio
Gentilini
Roveredo in Piano (Pn)
A che età è
morto Gesù? A 33 anni o a 36? La questione è dibattuta da due mila anni e ancor
a oggi non ne veniamo a capo. Si possono solo fare ipotesi con i pochi dati che
abbiamo a disposizione. Non sappiamo quando Gesù sia nato perché la data del 25
dicembre è puramente convenzionale, come spiegammo nel numero di MC di
dicembre. Sappiamo che nel redigere un computo temporale Dionigi l’Aeropagita
fece un errore di calcolo, in base al quale considerò l’«anno 0» come data di
nascita, mentre oggi sappiamo, e tutti gli studi lo confermano, che Gesù nacque
tra il 7 e il 5 a.C. Ma cambiare il calendario, spostandolo indietro sarebbe
un’impresa ormai impossibile. Le notizie che abbiamo dai Vangeli e da altre
fonti non sono decisive a riguardo. I Vangeli affermano che Gesù morì un venerdì
sera antecedente la Pasqua ebraica, la quale cade nel mese di Nisan,
corrispondente al nostro metà marzo, metà aprile (dipende dalla luna). Per gli
Ebrei, il giorno comincia al tramonto del sole del giorno prima, quindi venerdì
sera, dopo il tramonto è già il giorno Sabato. Per Mc, Mt e Lc (Vangeli
sinottici), infatti, Gesù morì il giorno di Pasqua (Pesach, il sabato 15 del
mese di Nisan), mentre per Giovanni la morte sarebbe avvenuta la vigilia del
Sabato, cioè prima del tramonto. Lo scopo di Giovanni è fare coincidere la
morte di Gesù con l’ora (le ore 16,00) del sacrificio nel tempio di Gerusalemme
per presentare Gesù come «Agnello di Dio» sgozzato sulla croce.Da tutta una serie di computi, confronti e studi, le date possibili
sono tre: il 7 aprile dell’anno 30, oppure il 27 aprile dell’anno successivo o
il 3 aprile dell’anno 33. Sia i Vangeli che lo storico ebreo Giuseppe Flavio ci
dicono che Gesù morì durante l’amministrazione del procuratore romano Ponzio
Pilato che gli studiosi fissano tra il 26 e il 36 dC. I Vangeli dal canto loro
aggiungono che Gesù fu condannato a morte durante il sommo sacerdozio di Caifa,
che era manovrato dal suocero Anna (a sua volta ex sommo sacerdote). Il
pontificato di Caifa si colloca tra l’anno 18 e il 36 dC, in concomitanza con
il procuratore Ponzio Pilato. Secondo Lc, Pilato per un atto politico inviò Gesù
a Erode Antipa che regnò per conto dei Romani sulla Galilea tra il 4 aC e il 39
dC. Da tutta questa ubriacatura di date, di anni e di nomi, la conclusione è
che la morte di Gesù deve essere avvenuta tra il 26 e il 36, logicamente dC. Se
fosse stato l’anno 26, tenuto conto che è nato circa 6 anni prima di quanto
crediamo noi, sarebbe morto all’età di 32/33 anni circa; se invece fosse stato
l’anno 36, tenuto conto dello stesso motivo, Gesù sarebbe morto dieci anni
dopo.Come si vede
non possiamo chiedere ai Vangeli una «precisione» cronologica che non possono
darci, perché il loro scopo è catechetico e teologico, non storico (come
intendiamo noi questa valenza). Noi sappiamo che i primi cristiani hanno identificato
Gesù con Isacco, il figlio di Abramo che stava per essere sacrificato dal padre
sul monte Moria. Secondo la tradizione ebraica, Isacco incitava il padre a
compiere fino in fondo il suo dovere di obbedienza a Dio e quindi si offrì
liberamente al sacrificio. La stessa tradizione parla di Isacco «legato» alla
legna come Gesù fu «legato/inchiodato» alla croce. Poiché si suppone che
l’episodio del sacrificio d’Isacco sia avvenuto quando questi aveva 36 anni,
applicando a Gesù un’età simile, non si è lontani dalla realtà perché si resta
perfettamente tra i 32/33 anni e i 42/43. Ciò che conta per i Vangeli è che Gesù
nacque, visse e morì, offrendo la sua vita in dono e senza chiedere in cambio
nulla. Sì, tutta la sua vita fu un atto permanente di amore a perdere.


Un brindisi
a padre Egidio (Crema)
In data 2 Gennaio 2014 padre Egidio Crema ha festeggiato
il suo 90esimo compleanno qui al Consolata Hospital di Ikonda dove si trova
ospitato. Vi inviamo due fotografie della cena conviviale a cui hanno
partecipato padre Sandro Nava, la dottoressa Manuela, la dottoressa Virginia
Quaresima, il dottor Gianpaolo Zara, il dottor Giuseppe Vasta e la sua badante
Rosy. Sarebbe bello che queste foto fossero pubblicate
per rendere onore a un missionario che dal
1950 ha lavorato in Tanzania e ora si è ritirato al Consolata Hospital che
funge anche da casa di riposo e cure per i missionari anziani e ammalati in
Tanzania.
p. Sandro Nava e dott.ssa Manuela Buzzi
Ikonda, Tanzania
Risponde il Direttore

 Isidoro
Isidoro
 Isidoro muore nel 1130 e lo seppelliscono
Isidoro muore nel 1130 e lo seppelliscono Il caso di Belgin Dogru: a scuola senza velo
Il caso di Belgin Dogru: a scuola senza velo
.jpg)
.jpg)

 Portfolio:
Portfolio: 





















 La cerimonia conclusiva è simpatica. Lo sposo prende la sposa
La cerimonia conclusiva è simpatica. Lo sposo prende la sposa E perché non succeda come nelle storie di una volta nelle quali
E perché non succeda come nelle storie di una volta nelle quali
 La ricorrenza sciita
La ricorrenza sciita







 A ben guardare, però, scorgo
nelle immagini anche il piglio risoluto, deciso, di colui che è buono con
sincerità, non per debolezza o convenienza. Il volto del Beato Allamano non ha
nulla di debole e comunica serenità e determinazione. Non so se altri lettori
siano stati attratti, sfogliando il calendario, da questa caratteristica del
suo viso. Forse sono io che ci ricamo sopra eccessivamente, lasciandomi guidare
dalla mia sensibilità. Può darsi, non lo posso escludere. Mi sembra in ogni
caso che lo sguardo del fondatore lasci intravedere qualcosa di lui, del suo
modo di essere e di intendere la vita. Gli occhi sono lo specchio dell’anima,
recita un antico adagio.
A ben guardare, però, scorgo
nelle immagini anche il piglio risoluto, deciso, di colui che è buono con
sincerità, non per debolezza o convenienza. Il volto del Beato Allamano non ha
nulla di debole e comunica serenità e determinazione. Non so se altri lettori
siano stati attratti, sfogliando il calendario, da questa caratteristica del
suo viso. Forse sono io che ci ricamo sopra eccessivamente, lasciandomi guidare
dalla mia sensibilità. Può darsi, non lo posso escludere. Mi sembra in ogni
caso che lo sguardo del fondatore lasci intravedere qualcosa di lui, del suo
modo di essere e di intendere la vita. Gli occhi sono lo specchio dell’anima,
recita un antico adagio.
 In povertà e in ricchezza / 2
In povertà e in ricchezza / 2.jpg)
.jpg) Concentrazione versus
Concentrazione versus