Uomo Nero, Torna A Casa Tua

la dura vita dei richiedenti asilo africani.
A migliaia,
fuggiti da conflitti africani, si ritrovano in Israele dopo un viaggio impossibile.
Ma per i richiedenti asilo l’integrazione è molto difficile. Non esiste una
legge che li tuteli. I politici di destra al governo li considerano una
minaccia. Le associazioni denunciano: immigrazione gestita su base religiosa.
Corre per oltre 250 chilometri il susseguirsi di reti e
muri che dividono il deserto del Sinai da Israele. Tel Aviv ha deciso la
costruzione di queste barriere per bloccare il flusso di migranti che negli
ultimi anni arriva sempre più copioso dall’Africa sub-sahariana. Sono i figli
dell’Africa nera: eritrei, somali, sudanesi, congolesi, nigeriani, ivoriani che
scappano dai loro paesi dilaniati da guerre, tanto lunghe quanto cruente.
Attraversano il deserto del Sahara e in molti scelgono di proseguire per
l’Egitto e la Libia, i più «fortunati» s’imbarcheranno per il tragico viaggio
verso Lampedusa. Una parte minoritaria decide di continuare a piedi attraverso
il deserto del Sinai, verso quella che in Europa definiamo «l’unica democrazia
del Medioriente». Israele accetta di malavoglia i richiedenti di asilo
politico. Sono decine le denunce di associazioni umanitarie, israeliane e
inteazionali, che parlano di soldati che sparano contro uomini e donne mentre
questi tentano di superare il confine tra Israele ed Egitto.
Yaki ha finito il servizio militare da qualche anno e ora studia
in una grande città europea. Per oltre dodici mesi ha pattugliato il confine
meridionale israeliano: «Da lì entrano i terroristi. Sono quelli che hanno
fatto scoppiare gli autobus negli anni passati». Yaki non è un estremista di destra, né uno
sprovveduto facilmente influenzabile dalla propaganda governativa. Nato e
cresciuto in una famiglia israeliana della media borghesia, a 18 anni è stato
catapultato in 36 mesi di servizio militare obbligatorio. «Personalmente –
continua l’ex militare – non ho mai sparato contro i migranti, ma ho negli
occhi l’immagine di una notte in cui una pattuglia ha iniziato a fare fuoco
contro un gruppo di donne. Non ci sono stati morti, ma quando abbiamo parlato
con loro ci hanno raccontato che erano state tutte rapite e violentate per mesi
dai beduini nel deserto». Le donne di cui racconta Yaki, come la maggioranza
degli africani che arrivano in Israele attraversando il Sinai, sono state
trasferite in un centro di detenzione nel deserto nel Neghev, Sud del paese,
per essere identificate, seguendo lo stesso principio dei Cie (Centro di
identificazione ed espulsione) e Cara (Centri di accoglienza richiedenti asilo)
in Italia.
Dal maggio 2012 a Tel Aviv è stato messo in funzione un nuovo
centro di detenzione che, a pieno regime, potrà ospitare fino a 16mila persone
nel Neghev. È stato definito, dai pochi a cui è stato permesso l’accesso, «un’immensa
prigione di tende e prefabbricati nel deserto». Da ottobre la polizia di
frontiera ha iniziato a respingere nel deserto del Sinai i rifugiati africani,
un’altra triste analogia con la politica di contenimento all’immigrazione
attuata dall’Europa.

Tel Aviv è la città simbolo della nascita
dello stato ebraico, un agglomerato urbano dove vivono circa tre milioni di
persone, quasi la metà della popolazione israeliana. Le prime case spuntarono a
inizio anni ’40, come periferia di Jaffa, uno dei più antichi e conosciuti
porti arabi del Mediterraneo. Con la creazione dello Stato ebraico, nel 1948,
si costruirono velocemente i grandi palazzi sulla spiaggia, che tutt’ora
ospitano i più rinomati alberghi d’Israele, costituendo uno skyline
simile a una grande città della Florida.
Le case degli arabi residenti a Jaffa, per lo
più scappati durante la guerra del ’48, vennero inglobate nel grande processo
di urbanizzazione. Dopo 60 anni Tel Aviv è diventata una delle città più care
al mondo per acquistare casa. Si sono concentrati qui soprattutto i giovani e
la parte meno religiosa d’Israele, lasciando Gerusalemme agli ultra-ortodossi.
A Tel Aviv sorge il più importante aeroporto
d’Israele, l’unico che fa atterrare i voli di linea inteazionali. Ed è qui
che diciotto anni fa atterrò l’aereo di Oscar Oliver, 45 anni, congolese. Oscar
scappava da un conflitto lungo e sanguinoso come solo le guerre civili sanno
essere. Era portavoce del sindacato studentesco e per le sue idee venne
arrestato e perseguito. Scappò dal Congo all’Egitto «ma non mi andava di
passare da una dittatura a un’altra» quindi chiese e ottenne un visto
lavorativo per arrivare in Israele. Ora è uno dei 60mila africani richiedenti
asilo politico residenti in Israele senza documenti. Oscar vive in clandestinità
con sua figlia, 9 anni, nata a Tel Aviv, ma senza la residenza israeliana. «Il
problema – spiega Oscar – è che le autorità gestiscono l’immigrazione su una
base religiosa. Non ci sono leggi che regolamentino l’ingresso di persone in
pericolo, questo è il cuore della questione: non c’è una legge per accogliere
chi non è ebreo». Dal punto di vista legale, Israele ha firmato la Convenzione
di Ginevra, che sancisce i diritti delle vittime di guerra e più in generale il
diritto internazionale umanitario, ma si rifiuta di riconoscere lo status di
rifugiato.
Oscar, come circa l’ottanta percento dei
richiedenti asilo africani, vive in una bolla di Tel Aviv, il quartiere di Neve
Sha’an, che sorge attorno all’enorme stazione dei bus. In Israele non c’è un
sistema ferroviario efficiente, gran parte della popolazione si muove con
modei bus verdi. I prezzi sono bassi e le rotte coprono tutto il paese. Come
in ogni grande centro urbano il quartiere accanto alla stazione è uno dei più
degradati della città: case fatiscenti, pochi servizi e ancor meno sicurezza.
Il picco del degrado è certamente il parco Levinsky, un paio di ettari in pieno
centro a Tel Aviv, esattamente alle spalle della stazione degli autobus. Qui
dorme ogni notte qualche migliaio di persone, tutte africane, buona parte delle
quali in Europa sarebbero inserite nel processo di richiesta di asilo politico.

Ci sono in Israele circa 60mila rifugiati
africani, di cui circa 40mila sono eritrei, altri 15mila vengono dal Sudan, metà
dei quali sono cristiani provenienti dal Sud Sudan mentre l’altra metà arriva
dal Darfur e sono musulmani. Fino alla scorsa primavera c’erano circa 2mila
persone originarie della Costa d’Avorio, ma negli ultimi mesi sono state in gran
parte deportate.
Al momento le autorità stanno cercando di
fare rimpatriare anche parte dei rifugiati fuggiti dal Sud Sudan. Le
espressioni usate per definire i richiedenti asilo politico sono al centro di
una campagna condotta dal governo israeliano: non vengono chiamati rifugiati,
ma infiltrati, quasi a richiamare il termine utilizzato per gli attentatori
palestinesi durante la seconda intifada. Il governo non parla di deportazioni,
termine troppo simile a quello usato in Europa negli anni ’30 e ’40, ma di
rimpatri volontari «anche se in molti – racconta Oscar – sanno che tornando nei
loro paesi d’origine troveranno i loro aguzzini ad aspettarli».
L’Ong Human Rights Watch ha accusato
il governo israeliano di contribuire a creare un’atmosfera negativa nei
confronti dei migranti. Secondo il sondaggio pubblicato a inizio novembre dal
quotidiano Israel Hayom, sembra che la strategia abbia funzionato: il
52% degli israeliani non vorrebbero come vicino di casa un lavoratore
straniero. Nell’ultimo anno ci sono state molte manifestazioni contro i
migranti africani organizzate da vari movimenti di destra sia a Tel Aviv che a
Gerusalemme. In una di queste marce Michael Ben Ari, un parlamentare
israeliano, ha incitato la folla urlando: «Io lo so, sono venuti per distruggere
il paese». Durante l’ultima estate si sono registrati attacchi fisici almeno
una volta alla settimana. Persino un asilo nido, frequentato per la maggioranza
da bambini eritrei, è stato dato alle fiamme.
I partiti di destra che governano il paese hanno una posizione
molto netta sui rifugiati africani e non perdono occasione per rimarcarla. Il
primo ministro Benjamin Netanyahu ha definito i migranti africani come una
minaccia all’identità dello stato ebraico. Elli Ishai, ex ministro
dell’Inteo, ha dichiarato a una tv israeliana: «La soluzione è chiara.
Neghiamo loro il permesso di lavorare, li imprigioniamo e li rimandiamo in
Eritrea». Miri Regev, già parlamentare: «I sudanesi sono un cancro nel corpo
della nostra nazione». Danny Dannon, parlamentare: «La soluzione è parlare
apertamente di deportazione. Dobbiamo deportare gli infiltrati».
«Gli africani che arrivano in Israele non sono alla ricerca di un
lavoro, ma di protezione» ripetono invece come un mantra gli attivisti e i
pochi politici che da anni lavorano per integrare i rifugiati nella società
israeliana. La possibilità di essere impiegati, se non in nero, è molto bassa,
perché lo stato ebraico non riconosce ai richiedenti asilo un permesso di
lavoro. Questa condizione spinge ancora più in basso i rifugiati, infatti molti
di loro sono stati costretti a pagare un riscatto per essere rilasciati, dopo
essere stati sequestrati in Sinai. I trafficanti chiedono fino a 10mila
dollari, una cifra enorme per i paesi dell’Africa sub-sahariana. Le famiglie
per aiutare i propri ragazzi s’indebitano, debito che ricade sulle spalle dei
richiedenti asilo.

Israele è una nazione composta per l’ottanta percento da figli e
nipoti di rifugiati. Ed è proprio su questo punto che insistono i volontari di Levinsky
Soup (La Zuppa di Levinsky), un gruppo di cittadini, che da febbraio dello
scorso anno aiuta gli africani che vivono nel parco. Iris ha studiato in Italia
due anni e ha una vaga idea di come funziona il programma di protezione per i richiedenti
asilo in Italia e in Europa: «Il problema qui è governativo ed è sicuramente
l’agenda per la quale il paese deve rimanere a maggioranza ebraica. È una cosa
razzista. Non vogliono aiutare o permettere ad altre persone di restare qui. Ma
non si prendono nemmeno il tempo di controllare se questi ragazzi hanno i
requisiti o meno per ottenere l’asilo politico». Mentre Iris parla si forma una
lunga coda, gli africani ordinatamente aspettano l’unico pasto caldo della
giornata. «La cosa che non ha senso – continua Iris – è che Israele è composto
per la maggior parte da seconde o terze generazioni di rifugiati
dell’Olocausto. Dobbiamo aiutare i rifugiati africani come obbligo verso i
nostri padri, che si sono salvati, che da rifugiati hanno creato uno stato».
Shlomo arriva al parco su una bici che traina uno strano carretto, ci sono
dentro due pentoloni: «Più di venti chili di riso bianco, la base dei nostri
pasti. Serviamo ogni sera tra i 500 e gli 800 piatti, più di qualsiasi ente di
solidarietà in Israele». Levinsky Soup è un gruppo informale di
cittadini che si è autorganizzato lo scorso inverno dopo la morte per ipotermia
di un rifugiato nel parco. «Non ci è sembrato possibile – spiega Shlomo mentre
scodella il riso – siamo rimasti scioccati e come singoli cittadini abbiamo
deciso di fare qualcosa. Questo è un paese accogliente, lo è stato con i nostri
genitori e noi dobbiamo esserlo con altri». Passeggiando per il parco si vedono
coperte e buste di plastica piene di vestiti incastrate all’incrocio dei rami
degli alberi. «Israele – continua Shlomo – ha già dovuto affrontare la
questione dell’immigrazione di massa. Abbiamo gestito quasi un milione di
arrivi con la disgregazione dell’Unione Sovietica, non posso credere che il
governo sia traumatizzato da 60mila rifugiati africani. Vorremmo vedere la
democrazia applicata per tutti e non solo per gli ebrei».
Per gli abitanti del parco, se un pasto caldo è quasi
un’eccezione, l’accesso ai servizi sanitari è praticamente impossibile. L’Ong Physician
for Human Rights, Phr, (Medici per i diritti dell’uomo) è una delle poche
associazioni alla quale si possono rivolgere i rifugiati. «Il 59% dei nostri
pazienti – racconta Ran Cohen, operatore dell’Ong – ha subito torture e abusi,
anche di carattere sessuale, durante il passaggio in Sinai. Phr ha una sede con
ambulatorio a pochi minuti a piedi dal parco, nulla a che vedere a confronto
dei grandi ospedali privati della zona Sud di Tel Aviv, ma da qui passano ogni
settimana centinaia di richiedenti asilo. L’Ong lavora contrastando
quotidianamente le difficoltà di un lavoro «scomodo»: aiutare decine di
migliaia di persone che non sono benvenute a causa della provenienza, della
loro religione: «Aiutare i rifugiati – conclude Ran – è quasi un crimine in
Israele».
Cosimo
Caridi
Cosimo Caridi
 Situazione economica e culturale degli amerindi Warao
Situazione economica e culturale degli amerindi Warao




 La scomparsa del dottor
La scomparsa del dottor






 Prima di partire da Roma, di mons. Padilla sapevamo solo
Prima di partire da Roma, di mons. Padilla sapevamo solo Nel frattempo mons. Padilla era stato ordinato vescovo e
Nel frattempo mons. Padilla era stato ordinato vescovo e



 Con lo sviluppo portato da questo fenomeno, il tenore di
Con lo sviluppo portato da questo fenomeno, il tenore di

 In pochi anni, Gengis Khan (1162-1227) e i suoi quattro
In pochi anni, Gengis Khan (1162-1227) e i suoi quattro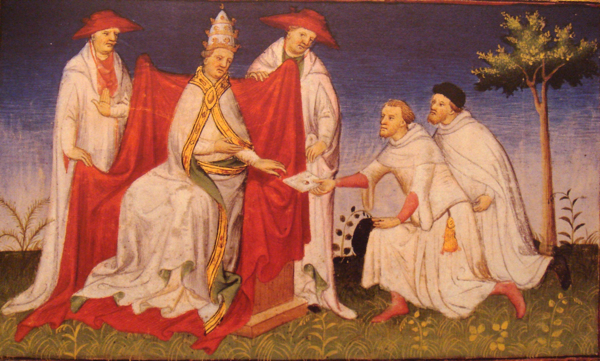

 Nato nel 1247 a Montecorvino, vicino a Saleo, «dottissimo
Nato nel 1247 a Montecorvino, vicino a Saleo, «dottissimo A portare per primi il
A portare per primi il Dossier di di Benedetto Bellesi,
mons. Wenceslao Padilla, Giorgio Marengo
La Chiesa cattolica in
Mongolia è la più giovane tra le chiese particolari nel mondo: ha appena 20
anni di età e ha festeggiato con meritato orgoglio il suo ventesimo compleanno
nel corso del 2012. Ad aprire le celebrazioni nella cattedrale di Ulaanbaatar è
stato mons. Savio Hon, segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione
dei Popoli. Si tratta di «una Chiesa di piccole dimensioni, ma di grande
vitalità» ha affermato il presule. Tale vitalità è stata espressa anche
simbolicamente: a conclusione dei festeggiamenti, rispondendo all’invito del
loro vescovo mons. Wenceslao Padilla, i cattolici mongoli hanno piantato un
albero, come augurio che il Vangelo di Cristo affondi sempre più profondamente
le radici nei cuori della popolazione mongola.
Dossier di di Benedetto Bellesi,
mons. Wenceslao Padilla, Giorgio Marengo
La Chiesa cattolica in
Mongolia è la più giovane tra le chiese particolari nel mondo: ha appena 20
anni di età e ha festeggiato con meritato orgoglio il suo ventesimo compleanno
nel corso del 2012. Ad aprire le celebrazioni nella cattedrale di Ulaanbaatar è
stato mons. Savio Hon, segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione
dei Popoli. Si tratta di «una Chiesa di piccole dimensioni, ma di grande
vitalità» ha affermato il presule. Tale vitalità è stata espressa anche
simbolicamente: a conclusione dei festeggiamenti, rispondendo all’invito del
loro vescovo mons. Wenceslao Padilla, i cattolici mongoli hanno piantato un
albero, come augurio che il Vangelo di Cristo affondi sempre più profondamente
le radici nei cuori della popolazione mongola.