I profitti del Covid, tanti e per pochi
A oltre due anni dall’inizio della pandemia che ha sconvolto l’esistenza dell’umanità, ci sono pochissimi vincitori. In prima fila, le multinazionali del web e quelle farmaceutiche. Con tanti soldi pubblici e le consuete ingiustizie.
La conta definitiva dei danni provocati dal Covid si potrà fare solo a pandemia superata. Per ora i numeri raccontano che, a fine 2021, si contavano più di cinque milioni di morti a livello mondiale e una perdita economica stimata in 3mila miliardi di dollari dovuta agli arresti produttivi, i famosi lockdown decretati in molti paesi industrializzati nel corso del 2020. Con inevitabili contraccolpi anche per i paesi più poveri che, nel 2020, hanno registrato un crollo delle loro esportazioni fino al 40%.
Detto questo, il Covid non è stata una sciagura per tutti. Al contrario, per qualcuno è stata una vera manna. Ad esempio, la riduzione della vita sociale ha provocato un boom delle attività online che hanno permesso ai giganti del web di ottenere profitti da nababbi. Tipico il caso di Amazon che, nel 2020, ha realizzato un fatturato pari a 386 miliardi di dollari, il 38% in più dell’anno precedente, mentre i suoi profitti sono aumentati dell’84% passando da 11,5 a 21,3 miliardi di dollari.
Nei primi mesi di pandemia non ci sono state altre imprese vincenti quanto quelle informatiche, ma di lì a poco anche per le imprese farmaceutiche il Covid si sarebbe dimostrato una gallina dalle uova d’oro. In particolare, per quelle dedite alla produzione di vaccini. Con i virus il problema è che ancora non si sono scoperti farmaci antivirali ad ampio spettro come invece è successo per gli antibatterici. Per cui, quando si presenta un nuovo ceppo (il virus originale modificato per alcune piccole varianti), siamo praticamente disarmati. Per questo assumono
particolare importanza i vaccini, perché la sola cosa che funziona sono gli anticorpi, siano essi prodotti a seguito di contagio o di vaccino.
I produttori di vaccini
Il termine «vaccino» deve la sua origine a «vacca» perché le prime forme di stimolazione intenzionale di anticorpi si sono realizzate a fine 1700 nei confronti del vaiolo mediante l’inoculazione in soggetti sani di siero proveniente dalle pustole presenti sulle mammelle delle vacche malate. Col tempo la vaccinazione è diventata una pratica abituale nei confronti di numerose malattie, per cui sono tantissime le industrie che si dedicano a questo genere di attività, non solo nel vecchio mondo industrializzato, ma anche in Cina, India, Brasile, Thailandia e molti altri paesi del Sud del mondo, anche se l’Africa si presenta come il continente meno attrezzato. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel 2019 il mercato globale dei vaccini valeva 33 miliardi di dollari, ma rappresentava solo il 2% del mercato farmaceutico complessivo. Inoltre, benché in termini di volumi produttivi i più grandi fossero le società indiane Baharat biotech e Serum institute of India, che assieme contribuivano al 37% dell’intera produzione, in termini di valore la situazione era dominata dalle multinazionali occidentali. In particolare, quattro – Gsk, Merck, Pfizer e Sanofi -, che da sole esprimevano il 90% del valore globale dei vaccini, realizzato per il 68% nelle nazioni più ricche. Ma oggi la situazione sta cambiando perché il Covid ha rimescolato tutte le carte.
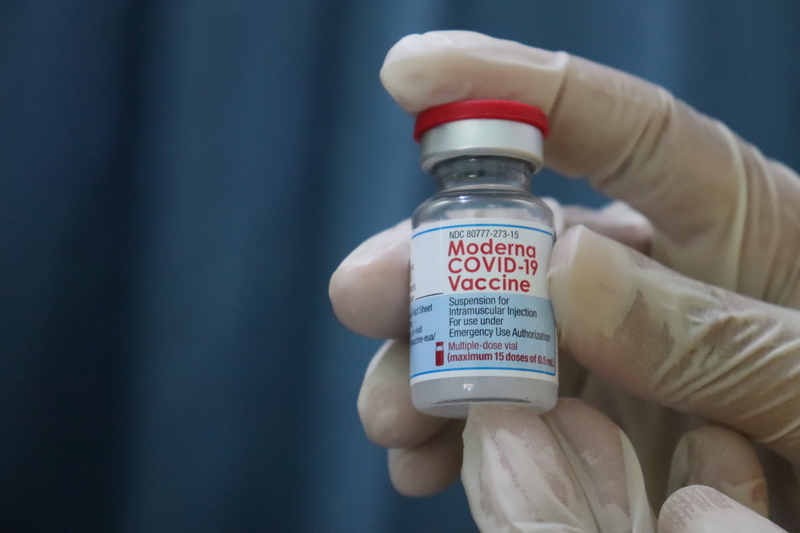
Il sostegno pubblico
Per cominciare si è assistito a un massiccio sostegno finanziario delle imprese farmaceutiche da parte dei governi, anche se va detto che il settore farmaceutico è sempre stato assistito dalla mano pubblica. Ma, in tempi normali, l’aiuto viene dato in forma mascherata. La formula utilizzata, infatti, è quella della collaborazione con le università che passano alle imprese i risultati delle loro ricerche. In altre parole, le università spendono per studiare e ricercare, mentre le imprese godono gratuitamente del loro lavoro con notevole risparmio di spese. Questa formula è così collaudata che è stata la prima soluzione a cui AstraZeneca ha pensato, quando ha deciso di dedicarsi a un vaccino anti Covid (del tipo a vettore virale). Essendo di nazionalità britannica, ha stretto un accordo di collaborazione con l’Università di Oxford che, da oltre un decennio, stava studiando un vaccino contro gli adenovirus presenti negli scimpanzé. L’ipotesi era che, a partire da quegli studi, si potesse ottenere un vaccino contro il Covid, come poi è avvenuto. Il costo sostenuto dall’Università di Oxford per le proprie ricerche non è stato rivelato, ma secondo una ricostruzione effettuata da alcuni accademici, fra cui Samuel Cross e Sarai Keestra, l’esborso complessivo ha superato i 250 milioni di euro, finanziati in gran parte dal governo britannico, dall’Unione europea e da alcune fondazioni private.
L’intervento del governo britannico si è concretizzato in particolare nel 2020, in linea con l’azione di molti altri governi. Non appena hanno capito che la soluzione della pandemia stava nel vaccino, questi hanno cercato di garantirsene l’approvvigionamento tramite contributi alla ricerca e contratti di preacquisto con le case farmaceutiche per una spesa complessiva che la fondazione Kenup ha stimato in 88 miliardi di dollari. Il solo governo degli Stati Uniti ha stanziato 18 miliardi di dollari e ancora non si sa quanti siano stati concessi a fondo perduto e quanti come pagamento anticipato di dosi concordate. L’iniziativa, battezzata Operation warp speed (operazione a tutta velocità), è stata strutturata in modo da poter evitare la trasparenza, ad esempio delegando l’esercito a stipulare i contratti con le case farmaceutiche come se si trattasse di operazioni militari. Tuttavia, nel marzo 2021 il Congresso ha prodotto un documento che rivela le somme elargite alle singole imprese e il corrispondente numero di dosi da consegnare a produzione avviata.
Una rapida realizzazione
I finanziamenti pubblici hanno avuto il loro effetto: nel marzo 2021 erano già disponibili 12 diversi vaccini prodotti non solo in Europa e Stati Uniti, ma anche in Cina, Russia, India, e ora anche a Cuba. Alcuni ottenuti secondo metodiche più tradizionali, altri con tecnologie all’avanguardia, ma tutti accomunati dalla rapidità di realizzazione. Basti dire che, prima del Covid, i tempi medi per la messa a punto di un vaccino variavano da 10 a 15 anni. Il record era stato battuto negli anni Sessanta dal vaccino contro la parotite che aveva richiesto soltanto quattro anni.
Stante la situazione, la rapidità va salutata con favore, anche se qualcuno l’ha pagata e la mente va ai morti per trombosi provocata dal vaccino AstraZeneca. Incidenti che hanno nuociuto gravemente alla reputazione di questo vaccino fino a farlo accantonare definitivamente nei paesi più ricchi. Perfino, il governo della Gran Bretagna, suo paese natio, gli ha girato le spalle preferendo i vaccini di Pfizer e Moderna, tecnologicamente più avanzati, i cosiddetti vaccini mRna.
Lo scandalo profitti
Pur essendo molto diverse fra loro, le due aziende sono i veri vincitori della partita vaccinale, almeno in Occidente.
Pfizer è una grande multinazionale statunitense che, nel 2020, si posizionava all’ottavo posto mondiale, per fatturato, fra le imprese farmaceutiche. Fino al 2020, più che i vaccini, la sua specialità erano i farmaci per malattie rare e oncologiche, ma quando è comparso il Covid, ha incassato quasi 6 miliardi di dollari di contributi pubblici e si è buttato nella ricerca di un vaccino mRna. Mossa vincente.
Nel 2021, Pfizer ha quasi raddoppiato il proprio fatturato rispetto all’anno precedente, un balzo dovuto interamente alla vendita dei vaccini anti Covid la cui quota sul fatturato è passata dal 15% nel 2020 al 50% nel 2021. E i profitti di Pfizer sono più che raddoppiati giungendo a 20 miliardi di dollari. Del resto, a fronte di una ricerca interamente finanziata dalla mano pubblica, i suoi vaccini sono venduti a 19,50 dollari a dose benché Oxfam abbia calcolato che il costo di produzione si fermi a 1,2 dollari a dose. Moderna, anch’essa superfinanziata dalla mano pubblica, fa ancora peggio vendendo lo stesso tipo di vaccino per 25,50 dollari a dose.
Al pari di Pfizer, anche Moderna è statunitense, ma le sue dimensioni sono di gran lunga inferiori. La prima è un gigante, la seconda un nanerottolo. Per giunta più che farmacologica, Moderna è un’industria di tipo biotecnologico. Durante il primo semestre 2020 ha dichiarato introiti uguali a zero, mentre nello stesso periodo del 2021 ha dichiarato un fatturato di 6,2 miliardi di dollari. Praticamente da azienda moribonda è diventata miliardaria, con profitti dichiarati pari a 4,3 miliardi di dollari, un’incidenza del 70%. E quando ha aperto il suo mercato in Europa, ha pensato bene di domiciliarsi in Svizzera in modo da convogliare in un paradiso fiscale tutti gli introiti incassati dalle sue vendite ai governi europei. Così siamo all’assurdo che la collettività spende per la ricerca, le imprese si arricchiscono, poi quelle stesse imprese gabellano la collettività evitando le tasse. Ed hanno pure il permesso di mettere il brevetto sulle scoperte realizzate con i soldi pubblici, arrecando così un danno alla salute pubblica mondiale, perché sono loro a decidere a chi concedere le licenze di produzione e a che prezzo.
I brevetti dei ricchi
Fin dal sorgere della pandemia i paesi del Sud del mondo hanno invocato lo stato di emergenza per chiedere la sospensione dei trattati internazionali a protezione dei brevetti o, per dirla con l’eufemismo usato dai potenti, a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Invano. La lobby delle multinazionali farmaceutiche è così potente da aver ottenuto un «no» compatto da parte di tutti i paesi del Nord, prima fra tutte l’Unione europea. Il risultato è un mondo diviso in tre: i paesi ricchi dotati di vaccini e farmaci all’avanguardia, quelli a ricchezza media con vaccini di qualità più bassa e nessun farmaco antivirale, infine quelli poveri sprovvisti di tutto. Situazione confermata dai tassi di vaccinazione.
Secondo One world data, al 1° dicembre 2021, la percentuale di popolazione che ha avuto almeno una dose di vaccino era del 75% nei paesi a ricchezza elevata, del 44% nei paesi a ricchezza media, del 6% nei paesi a ricchezza bassa.
Eppure, tutti sanno che in un mondo globalizzato come è quello di oggi, non esiste più la possibilità di proteggersi da soli: o ci si salva tutti o non si salva nessuno. Le nuove varianti che continuano a imperversare ne sono una chiara dimostrazione. Ma di fare qualcosa che una volta tanto sia per le persone, anziché per le imprese, questo sistema non vuole proprio saperne. Il massimo che sa fare sono promesse non mantenute.

La delusione Covax
Nell’aprile 2020 sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale della sanità venne istituito il
Covax (Covid-19 vaccines
global access), un organismo che aveva il compito di coordinare gli acquisti dei vaccini a livello mondiale in modo da evitare che i più ricchi facessero la parte del leone lasciando i più poveri a bocca asciutta.
L’organismo doveva anche raccogliere fondi per permettere ai paesi più poveri di poter comprare le dosi necessarie ai loro bisogni.
Sappiamo com’è finita: i paesi ricchi hanno acquistato i loro vaccini tramite contratti diretti con le case farmaceutiche fino ad assorbire il 49% dei quali prodotti dalle imprese occidentali. Più precisamente, nel 2021 Moderna ha venduto ai paesi ricchi il 93,5% delle sue dosi, Pfizer (con BioNTech) il 67%, Johnson & Johnson l’87%, AstraZeneca il 32,5%. Eppure i paesi ricchi ospitano appena il 16% della popolazione mondiale.
In conclusione, all’agosto 2021 le dosi transitate per il Covax, a beneficio di 140 paesi, erano appena 205 milioni su un totale auspicato di due miliardi. Quanto ai fondi per assistere i paesi più poveri, il fabbisogno era stato stimato in 34 miliardi di dollari, ma la cifra realmente raccolta al dicembre 2021 si era fermata a 18 miliardi. Un’altra occasione mancata per avere giustizia e solidarietà.
Francesco Gesualdi




