Diseguaglianza, la sfida che decide il nostro futuro
Il 18 giugno 2018, a tre anni di distanza dalla pubblicazione della Laudato
Si’, circa venti partner, fra cui Caritas Italiana e Focsiv, hanno lanciato la
campagna triennale «Chiudiamo la forbice: dalle diseguaglianze al bene comune,
una sola famiglia umana». Vediamo i numeri delle disparità nel mondo e alcune
iniziative che la campagna ha messo in campo su uno dei tre ambiti: il cibo.
Immaginiamo per un attimo che sul pianeta vivano cento persone e che il presidente della Banca Planetaria chieda loro di portare in banca tutti i soldi che possiedono perché viene emessa una moneta nuova e quelle vecchie non valgono più. In cambio verrà distribuita la nuova moneta che si chiama globone.
La Banca Planetaria convoca i cento abitanti del
pianeta e, cominciando da chi possiede di più, restituisce a ciascuno il suo
con le dovute rivalutazioni.
Per facilità supponiamo che tutti i soldi
raccolti equivalgano a cento globoni.
Arriva il primo signore, solo. Gli danno i suoi
soldi: 33 monete. È molto soddisfatto. Proprio un bell’affare. Nel 1980, quando
era stata fatta un’operazione simile, aveva avuto «solo» 28 monete.
Arrivano poi altre 9 persone. Ricevono 37 monete,
più o meno quattro a testa. Per loro è un colpo, perché nel 1980 ne avevano
ricevute 40, ma visti i tempi che corrono, meglio non lamentarsi, le perdite
sono contenute.
Dei 100 globoni iniziali, ne rimangono 30, ma le
persone da rimborsare sono ancora 90. Quanto riceverà ciascuno? Tutti lo
stesso?
Sono chiamate altre 15 persone: ricevono 20
globoni da dividere fra loro. Mugugnano un po’ perché rispetto al 1980 hanno
perso almeno un globone, o forse due, in favore del primo uomo.
Rimangono ancora 10 monete in tutto per 75
persone. A 25 sono distribuiti equamente 8 globoni, 32 centesimi a testa.
Speravano di prendere un po’ di più, ma possono andarsene contenti perché
almeno non hanno perso molto nel cambio. Metà dei «clienti» è sistemata.
A questo punto, le 50 persone rimanenti devono
spartirsi quel che rimane: due monete. Non due a testa: due in tutto, 4
centesimi ciascuno.
Una storia per capire
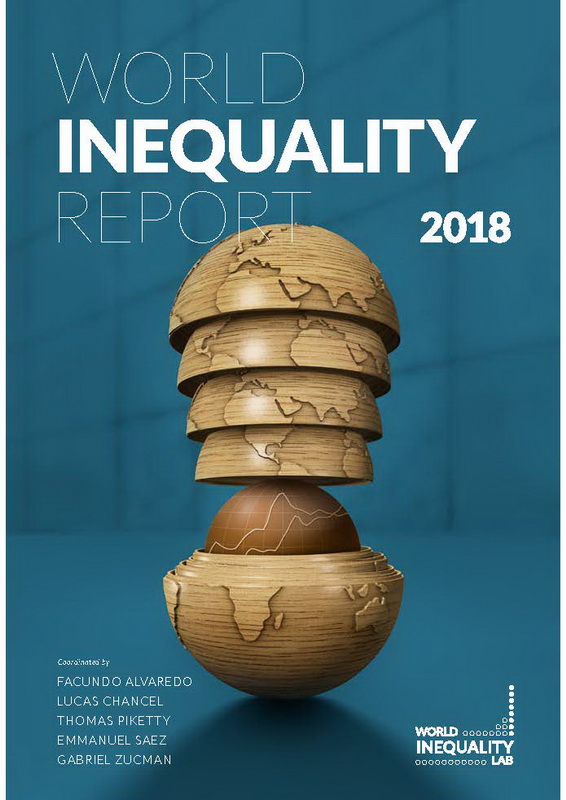
Questa storiella è una semplificazione dei dati riguardanti la distribuzione della ricchezza nel mondo pubblicati nel World Inequality Report (Wir) del 2018. Va detto che queste percentuali devono essere prese cum grano salis, come gli autori stessi tengono a chiarire, perché i dati affidabili sulla ricchezza nel mondo sono meno disponibili di quelli sul reddito, altra misura su cui si basa il rapporto. Inoltre, lo scenario è costruito sui dati dei soli Stati Uniti, Unione europea e Cina.@
Tuttavia, con le dovute cautele, è possibile
sostenere che di questo passo – cioè ai tassi di crescita della diseguaglianza
attuali – nel 2050 l’1% più ricco della popolazione mondiale arriverà a
possedere di più di tutta la classe media mondiale.
Per capire meglio riprendiamo la nostra storiella
e immaginiamo di moltiplicare tutto per dieci: gli abitanti del pianeta sono
mille, non cento, l’uomo con 33 monete diventa 10 uomini con 330 monete, e i 40
(15 + 25) della fascia intermedia con 28 globoni diventano 400 con 280 globoni.
Oggi, per eguagliare la ricchezza dei 400 uomini della fascia intermedia serve
la ricchezza di otto uomini e mezzo dei dieci più ricchi.
Le proiezioni nel rapporto dicono che nel 2050
basterà la ricchezza di uno solo dei dieci super ricchi per eguagliare la
ricchezza dei 400 della classe media mondiale.
Ma di quante persone reali stiamo parlando? I
dieci ricchi con 330 monete (l’1% della popolazione) corrisponono a circa 70
milioni di persone, spiega Lucas Cancel, uno degli autori del Wir 2018, alla
rivista francese Alternatives Economiques, o 40 milioni considerando la
sola popolazione adulta. Il livello di reddito di queste persone è di 330mila
euro all’anno.
La metà più povera della popolazione mondiale, invece (i cinquanta uomini che si dividono due monete nella storiella iniziale) corrispondono a tre miliardi e mezzo di persone e hanno un reddito sotto i 3.200 euro l’anno per ogni adulto@.
Diseguaglianza in crescita

Nel 2016 la quota di reddito nazionale detenuta
dal 10% più ricco della popolazione variava dal 37% in Europa al 61% nel Medio Oriente. Dal 1980
al 2016 – il periodo considerato dal Wir – la diseguaglianza è aumentata un po’
ovunque, ma con tassi molto differenti: mentre in Europa la variazione è stata
di pochi punti percentuali, in Russia è passata da poco più del 20% nel 1980 a
oltre il 40% nel 2016.
Del complessivo aumento del reddito globale nei
36 anni considerati, l’1% più ricco della popolazione mondiale ha «catturato»
circa il 27%. Il 50% più povero ha certamente beneficiato di tassi di crescita
degni di nota, ma la quota di aumento
del reddito «catturato» dalla fascia più povera è stata del 12%, pari cioè a
meno della metà rispetto alla quota dei super ricchi. Chi ha visto la propria
parte restare invariata, se non addirittura erodersi, è ancora una volta la
classe media.
Da qui al 2050, gli scenari riguardanti le
diseguaglianze sono molti. Il migliore è quello che le vede crescere in tutti
paesi ai tassi «contenuti» dell’Europa. Questo porterebbe la quota dei più
ricchi dal 27% al 19% e aumenterebbe dal 12% al 13% la quota goduta dai più
poveri. Viceversa, se il mondo seguisse il trend degli Stati Uniti, la «fetta»
di crescita a beneficio dei 3 miliardi e mezzo di poveri crollerebbe al 6%,
mentre i 70 milioni di persone più ricche otterrebbero un ulteriore aumento di un
punto percentuale.
Chiudiamo la forbice, ora

Chiudiamo la forbice@ è la campagna lanciata il 18 giugno dell’anno scorso da Caritas Italiana, Focsiv e una ventina di altri soggetti, prevalentemente di ambito ecclesiale. L’attenzione per il tema delle diseguaglianze è sintetizzata in una frase chiave contenuta nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium: «L’iniquità è la radice dei mali sociali».
La data del lancio di Chiudiamo la forbice, precisa il comunicato stampa che apre la campagna, corrisponde al terzo anniversario della pubblicazione dell’enciclica Laudato Sì’@.
«Non ci sono due crisi separate, una ambientale e
un’altra sociale», sostiene Francesco nell’enciclica, «bensì una sola e
complessa crisi socioambientale» che richiede un «approccio integrale per
combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso
tempo per prendersi cura della natura».
Di questo approccio integrale vuole farsi
portatrice la campagna, che concentra il proprio lavoro principalmente su tre
ambiti: il cibo, i conflitti e la mobilità umana, da leggere nell’insieme
attraverso due elementi trasversali del contesto: la dimensione ambientale, cioè
la cura della casa comune, e la dimensione finanziaria, in particolare «la
relazione tra debito, crisi finanziarie, diseguaglianze e resilienza rispetto
all’instabilità sociopolitica e allo svilupparsi di conflitti violenti».
A Chiudiamo la forbice sono legati tre concorsi
per la produzione di un video, una foto e un disegno che esprimano il titolo e
il tema della campagna. La scadenza per la presentazione dei lavori è il 30
giugno 2019, mentre la premiazione avverrà il 30 dicembre.
Il cibo, diritto basilare negato

Quello del cibo, dalla produzione al consumo, è un ambito nel quale le diseguaglianze sono di un’evidenza schiacciante. Del cibo sprecato annualmente sul pianeta, pari a 1,3 miliardi di tonnellate, gli abitanti di Europa e Nord America ne buttano fra i 95 e i 115 chili a persona contro i 6-11 chili a testa del resto del mondo. Nel primo caso, le perdite avvengono principalmente al livello del consumo e della vendita al dettaglio. In quest’ultimo ambito, buona parte dello spreco è l’effetto dell’applicazione di norme che danno eccessiva importanza all’aspetto dei prodotti. Nei paesi in via di sviluppo, invece, gli sprechi avvengono soprattutto nella fase successiva al raccolto e in quella di lavorazione, spesso a causa di limiti e inefficienze nelle tecniche di raccolta e nella catena del freddo. Nei paesi a medio reddito, infine, a causare le perdite di cibo sono principalmente la mancanza di coordinamento fra produttori e venditori e la scarsa consapevolezza da parte di produttori, venditori e consumatori sul problema dello spreco e su eventuali modi per riutilizzare il cibo che viene attualmente buttato@.
La campagna cerca di far emergere gli aspetti
disfunzionali in questo settore: «Se il 2017 è l’anno in cui la Fao ha rilevato
per la prima volta da tempo un nuovo aumento delle persone che soffrono la fame
sul pianeta, non cessano di aggravarsi le varie malattie dell’opulenza, come
l’obesità, lo spreco di cibo, la sovra alimentazione, ecc. Sullo sfondo vi sono
fenomeni complessi come la concentrazione del potere economico nelle filiere
della produzione del cibo, o i fenomeni dell’accaparramento della terra».
Fra le iniziative promosse in questo ambito vi è la spesa sospesa, che a Roma ha preso forma il primo fine settimana di ottobre al Villaggio Coldiretti. «Per tutto il weekend della manifestazione i visitatori dei banchi del maximercato degli agricoltori promosso da Coldiretti e Campagna Amica al Circo Massimo hanno avuto la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore dei più bisognosi, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo». Frutta, verdura, formaggi, salumi e altri generi alimentari così raccolti, per un totale di una tonnellata e mezzo, sono stati poi consegnati alla Caritas e alla Comunità di Sant’Egidio, che li hanno utilizzati per rifornire i quattro Empori della Solidarietà promossi dalla Caritas di Roma, che sono «supermercati di medie dimensioni a cui possono accedere gratuitamente persone che si trovano in temporanea difficoltà e che non riescono a sopperire a tutte le loro necessità»@.
Anche a Torino si è svolto a giugno un evento simile ai Giardini Reali superiori. Il bilancio è stato di una tonnellata di cibo raccolta e distribuita alle famiglie bisognose@.
Chiara Giovetti






























