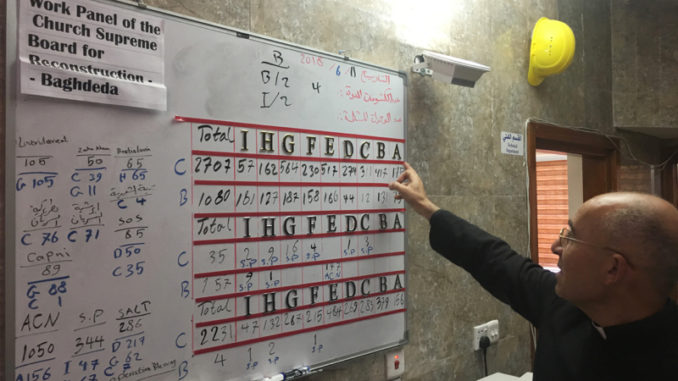Riflessione sulla guerra
Sommario
- Menzogne, attori e comparse delle «nostre» guerre: tutto sarà dimenticato?
- Baghdad, diario di una pacifista
- Le guerre spostano i popoli
Menzogne, attori e comparse delle «nostre» guerre tutto sarà dimenticato?
Sono passati vent’anni dall’invasione degli alleati in Iraq. Una guerra giustificata con una menzogna, e alla quale si opposero milioni di pacifisti in tutto il mondo. Ma a nulla valse. Meccanismi che si sono ripetuti in molte guerre volute dall’Occidente. Mentre i paesi che cercavano una soluzione negoziale (spesso possibile), venivano messi all’angolo.
Venti anni fa, nel mese della guerra, l’offensiva anglo-statunitense «Iraqi Freedom» contro l’Iraq iniziava con una campagna di bombardamenti aerei. Malgrado tutto. Malgrado l’inedito rifiuto popolare espresso nelle piazze e nelle strade di tutto il mondo (il New York Times parlò di «seconda superpotenza mondiale», a indicare la prima manifestazione planetaria contro un conflitto). Malgrado l’opposizione di importanti paesi anche in Occidente e nel mondo arabo. Malgrado, infine, l’evidente falsità del pretesto bellico: il possesso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno. Eppure, il Paese fu bombardato, invaso, occupato. E nessun capo politico militare fu in seguito punito per questo. Meccanismi molto simili (senza però la presenza di milioni di pacifisti nelle strade) si sono verificati nelle altre guerre mosse dall’Occidente e alleati a partire dal 1991. Per un totale (vedi scheda a pag. 41) di 6 milioni di morti. Più la distruzione dei paesi nel mirino, gli spostamenti di popolazioni, il dilagare del terrorismo.
La storia dovrebbe essere maestra. Quali lezioni trarre da quella vicenda?
Di fronte alla guerra in Ucraina e al dibattito sull’invio di armi, una riflessione sulle guerre condotte dall’Occidente (e alleati) può dare spunti? O tutto è già stato dimenticato?
![]()
Ossimori e menzogne nelle guerre di aggressione
Proteggere i civili, evitare genocidi, cancellare i dittatori, sconfiggere il terrorismo, portare la democrazia. E possibilmente avvolgendosi nei panni dell’Onu. Questa narrazione serviva a spacciare per umanitarie e giuste le guerre infinite portate avanti o aiutate dall’Occidente democratico.
Gennaio 1991: contro l’Iraq viene scatenata «Desert Storm» (Tempesta nel deserto), in Italia battezzata «operazione di polizia internazionale» per via dell’articolo 11 della Costituzione. Così, l’Onu sdogana la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti.
Marzo 1999: campagna di attacchi aerei della Nato contro la Jugoslavia, «Allied Force» (Forza alleata); detta anche «operazione umanitaria per fermare la pulizia etnica in Kosovo».
Ottobre 2001: «Enduring Freedom» (Libertà duratura), intervento bellico di Stati Uniti e alleati contro l’Afghanistan.
Marzo 2003: «Iraqi Freedom», «guerra preventiva» degli Usa e alleati (senza autorizzazione Onu) contro l’Iraq.
Marzo 2011: bombardamenti occidentali e petromonarchici sulla Libia, con semiautorizzazione da parte del Consiglio di sicurezza Onu; per alcuni giorni chiamata «Odissey Dawn» (Alba dell’Odissea), diventa «Unified protector» (Protettore unificato) quando coinvolge altri attori dell’Alleanza. Dal 2011, guerra per procura in Siria, con Occidente, monarchie del Golfo e Turchia uniti nell’appoggiare, in molti modi, gruppi armati jihadisti.
Dal 2015, operazione «Decisive Storm» (Tempesta decisiva), condotta contro lo Yemen dall’Arabia Saudita con una coalizione di nove paesi arabi e armi soprattutto occidentali.
Per legittimare operazioni di aggressione di tale portata e renderle «giuste» e «umanitarie» i belligeranti hanno fatto ricorso a menzogne o a notizie non verificate. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 sottolinea, all’articolo 20.1, che qualsiasi propaganda in favore della guerra dovrebbe essere vietata per legge. Ma questo invito ai paesi è rimasto lettera morta. E in guerra, sembra non operare il rasoio di Hitchens: cioè il principio metodologico secondo il quale «ciò che viene affermato senza prove può essere smentito senza prove».
Le tattiche della propaganda in tempo di guerra – fatta di notizie non verificabili, cause occultate, fonti di parte, omissioni, demonizzazione dell’avversario – non sono appannaggio dei soli governi belligeranti e dei media mainstream che li seguono. Vengono usate, e sempre di più, da diversi altri attori. Il caso del 2003 è peculiare perché ben pochi credono alla famosa provetta mostrata dallo statunitense Colin Powell all’Onu come prova della presenza di armi di distruzione di massa in Iraq. Nel libro Guerra all’Iraq, del 2002, William Rivers Pitt intervista l’ispettore dell’Onu Scott Ritter, il quale spiega che «la minaccia dell’Iraq in termini di armi di distruzione di massa è zero». Tutto l’arsenale è stato distrutto sotto il controllo Onu. E il 5 febbraio 2002 il New York Times rivela che la Cia non ha prove che l’Iraq sia impegnato in operazioni terroristiche contro gli Usa ed è convinta che Saddam non abbia fornito armi chimiche o batteriologiche ad al Qaeda.
![]()
Fake news mondiali
Per la precedente operazione contro l’Iraq, nel 1991, un’efficace finzione contribuisce a convincere il Congresso Usa.
Novembre 1990, la giovanissima «infermiera volontaria» Nahyrah riferisce in lacrime al Congresso Usa che a Kuwait City i soldati iracheni occupanti strappano i neonati dalle incubatrici e li gettano per terra. Ci credono – con tutte le conseguenze del caso – i congressisti, i media, l’opinione pubblica, ma anche organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International. A guerra fatta, l’ammissione: non era vero niente. La volontaria risulta essere la figlia dell’ambasciatore kuwaitiano, istruita dall’agenzia di pubbliche relazioni Hill&Knowlton.
Anche nel caso della guerra della Nato contro la Serbia e delle bombe sull’Afghanistan si rivelano determinanti le accuse a senso unico di crimini efferati.
Con le guerre in Libia e Siria, al consolidato corto circuito di attori militari e mediatici (media embedded) si aggiungono, volontariamente o ingenuamente, altri soggetti. Insospettabili e prestigiosi. Organizzazioni umanitarie e per i diritti umani, regionali e internazionali, commissioni e gruppi speciali della stessa Onu, reti sociali, «attivisti» armati e non. E, come ha rilevato Alessandro Marescotti, che nel 1991 fondò Peacelink-Telematica per la pace, lo stesso ruolo di Internet è cambiato: «da attore di controinformazione ad arma di distrazione» (citazione dal documentario Tutto sarà dimenticato?, reperibile su Youtube).
Il fondo viene toccato in Libia, con la rivolta armata del 2011, ben presto appoggiata dalla Nato. L’Italia partecipa a una guerra per il controllo del petrolio e dell’Africa, giustificata con la «responsabilità di proteggere i civili libici dal massacro da parte del dittatore». Piccolo particolare: il massacro («diecimila morti») è inventato sulla base di notizie false, come ben presto accertato. La stessa Onu avalla di fatto un intervento militare senza fare alcuna verifica.
Dopo alcuni mesi, Maximilian Forte, docente di antropologia all’università di Montreal e autore del libro The scourging of Sirte, passa in rassegna le principali fake news della guerra in Libia: bombardamenti aerei contro i manifestanti, Bengasi a rischio genocidio, fosse comuni, mercenari africani, stupri. In realtà, prima delle bombe della Nato, i morti erano stati pochi, e le città ricatturate dal governo non avevano registrato massacri.
La regola della propaganda bellica consistente nel «nascondere le vittime e i crimini fatti dai nostri alleati» opera in pieno anche in Siria, dove dal 2011 il conflitto non è ancora concluso: l’area di Idlib è controllata da forze islamiste derivate da al Qaeda e l’esercito turco e le sue milizie continuano a occupare intere zone. Il coro è così sbilanciato sulle accuse di massacri compiuti dal solo regime di Damasco, che a metterlo in discussione è il sito Syria Truth, gestito da un veemente e storico oppositore di Bashar al-Assad, rifugiato all’estero da decenni, ma sconvolto dalle manipolazioni finalizzate a giustificare l’ingerenza occidentale, turca e delle petromonarchie nel suo paese. Allo stesso tempo, la commissione ad hoc dell’Alto Commissariato Onu per i diritti umani, con base a Ginevra (la Coi, Commissione indipendente sulla Siria), compilava rapporti ascoltando al telefono i resoconti dell’opposizione armata e visionando video nei quali l’attribuzione delle responsabilità era lungi dall’essere chiara.
![]()
Gli schieramenti di guerra dal 1991
Quel che è certo è che l’Italia non si fa mancare nessuna delle guerre fatte sulle teste altrui, a partire dal 1991. L’invasione dell’Iraq nel 2003 è una iniziativa anglo-statunitense, senza l’Onu. I paesi arabi non si oppongono in modo deciso, ma non partecipano con proprie truppe come invece avevano fatto nel 1991. Fra i paesi importanti nella Nato, a opporsi decisamente sono Francia e Germania.
Bush e Blair vanno a caccia di alleati raccogliticci fino in Micronesia. Il 18 marzo 2003, il Dipartimento di stato Usa rende pubblico un elenco di 31 paesi che – sulla carta – partecipano all’autonominata «coalizione dei volenterosi» guidata dagli Stati Uniti: Afghanistan, Albania, Australia, Azerbaigian, Bulgaria, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, El Salvador, Eritrea, Estonia, Etiopia, Georgia, Ungheria, Islanda, Italia, Giappone, Corea del Sud, Lettonia, Lituania, Macedonia, Paesi Bassi, Nicaragua, Filippine, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Uzbekistan.
Il 20 marzo 2003, la Casa Bianca pubblica un elenco con le seguenti aggiunte: Costa Rica, Repubblica Dominicana, Honduras, Kuwait, Isole Marshall, Micronesia, Mongolia, Palau, Portogallo, Ruanda, Singapore, Isole Salomone, Uganda, Panama. Nell’aprile 2003 si aggiungono Angola, Tonga e Ucraina. In tutto 49, Usa compresi.
Nel 1991 – un caso che fa scuola – tutto si è invece giocato, formalmente, all’Onu. «Se avremo successo, le Nazioni Unite ne usciranno rafforzate», disse George Bush nei mesi precedenti l’attacco non chirurgico all’Iraq. Sfacciata la compravendita statunitense del consenso, nei lunghi mesi di preparazione della guerra, per trasformare in una «coalizione dell’intero mondo libero coraggioso» (più la declinante Urss) quella che era invece un’azione bellica necessaria alla continuità di Washington come superpotenza e al controllo Usa sul vitale Medioriente petrolifero.
Nei mesi dell’escalation prima delle bombe, gli Usa si impegnano in un pressing a 360 gradi, in particolare sui membri permanenti e non permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu, ai quali vengono offerte prebende, soprattutto se poveri come Etiopia, Colombia e Zaire.
In Consiglio di sicurezza, al voto clou sull’ultimatum all’Iraq si registrano solo due «no», decisi ma marginali: quelli di Cuba e Yemen. La Cina si astiene (deve legittimarsi a livello internazionale). L’Urss in via di scioglimento non pone il veto (dipende dagli aiuti occidentali). Fino all’inizio della crisi, la Lega araba, su intensa pressione Usa e delle petromonarchie, si divide (cercano di opporsi all’escalation solo Libia, Algeria, Giordania e Yemen), dimostrandosi incapace di proporre una soluzione nonviolenta.
A cavallo del nuovo millennio, all’operazione bellica della Nato in Serbia partecipano 13 paesi membri (Turchia compresa); la Grecia rifiuta. Dopo due anni, attaccano l’Afghanistan sette paesi occidentali più Nuova Zelanda e Australia.
Nel 2011, l’operazione militare Nato-petromonarchica in Libia viene legittimata a livello Onu dalla risoluzione 1.973 in Consiglio di sicurezza, che passa senza veti e con 5 astensioni: Brasile, Cina, Germania, India, Federazione Russa. I bombardamenti non aspettavano altro, e iniziano subito, a cura di 14 Stati occidentali, più Qatar, Turchia, Giordania ed Emirati arabi. Fra le petromonarchie, il Qatar si era guadagnato credibilità presso l’opinione pubblica araba con la sua tivù al-Jazeera, la quale in Iraq nel 2003 aveva mostrato una certa indipendenza dalla posizione Usa-Uk. Nel caso libico il media dell’emirato è, invece, in prima linea nella propaganda pro-intervento.
Nel caso siriano, gli undici paesi autoproclamatisi «Amici della Siria» (cinque occidentali – Usa, Francia, Germania, Regno Unito, Italia – e sei della macroregione intorno alla Siria – Emirati Arabi uniti, Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Egitto, Giordania) sono per diversi anni in prima linea nell’alimentare il conflitto, finanziando apertamente gruppi jihadisti e ostacolando ogni negoziato in sede Onu.
![]()
Paesi non belligeranti e negoziatori boicottati
Le guerre, come la geopolitica, hanno geometrie variabili. Via via, dal 1991, alcuni paesi si sottraggono alle avventure militari avviate dal loro blocco di appartenenza; altri mostrano una vocazione pacifista; altri si espongono in sforzi negoziali. Senza successo, ma onore al merito.
Il 29 novembre 1990, solo Yemen e Cuba in Consiglio di sicurezza (di cui sono membri per caso) votano no alla risoluzione definitiva, la 678 che fissa un ultimatum per il 15 gennaio 1991. Lo Yemen, il paese più povero della regione, ha resistito a ricatti e lusinghe, ma paga la sua indipendenza con la cancellazione di un pacchetto di aiuti occidentali e l’espulsione di centinaia di migliaia di lavoratori dall’Arabia Saudita. L’Urss agonizzante di Mikhail Gorbacev non riesce a porre un risolutivo veto all’ultimatum, ma tenta poi, per mesi, di mediare, inviando come negoziatore Evghenij Primakov, soprattutto nelle capitali arabe e a Baghdad. Era possibile, annoterà poi il negoziatore russo, ottenere un ritiro in dignità dell’Iraq dal Kuwait offrendo a Baghdad un pacchetto di garanzie. Sarebbe stato il modo per affermare il rispetto delle risoluzioni Onu senza la guerra.
Dopo la risoluzione 678 che autorizza l’uso della forza, il Consiglio di sicurezza non si riunisce più. Cercano ancora di negoziare l’Iran, sostenuto dall’Urss, e un gruppo di leader non allineati guidati da India e Nicaragua, insieme a Willy Brandt. Gli Usa rigettano ogni proposta. Il mondo si accoda.
Quanto all’invasione dell’Iraq nel 2003, vede l’opposizione attiva ma inefficace di molti paesi: in Europa Francia, Belgio, Germania. Poi Russia e Cina, Cuba (che mantiene l’ambasciata aperta sotto le bombe), Venezuela, Siria e altri paesi arabi. La Francia di Jacques Chirac si frappone in Consiglio di sicurezza, non accettando alcuna risoluzione contenente un ultimatum.
Invece, nel caso della crisi libica nel 2011, fra i membri eminenti della Nato solo la Germania, membro di turno del Consiglio di sicurezza, non dice sì alla no-fly zone che da lì a poco si trasformerà nella distruzione per via aerea della Libia (la Norvegia, se non altro, si ritira dai bombardamenti su Tripoli dopo pochi mesi). Ma è soprattutto il presidente venezuelano Hugo Chávez, appoggiato da Fidel Castro (che invano chiede alle popolazioni occidentali di sostenerlo), a cercare di coinvolgere diversi Stati in uno sforzo negoziale tempestivo, ben architettato, mai interrotto nelle successive fasi del conflitto. Nell’ambito dell’Alleanza Alba (alleanza bolivariana per i popoli della nostra America, ndr), il Venezuela propone all’Onu la «costituzione di una Commissione internazionale di buona volontà per la ricerca della pace in Libia, mediante la promozione del dialogo fra le parti». La Commissione potrebbe annoverare rappresentanti di Unione africana, Lega araba, Conferenza islamica, Movimento dei non allineati, Unasur e Alba.
Chávez ripete invano il suo appello ai paesi non belligeranti che non possono «stare inerti» e appoggia senza riserve la proposta dell’Unione africana (ma il Sudafrica, unico paese africano che all’epoca è membro non permanente del Consiglio di sicurezza Onu, vota a favore della no-fly zone). Come scriverà anni dopo su Le Monde diplomatique il suo ex segretario Jean Ping, l’Unione africana elabora una road map, adottata il 10 marzo 2011. Ma paesi Nato e monarchie del Golfo ignorano la mossa iniziando i bombardamenti pochi giorni dopo. Nondimeno il 10 aprile, rappresentanti dell’Ua arrivano a Tripoli per incontrare Gheddafi, che accetta la proposta. Ma non la accettano le milizie armate dell’opposizione appoggiate dalla Nato. E la guerra continua fino alla distruzione di Sirte e al linciaggio di Gheddafi.
I popoli, il pacifismo e quel che non si fece
Che fare, si possono chiedere i popoli, quando i governi avviano guerre che sfasciano paesi, ammazzano centinaia di migliaia di civili e militari, fanno milioni di rifugiati e immani distruzioni e non finiscono mai, si trasformano soltanto?
Obiettori delle industrie d’armi e attivisti contro le basi militari spiegano da sempre che il conflitto armato è il naturale sbocco del complesso militar-industriale, al quale occorre opporsi ogni giorno, e non solo a ridosso delle bombe. E poi, dicono in tanti, contro i conflitti per ragioni geostrategiche e per le materie prime, bisogna puntare a un modello economico equo ed ecologico. Certamente, «ci salverà il pilota che non volerà» e «ci salverà il soldato che non sparerà» (citando Girotondo di Fabrizio De André). Ma con gli eserciti professionisti dispiegati dall’Occidente non ci sono chance di diserzioni di massa.
Diverso è il caso nell’attuale guerra russo-ucraina: non per nulla si moltiplicano gli appelli all’obiezione, alla diserzione e all’accoglienza all’estero dei disertori di entrambe le parti.
E le popolazioni? Nel 2003 il popolo della pace fu dovunque, mondiale, visibilissimo, soprattutto nei paesi che andavano a bombardare l’Iraq.
Anche nelle altre avventure militari internazionali, dalla guerra del Golfo di trentadue anni fa in poi, le attività dei pacifisti in dissenso rispetto ai loro governi (e anche nei paesi non belligeranti e contrari) coinvolsero minoranze rilevanti. Ma con limiti invalidanti. Troppo poche le azioni dirette nonviolente contro le basi militari. Inutili le presenze, sotto le bombe, di cittadini dei paesi occidentali e arabi: non erano numericamente tali da poter fungere da deterrente o forza disarmata di interposizione. Non abbastanza forti le proposte di eventuali tribunali internazionali.
Negli ultimi anni, poi, con la guerra Nato alla Libia, e con la guerra per procura in Siria non si è mosso nessuno o quasi. Perfino rispetto alla guerra saudita in Yemen l’indignazione è stata limitata. Per quale motivo nessuna delle grandi organizzazioni della società civile, né i pacifisti, né gli ecologisti, né i progressisti, né i movimenti per un altro mondo ha fatto nulla?
Forse ha giocato la forza del circolo vizioso di attori menzogneri, o forse la disillusione: nel 2003 la seconda superpotenza mondiale (i pacifisti di tutto il mondo, come citato sopra) non aveva fermato Bush e alleati. Il presidente repubblicano statunitense doveva rispondere solo ai neoconservatori, ai potentati economici e al suo elettorato indifferente.
Dunque, non si può fare nulla di efficace per prevenire e fermare le guerre?
Lezioni per l’attualità
La guerra russo-ucraina poteva essere evitata «ma i piani e le azioni per allargare la Nato fino ai confini russi hanno provocato i timori di Mosca», sottolinea l’appello di 15 statunitensi, ex militari, ex diplomatici, esperti di politica estera e sicurezza, promosso dall’Eisenhower Media Network. Un appello a sostituire l’invio delle armi a Kiev con un vero negoziato senza precondizioni. Di che farne una campagna. Paesi terzi, non schierati, come alcuni paesi africani e il Vaticano, tentano la via del negoziato fra Mosca e Kiev. Ma nel contempo, altri alimentano la guerra.
Manca nel mondo un pool negoziale di paesi neutrali o comunque meno allineati e non fautori di guerre negli ultimi decenni. Un gruppo incaricato stabilmente dall’Onu – indipendentemente dai governi del momento – di disinnescare i conflitti prima che scoppino, o di negoziare a danno fatto. Una forza negoziale con la quale i movimenti pacifisti potrebbero agire. In fondo le Nazioni Unite, lo dice la loro Carta, nacquero proprio per questo scopo: «Salvare le future generazioni dal flagello della guerra».
Marinella Correggia

Baghdad, diario di una pacifista
Anno 2003: il racconto dei primi mesi di guerra
L’autrice è stata nell’«Iraq peace team», un Gruppo internazionale di pacifisti che ha cercato di opporsi all’invasione Usa. È entrata in Iraq il 24 marzo dalla Siria e uscita il 3 maggio 2003 dalla Giordania. In queste pagine, ripercorre quei giorni, non senza delusione, e con una certa autocritica.
«‘Ayn ‘insaanyia?» (Dov’è l’umanità?). Era la retorica domanda che gli iracheni ripetevano, in quelle settimane di bombardamenti aerei, apripista per l’occupazione anglo-statunitense dell’Iraq. Per fortuna non chiedevano «ma cosa siete venuti a fare?» a noi dell’Iraq peace team, alcune decine di pacifisti autogestiti di vari paesi arrivati nella capitale irachena poco prima dell’inizio della guerra o poco dopo, come erano arrivati gli «scudi umani» (andati a presidiare infrastrutture civili) e un gruppo di attivisti spagnoli. Ciascuno di noi con le proprie motivazioni. Il tentativo di testimoniare e comunicare al mondo (reso quasi impossibile dall’immediato bombardamento della rete telefonica e dall’assenza di internet salvo tramite l’utilizzo di telefoni satellitari e l’aiuto dei media). L’impegno a cercare prove sui crimini di guerra. Il desiderio di «stare con loro» dissociandoci anche fisicamente dalle malefatte di Usa e governi alleati.
Pagando pochi euro al giorno, dormivamo (più o meno) e mangiavamo all’albergo familiare al-Fanar, sulle sponde del Tigri. Lì vicino, l’hotel dei giornalisti, il Palestine, costoso e pieno di comfort finché – per via delle bombe – non se ne andò la luce e con quella l’acqua ai piani alti. Così alcuni venivano a mendicare all’al-Fanar, dove il tuttofare Mohamed detto «Karaba» (elettricità) riusciva a gestire un approvvigionamento saltuario idrico ed elettrico grazie al generatore.
Quando il letto nelle nostre stanze si scuoteva troppo, come una culla impazzita, scendevamo chi nel rifugio sottoterra chi nell’atrio a tenere compagnia a forza di tè nero a Mohamed e a Cocco, scimmietta portata lì chissà da dove e amica solo sua. Il personale dell’albergo non andava più a casa per non rischiare troppo. Era diventata una famiglia. Abu Ali, cameriere e cuoco, aveva perso il figlio nella guerra con l’Iran. Quando, ben presto, per la vegetariana della situazione erano rimasti solo pane e marmellata di datteri, lui premuroso mi garantiva di soppiatto qualche ortaggio, qualche frutto.
Paura? No. Come in altre (inutili) delegazioni di pace, prima in Afghanistan e in Serbia, e anni dopo in Libia, si sviluppa la fatalistica sensazione che non ti toccherà. Ma c’era il dolore per chi moriva, veniva ferito, perdeva casa e ogni cosa. Civili e militari. Firos, che era stato soldato, ci diceva: «I militari sono nel mirino. Se si salvano è solo per miracolo». Non posso dimenticare l’immagine, in un ospedale di Hilla raggiunto nella seconda metà di aprile, di un soldato ustionato, avvolto completamente nelle bende. «Non sappiamo come chiamare il centro ustioni a Baghdad, i telefoni non funzionano», dicevano sconsolati i medici. Al ritorno nella capitale mi precipitai a segnalare l’urgenza, molto probabilmente senza speranza. Tutto è così in guerra. Appeso a un filo.
«La guerra non ci sarà»
Nessuno dell’Iraq Peace Team si illudeva di poter fermare nemmeno un missile minore. L’interposizione e la deterrenza civile avrebbero richiesto decine di migliaia di persone dal mondo. Tariq, veterinario improvvisatosi tassista, ci aveva comunicato il suo stupore: «Quando alla tivù ho visto, settimane fa, tutte quelle manifestazioni in giro per il mondo, anche nei vostri paesi, mi sono detto no, la guerra non ci sarà, i governanti potrebbero temere per le prossime elezioni. Invece a quanto pare non vi hanno dato retta». I governi sanno che la maggioranza dei cittadini non nega il proprio voto a chi ha deciso di fare le guerre, finché sono fatte a casa di altri popoli.
Allora, cosa riuscivamo a fare? Andavamo a vedere i feriti negli ospedali e i bambini nell’orfanotrofio, custoditi dal personale che non andava più a casa e nutriti dalle persone del quartiere. Parlavamo con gli iracheni, tanto. Cercavamo di capire se fosse possibile mettere insieme una conta delle vittime (almeno quelle civili) per future denunce internazionali. Ci recavamo, su segnalazione della Mezzaluna rossa, a vedere i crateri delle bombe finite per errore (ma finite comune) sui mercati o sulle case civili. Cercavamo di portare ai media del vicino mega-hotel appelli inutili o segnalazioni che credevamo d’impatto; come questa: «A Hilla sotto le bombe un uomo ha perso moglie e tutti i sei figli». A volte, con un altro gruppo, il Christian peace team, passavamo la notte nella capannetta dell’impianto idrico dell’ospedale al Mansour, dove l’ingegnere Leyla e il suo personale temevano il peggio in caso di bombardamento.
Leggevamo l’Iraq Daily, pochi fogli miracolosi. Un giorno risultò stampato alla rovescia, stile Leonardo da Vinci. Vi si dava conto di notizie tremende, i civili colpiti da una qunbula (bomba), da un sarukh (missile), morti in una anfijor (esplosione). Lo stesso termine usato dagli sminatori afghani. Ma il Daily dava risalto anche a surreali news incoraggianti: un agricoltore che era riuscito ad abbattere un elicottero yankee nel Sud, la tempesta di sabbia rallentava – benedetta – le operazioni aeree dei nemici. Un giorno, era il 5 aprile, accorremmo in strada al suono di clacson e di un carosello di auto della polizia o simili, con le bandiere irachene, a festeggiare una (ipotetica) manovra militare riuscita da parte degli iracheni. Sì, per i pacifisti l’asimmetria di potenza e di colpe fra i contendenti era tale che parteggiare per gli aggrediti era davvero normale. Un conforto, ma di breve durata.
Confortante anche il caffè fatto e servito dal viceambasciatore di Cuba, una delle pochissime ambasciate rimaste aperte sotto le bombe (naturalmente quella italiana era chiusissima, perché rischiare?). Diceva l’ambasciatore Ernesto Gomez Abascal, con il suo berrettino, a me e a Pietro Gigli (fotogiornalista, ma in Iraq in veste di operatore umanitario, autore di alcune delle foto di questo dossier): «Andremo via se e quando arriveranno i carri armati yankee».
E il momento arrivò. L’8 aprile, Talib disse a noi increduli: «Sono qui vicino». Guardandoci negli occhi, capì che doveva ripetere: «Vi dico che sono qui, a due passi». Gli scorpioni del deserto, i carri armati. Li vedemmo, eccoli. Tutto precipitava. Intorno a noi gli iracheni sembravano essere invecchiati in un giorno. I funzionari del governo sparirono per non essere arrestati dai militari invasori. Il viceambasciatore cubano ci offrì l’ultimo caffè, stavano partendo.

Messaggio in una bottiglia
Intanto civili e militari, ci veniva riferito, morivano come mosche nelle zone periferiche dove gli scontri di terra erano più intensi; qualcuno era invece riuscito a portare in ospedale la giovane e bella Dina Sahran, senza più una gamba quando la incontrammo nel letto, sguardo vuoto. Pensai allora di lanciare un appello approfittando dell’indignazione causata nei giornalisti internazionali dall’attacco al loro hotel Palestine da parte di un carro armato (prima di sapere dei morti, vedemmo il fuoco che usciva da quella finestra a un piano alto). Scritto a mano (non c’era modo di stampare alcunché), il povero testo recitava più o meno: «Noi pacifisti assistiamo alle distruzioni e alle morti provocate da una guerra immorale. Chiediamo a popoli e governi del mondo di fare ogni pressione su Usa e alleati». Per un disguido nella comunicazione con due scudi umani che avevano contatti precisi con i media, il messaggio non arrivò. Un altro fallimento. Essere là e non riuscire a lanciare nemmeno un messaggio in bottiglia contro la propaganda. La stessa che, davanti al fatto altamente simbolico dell’abbattimento della statua di Saddam, la spacciò per un segno di giubilo da parte della popolazione irachena. Falso: c’eravamo. La piazza Firdaus era vicina al nostro hotel e vedemmo: erano pochi a manovrare intorno alla statua; e determinante fu un marine agilmente arrampicato.
Arrivano i giornalisti embedded
Comunque, lo scambio con i media occidentali, quasi inesistente nelle settimane dei bombardamenti, diventò imbarazzante quando, al seguito dei carri armati, arrivarono i giornalisti embedded. Si impadronirono del piccolo al-Fanar (dove comunque pagavano per la stanza molto più di noi), sapevano fare fotoshop, avevano il satellitare thuraya, andavano in giro a caccia di news d’effetto ma non scomode. «Cos’è successo al manicomio?». Oppure: «Dove possiamo trovare bambini poverissimi, tipo un orfanotrofio?». Alla nostra offerta: «Sì, glielo possiamo indicare, ma lei deve dire che i lavoratori sono rimasti in servizio sempre, che la gente portava aiuti, e che embargo e bombe hanno immiserito questo paese», il fotoreporter canadese rispose che non poteva fare «politica pacifista».
Una volta ci fecero vergognare perché, mentre eravamo andati in un ospedale a donare il sangue (e avremmo dovuto sapere che era inutile, non avrebbero potuto usarlo senza avere la certezza del nostro stato di salute), arrivarono due cineoperatori giapponesi e ci ripresero. Il volto del medico si fece duro; di certo pensò che stavamo tutti prendendo in giro il suo popolo. Gli stessi media diedero molto risalto all’evacuazione in Kuwait del piccolo Ali Ismail, della sua famiglia unico sopravvissuto (ma non le sue braccia, amputate). In precedenza, lo avevo cercato e trovato all’ospedale al Kindi. Lo stesso nel quale un medico barbuto mi diede la prima avvisaglia – che allora mi parve farneticante – della futura rivolta contro gli occupanti statunitensi: «Li saboteremo, renderemo loro la vita impossibile».
La Baghdad a ferro e fuoco sorvolata da rumorosi elicotteri Apache, con il rumore delle ambulanze superstiti, i muri pieni di rettangoli neri di stoffa con le scritte bianche a ricordare i morti, entrò nel caos dei saccheggi. Vedemmo quelli di negozi e magazzini, ci sfuggì quello del museo archeologico, ma perfino gli ospedali venivano depredati, alcuni dati alle fiamme. Tutti raccontavano: «È stato derubato e i marines lì vicino non facevano nulla, dicevano di non avere abbastanza personale, eppure sulla strada verso il Nord c’è la coda di carri armati!» (pensai anche allo spreco immane di combustibili fossili, prima per gli aerei, ora per i mezzi a terra); «Sono i kuwaitiani a vendicarsi portandoci via i nostri tesori antichi»; «Distruzioni e incendi dappertutto»; «Alcuni ospedali sono presidiati da civili per evitare il peggio».
Del resto, anche negli anni dell’embargo, stranieri presenti in Iraq a vario titolo «arrotondavano» vendendo tappeti antichi e vecchi argenti che gli iracheni ormai in miseria quasi regalavano.

«Siamo qui per la democrazia»
Un cavallo che si agitava a terra, non soccorso da nessuno e nemmeno dal tassista che non volle fermarsi, mi ispirò l’idea di andare a capire che cosa accadesse allo zoo. Si era sparsa la voce orrenda che a leoni e altri grandi carnivori erano stati dati in pasto asinelli vivi. Però, impossibile avvicinarsi. I soldati stranieri bloccavano il passo. Allo zoo come altrove. Con loro si cercava di comunicare (seppure in modo secco e ostile), per comprendere motivazioni e informazioni. Limitatissimo il loro repertorio di risposte: «Siamo qui per la democrazia»; «Portiamo la libertà». Qualcuno però a domanda rispondeva che sì, si era arruolato per poter studiare gratis nelle costosissime università degli Usa.
Il 15 aprile, la pacifista statunitense Cinthya Banes era fra i pochi rimasti (gli altri già andati via, arresi, per manifesta inutilità). Prendendo a prestito l’email da un giornalista, si mise a mandare messaggi a diverse personalità nel suo paese denunciando i crimini dell’invasione, saccheggi compresi. Poi, dopo la lettura indignata di uno dei volantini che gli occupanti distribuivano in inglese e arabo per l’edificazione dei cittadini di Baghdad, decidemmo una manifestazione, con cartelli: uno chiedeva l’impossibile (Stop occupation), l’altro evocava le responsabilità disattese della potenza occupante, sulla base della Convenzione di Ginevra. L’idea era di piazzarci davanti a un carro armato e attirare l’attenzione di qualche media. Un flash mob ante litteram. Entrate come clandestine nello spazio esterno dell’hotel Palestine, i marines ci lasciarono stare per un po’, poi, «adesso via, sennò vi cacciamo in malo modo».
A Baghdad resistemmo ancora qualche settimana, volevamo raccogliere prove sulle vittime civili. Una sera di fine aprile Omar, ex operaio in una industria chiusa, un fratello soldato morto poche settimane prima a Bassora, ci raccattò e ci accompagnò all’al-Fanar: «Non è più tempo di girare da sole. È il caos. L’Iraq è come questa polvere. Facciamo solo attenzione quando ci avviciniamo ai reticolati, nel buio se gli americani ci prendono per fedayin ci sparano subito».
Fedayin? Combattente. Ce ne sarebbero stati molti, nei mesi e anni successivi. In una guerra infinita.
Marinella Correggia
tratto da «Si ferma una bomba in volo?»,
Terre di mezzo edizioni, Milano 2003, Premio Pieve «Diario del presente»
![]()
Le guerre spostano i popoli
Gli sfollati e profughi a causa dei conflitti
Incontri di donne e uomini scappati dalle guerre. Profughi in fuga, da Iraq, Siria, Libia, Kosovo. Sono milioni, destinati a passare la vita tra un campo di sfollati e un altro. Anche loro vittime, spesso dimenticate, delle guerre causate dall’Occidente. Ecco alcune storie, emblematiche, e quanto mai attuali.
La sera, nel quartiere di Jaramana, gli iracheni si ritrovavano a giocare a scacchi e bere tè sotto una grande tenda. Jaramana è a Damasco, in Siria. Era il maggio 2013. Dopo l’invasione «Iraqi Freedom» guidata da Bush e Blair nel 2003, moltissimi abitanti dell’Iraq avevano lasciato il paese per sfuggire al caos dell’occupazione e al conflitto settario. Oltre un milione di loro aveva trovato ospitalità nella capitale siriana, all’epoca un approdo tranquillo. Permessi di soggiorno rinnovabili anche a chi non aveva uno status di rifugiato vero e proprio. Costo della vita basso (allora). Aiuti pubblici e internazionali (allora). La stessa lingua e in parte le stesse tradizioni. La vicinanza con la terra d’origine.
Ma nel 2011 è iniziata la guerra anche in Siria. Incredulo per la sua sfortuna, Saad, che aveva lasciato anni prima il quartiere Karrada di Baghdad, sotto la tenda degli scacchi ci diceva: «Temiamo un intervento armato esterno anche qui, ad appoggiare i gruppi di terroristi come quelli che ci hanno fatti partire dall’Iraq». Quanto a Majid, arrivato a Damasco nel 2007 con moglie e due figli (altri tre erano stati uccisi, uno durante un rapimento, due gemelle in un’esplosione), ribadiva: «Siamo venuti qua per il pericolo di attentati, le violenze settarie, i rapimenti. Adesso molti iracheni stanno cercando di ripartire. Ma per dove?».
Iracheni erranti
A partire dal 2014, un milione e 800mila persone hanno lasciato le loro case in Iraq e in Siria di fronte all’avanzata del cosiddetto Stato islamico (Isis, o Daesh in arabo). «Fa un caldo infernale sotto queste tende», diceva a un giornalista una donna sfollata, nell’estate torrida del 2015. A Mosul (Iraq) nel luglio 2014, Abu Bakr al Baghdadi annunciò l’instaurazione del califfato: lo Stato islamico era entrato in città.
E nel 2023, dove sono gli iracheni che erano emigrati in Siria, adesso che la situazione economica difficilissima è peggiorata a causa del terremoto di febbraio scorso, sale sulle ferite di tanti anni di conflitto? «Una parte è tornata a casa, altri sono rimasti qui», risponde Salam, giornalista siriano rimasto a Damasco, un caso quasi raro: la Siria, per una guerra fomentata da paesi Nato, petromonarchie e Turchia, conta dal 2011 oltre 6,8 milioni di sfollati interni su una popolazione di 21 milioni, e oltre cinque milioni all’estero – secondo l’Alto commissariato Onu per i rifugiati.
Iracheni erranti, come Elias, yazida, che non vedendo futuro nel suo Iraq, nel 2010 era partito attraverso Turchia e Grecia con il saggio figlio dodicenne, per raggiungere parenti in Germania e poi chiamare il resto della famiglia. Incagliatosi in Italia per questioni burocratiche, alla fine, esasperato, aveva chiesto e ottenuto il rimpatrio. Nel 2013 scriveva, dalle sue terre: «Sono contento, un po’ contento e un po’ triste, forte e debole, ma ho grandi speranze. Auguri di pace al pianeta». Ma ecco che nel 2014 l’Isis, infernale frutto delle guerre, ha spazzato via la regione degli «infedelissimi» yazidi. Un olocausto. Elias si ritrova in un campo di sfollati. Poi abbiamo perso le sue tracce.
![]()
Libia 2011: fuga dalle bombe Nato e dagli integralisti
Fino al 2011 lavoravano nel paese petroliero nordafricano oltre due milioni di stranieri, regolari o irregolari, fra nordafricani (in primis egiziani), africani subsahariani e asiatici (70-80mila dal solo Bangladesh).
Con le bombe della Nato e la concomitante «caccia al nero» da parte di gruppi armati integralisti, ai quali l’Alleanza atlantica ha fatto da forza aerea, hanno lasciato la Libia 800mila lavoratori migranti. Altri se ne sono andati dopo la caduta del governo di Tripoli (settembre) facendosi rimpatriare dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).
Mohamed, del Niger, aveva resistito nella capitale malgrado la chiusura della ditta per la quale lavorava. Nell’agosto 2011, preoccupato, ci diceva: «So che questa guerra è una tragedia. Se non si ferma farà tanti danni anche nel nostro Sahel. Quanti ne ha già fatti, con il rientro in patria di quasi tutti i lavoratori stranieri». È tornato ad Agadez (Niger). Ha provato a coltivare arachidi. Magrissimi introiti. Poi è stato assunto in un hotel a Niamey.
Dove sei andato, insegnante del Darfur che dopo tanti anni a Tripoli, nel maggio 2011 te ne stavi buttato con tutti gli altri sotto il sole al confine tunisino, a Ras Jedir, aspettando non si sa che?
Dove sei finito, Johnson del Ghana, già muratore in Libia, poi ferito durante la guerra, e nel 2012, arrivato da mesi in Italia con un barcone, per poi ritrovarti a vagare con la tua stampella intorno alla stazione Termini a Roma, con continui sfratti dai centri di accoglienza e un asilo umanitario traballante?
E dove sei tu, Abu, che fino a poco prima del crollo di Tripoli facevi il custode e giardiniere in una villa nel quartiere Tajoura? Fuori dal tuo bugigattolo pulito offristi cerimonioso alla pacifista, inutilmente presente da quelle parti, una cena a base di miglio e di un’erba del Niger che compravi al mercato. Ammiravi Thomas Sankara (un mot de passe per tanti saheliani) e anche altri eroi africani. Era stato surreale rievocarli in quel tardo pomeriggio, sotto le bombe.
![]()
Mortali effetti collaterali nel Sahel
I lavoratori tornati nei loro paesi dell’Africa subsahariana sono ben presto andati incontro a un’altra guerra, quella dei jihadisti, con il suo strascico di massacri e spostamenti di popolazioni. Questo effetto collaterale, per l’intero Sahel e non solo, della crescita dei gruppi estremisti in Libia a partire dal 2011, veniva sottolineato già nel 2013 da un negletto studio per l’Europarlamento. In esso si faceva notare come molte delle armi fornite dalle petromonarchie ai ribelli in Libia fossero finite nelle mani di gruppi terroristici sotto il deserto.
Stragi di civili e di soldati, spostamenti di centinaia di migliaia di persone. Così è andato avanti, dunque, dagli inizi del 2012 il terrorismo nella fascia del Sahel, a iniziare dal Mali, poi Niger e dal 2016 in Burkina Faso.
Tawergha, deportazione del XXI secolo
Per fuggire dalla guerra e dall’avanzata delle milizie, anche tanti libici nel 2011 si sono riversati in Egitto o in Tunisia, o in altre aree del paese bombardato. Ma i circa 40mila residenti della città di Tawergha, cittadini libici di pelle nera discendenti degli schiavi africani, non sono partiti volontariamente: sono stati cacciati dalle milizie armate della vicina città di Misurata (cfr. MC giugno 2021). Tawergha è stata distrutta e saccheggiata, svuotata dei suoi abitanti accusati di essere sostenitori di Gheddafi. Il razzismo ha avuto un grande peso. Migliaia di famiglie di Tawergha sono state costrette per anni a vivere in accampamenti, ricoveri di fortuna, centri pubblici, o in aree del paese non controllate dalle milizie più estremiste. Nel 2018 gli accordi di riconciliazione conclusi sotto l’egida Onu avrebbero dovuto spianare la strada al ritorno dei tawerghesi, ma la distruzione massiccia e deliberata della città e delle sue infrastrutture e un senso di insicurezza pervasivo hanno a lungo impedito il loro ritorno in massa. Solo negli ultimi tempi il 45% della popolazione è potuta tornare anche grazie ai servizi di base ripristinati.
Migrazioni o addirittura espulsioni di massa hanno modellato anche le altre guerre calde post-guerra fredda, a partire dalla «Tempesta nel Golfo» nel 1991. Intanto, l’Arabia Saudita espulse circa 800mila yemeniti, punizione collettiva perché il loro governo – membro di turno del Consiglio di sicurezza Onu – non aveva votato a favore dell’ultimatum (risoluzione 678), tappa necessaria per timbrare come «guerra giusta dell’Onu» quell’avventura senza ritorno (per usare le parole di Giovanni Paolo II).
E abbandonarono con ogni mezzo l’Iraq, alla vigilia o dopo le bombe, circa un milione di lavoratori stranieri (bengalesi, egiziani, yemeniti, filippini, indiani, pachistani…). Folle enormi accampate in tendopoli alla periferia di Baghdad e poi al confine iracheno-giordano, cercando un modo di fuggire. Eppure, in un libro curato da giornalisti italiani, la foto di una lunga colonna di persone del subcontinente indiano in attesa di partire, veniva spacciata per «curdi in fuga da Saddam».
Inoltre, 300mila lavoratori palestinesi furono espulsi per vendetta dal Kuwait «liberato» e da altre petromonarchie, o lasciarono l’Iraq, dove rimasero ben pochi stranieri. Come Fouad, marocchino di Fez, cameriere del ristorante Shatt el Arab di Bassora, un tempo frequentato dai ricchi del Golfo. Rimasto nella città durante le due guerre, prima quella con l’Iran poi la Tempesta nel deserto del 1991, andò via alla fine degli anni 1990, per la miseria dell’embargo, non vedendo niente all’orizzonte, con uno stipendio diventato da fame.
Le guerre spostano popoli. Spesso solo nei paesi confinanti.
Tornando agli yemeniti: a partire dal 26 marzo 2015, con i bombardamenti sul paese da parte di una coalizione di monarchie arabe guidate dall’Arabia Saudita e con l’appoggio tecnologico degli Usa, oltre un milione di abitanti hanno dovuto spostarsi di area in area.
Surreale poi, che negli stessi anni, dal Corno d’Africa arrivassero ancora in Yemen via mare parecchi profughi: la loro destinazione sperata, nella penisola arabica, erano i ricchi paesi del Golfo. Molto difficile arrivarci, però, in quei viaggi degni della canzone Samarcanda di Roberto Vecchioni.
![]()
Vesna, la casa in mezzo alla strada
Nel 1999, l’«Operation Allied Force», le bombe Nato su Serbia e Kosovo, provocò – invece di prevenire o arrestare – l’esodo di massa di centinaia di migliaia di kosovari. Dopo la vittoria della Nato, furono i serbi a fuggire a decine di migliaia dal Kosovo «liberato». A Belgrado si incontravano in quei mesi storie stralunate. Come quella di Vesna, suo marito Neboish e il loro figlio Stephan di sette anni. Sfollati nella capitale serba anni prima, da Sarajevo (Bosnia). Abitavano da anni in una stanza d’hotel nel quartiere Zemun. Profughi di guerra catapultati sotto le bombe. Vesna rifletteva sulla guerra della Nato: «Già prima vivevamo giorno per giorno. Adesso è ora per ora. Siamo sfortunati. Forse abbiamo costruito la nostra casa in mezzo alla strada, così si dice da noi. Ma quasi sette settimane di bombe sono tante, non lo auguro a nessuno. Il 5 aprile hanno colpito a 100 metri. Il problema era antico, in Kosovo. C’erano conflitti, certo. Ma l’intervento militare porta non solo altri morti, altri senzatetto, porta anche odio».
Asinelli afghani in aiuto ai fuggitivi
Nel 2001, con l’infinita «guerra al terrore» avviata dagli anglo-statunitensi, altre centinaia di migliaia di afghani ammassavano l’indispensabile sui loro asinelli e prendevano i sentieri e le strade verso il Pakistan o l’Iran. Aggiungendosi ai milioni che avevano lasciato il paese nei precedenti decenni bellici: da quando nel 1979 Usa e petromonarchie, con il sostegno determinante dei servizi segreti pachistani, avevano stretto il patto del diavolo con integralisti provenienti da vari paesi, allo scopo di rovesciare il regime afghano dell’epoca.
Marinella Correggia
![]()
Hanno firmato il dossier:
- Marinella Correggia
È autrice e militante eco-pacifista. Ha scritto saggi e manuali fra i quali: La rivoluzione dei dettagli; Diventare come balsami; Si ferma una bomba in volo?; L’Alba dell’avvenire; El presidente de la paz; Alleanza per il clima; Cambieresti?. Ha sceneggiato documentari fra i quali: Le mani del futuro; Crocevia kirghiso e Tutto sarà dimenticato? . Ha scritto molti dossier nel campo eco-sociale-internazionale. Collabora con diversi media italiani ed esteri. Da decenni è attivista contro le guerre di aggressione. Come volontaria ha partecipato, e partecipa, a campagne e progetti nel campo dell’alternativa ecologica, dei rapporti Nord-Sud, del rispetto attivo dei viventi. - a cura di Marco Bello, giornalista, direttore editoriale MC.
- Si ringrazia la Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus per avere messo a disposizione di MC alcune foto di Pietro Gigli dal suo archivio.