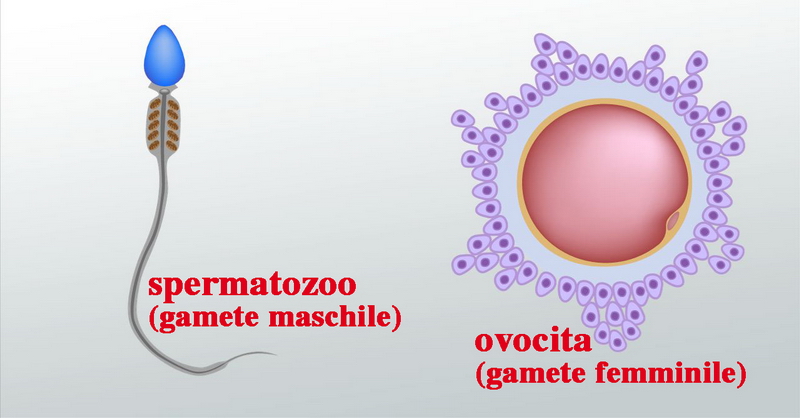Vento antieuropeista?
Un’altra Europa è possibile
Per poter proseguire il suo cammino, l’Europa deve cambiare. Smettendo di proteggere gli interessi privati e la speculazione per porsi al servizio delle persone e del bene comune.
Testo di Francesco Gesualdi
Un vento antieuropeista soffia per l’Europa, dal Danubio all’Atlantico, dal Mediterraneo al Polo Nord. I partiti nazionalisti l’hanno intercettato e lo amplificano in funzione anti straniero, convogliando le ansie e le paure provocate dall’iniquità. Il fondamento ideologico di questi movimenti è l’identità nazionale, in nome della quale viene fatto accettare ai cittadini qualsiasi abuso, ingiustizia, privazione di libertà.
L’immigrazione e l’appartenenza all’Ue dunque sono le circostanze utilizzate dai nazionalisti per fomentare lo spirito xenofobo.
Gli immigrati vengono strumentalizzati dipingendoli come coloro che ci rubano i posti di lavoro e si appropriano indebitamente del nostro stato sociale.
L’Europa viene strumentalizzata dipingendola come una camicia di forza che vuole limitare la nostra sovranità. Ma colpevolizzare l’Europa perché limita la sovranità degli stati aderenti è come colpevolizzare il cane perché abbaia di notte quando vede un pericolo.
Perché i nazionalisti hanno successo
Il compito del cane è quello di fare la guardia. Allo stesso modo, il compito degli organismi sovranazionali è quello scrivere regole che condizionino la sovranità degli stati in nome di un interesse comune. Del resto agli stati rimane sempre la libertà di decidere se aderirvi o rimanerne fuori.
I nazionalisti si oppongono agli organismi sovranazionali per principio, tutti gli altri decidono se aderirvi o meno in base agli obiettivi che l’organismo si prefigge e ai principi che lo animano. Da questo punto di vista, anche i non nazionalisti hanno la necessità di ripensare l’Europa. Se non lo faranno loro, la consegneranno definitivamente nelle mani dei nazionalisti, i quali non la elimineranno, ma la trasformeranno in una nuova entità di cui è difficile prevedere la connotazione economica, ma che di certo avrà le sembianze di una fortezza con i confini ben difesi.
Verosimilmente il nuovo patto europeo a quel punto potrebbe fondarsi su due obiettivi: il mantenimento di un mercato comune interno e la chiusura militarizzata dei confini esterni. Il primo per compiacere le imprese, il secondo per le frustrazioni dei cittadini.
![]()
Europa, da madre a matrigna
Oggi i nazionalisti hanno buon gioco ad alimentare lo spirito anti europeo, perché l’Europa è macchiata da un peccato originale che la fa essere più matrigna che madre. Stiamo parlando della scelta mercantilista: finché ha avuto come applicazione pratica la creazione di un mercato comune, non ha provocato molti contraccolpi, ma quando si è realizzata nella moneta unica, ha orientato la predilezione dei governanti europei verso i forti e gli interessi privati, in spregio a quelli comuni.
L’Europa, ignorando che l’euro, senza meccanismi di compensazione, poteva trasformarsi in uno tzunami per i paesi e le imprese più deboli, e ignorando che chi gestisce la moneta, di fatto, gestisce il potere, si è dotata di un’architettura monetaria che favorisce le imprese ad alta capacità concorrenziale contro quelle meno competitive e le banche contro i governi.
Se esaminiamo le statistiche commerciali stilate dopo l’introduzione dell’euro, notiamo che Olanda, Belgio e Germania hanno avuto un costante ed elevato saldo commerciale positivo nei confronti degli altri paesi dell’Unione europea. Al contrario Francia, Austria, Portogallo, Grecia hanno avuto un costante saldo negativo. Quanto all’Italia, notiamo un andamento altalenante: in pareggio fino al 2009, poi negativo fino al 2012, infine di nuovo positivo ai giorni nostri. È proprio durante gli anni della crisi – quando il Pil e le esportazioni scendevano e la disoccupazione saliva al 13% -, che anche in Italia si è cominciato ad avere dubbi sulla convenienza a rimanere nell’euro. Qualcuno ha iniziato a proporre addirittura di uscirne per rimettersi in piedi. Quest’idea poggia sulla convinzione che l’Italia vada male perché non è abbastanza competitiva rispetto agli altri paesi, sia quelli interni che esterni all’Unione europea, e che le servirebbe una propria moneta da svalutare, cosa che l’appartenenza all’euro però non permette. Quest’analisi, per la verità, è condivisa anche dal pensiero dominante, il quale però individua nel modello tedesco la strada da seguire per tornare a correre: la Germania, infatti, dicono i suoi estimatori, è in testa alle esportazioni europee perché ha impegnato risorse importanti in investimenti tecnologici che hanno aumentato la produttività e la qualità dei prodotti, e anche perché ha saputo varare riforme occupazionali, salariali, fiscali che hanno ridotto i costi delle aziende. Detto fatto: in tutta Europa si è puntato a ridurre il costo del lavoro tramite l’esasperazione del precariato, il ridimensionamento del sindacato, la riduzione salariale e dei contributi sociali. Una strada, però, che da una parte approfondisce il divario fra profitti e salari, portando all’aumento dell’iniquità, dall’altra crea le premesse di una futura instabilità. Meno soldi in tasca alle famiglie, infatti, significano meno consumi e quindi rallentamento della produzione, con nuove possibilità di crisi economica.
Ma allora perché tutti seguono questa strada? I fautori dell’uscita dall’euro sostengono che ci sia una sola ragione: perché l’unica alternativa sarebbe quella della svalutazione, cosa impossibile a causa della moneta unica. Di qui la proposta di tornare a una moneta propria che ci consenta di recuperare competitività non attraverso la svalutazione salariale bensì tramite quella valutaria.
Da quando l’Italia è tornata a crescere, la disoccupazione si è ridotta e il saldo commerciale con l’estero è tornato di segno positivo, il dibattito attorno all’uscita dall’euro si è smorzato. Ma altre ragioni, dalle conseguenze sociali ancor più gravi, ci impongono di mantenere acceso il dibattito sull’euro, non tanto per stabilire se mantenerlo o lasciarlo, ma per discutere come governarlo.
Nella sua impostazione attuale, l’euro è una moneta a pagamento, affidata al sistema bancario privato. Un’impostazione ultraliberista che nega sovranità alla sfera pubblica in favore dei mercati. Essa va messa in discussione non per spirito nazionalista, ma per una questione di democrazia e giustizia sociale.
Prima l’interesse dei creditori
Ce ne siamo accorti quando l’attenzione dei mercati, dopo avere devastato banche e imprese, si è concentrata sui debiti pubblici, ultimi ambiti rimasti da saccheggiare. La speculazione ha affondato i suoi denti nei polpacci dei paesi più deboli e non ha mollato la presa finché i governi non hanno adottato politiche di finanza pubblica che mettessero l’interesse dei creditori prima di quello dei cittadini.
Nessuno condanna la speculazione, neanche le istituzioni europee che appaiono come amministratori di un condominio i cui condomini, al di là delle scale e dell’ingresso, non condividono neppure il buongiorno. Per le regole di Maastricht, del resto, ogni paese è solo di fronte ai propri debiti e, non potendo sperare nell’aiuto della Banca centrale europea (Bce), l’unica cosa che deve fare è ingraziarsi i mercati assicurando di servire loro il primo pezzo di carne disponibile sulla tavola. A costo di sacrifici, recessione, disoccupazione.
![]()
Uscire dal guado
Il dibattito sui debiti pubblici è lungo e articolato, ma per non ritrovarci di fronte ad altre crisi come quella che abbiamo attraversato e che ancora ci morde, dobbiamo ripensare l’Europa e il governo della moneta.
Abbiamo due strade di fronte a noi: andare avanti o tornare indietro. L’unica cosa certa è che non possiamo rimanere in mezzo al guado senza sapere se siamo in compagnia di amici o nemici e con il rischio essere mangiati dal primo rapace che passa.
Fuori di metafora non possiamo restare in un’Europa a mezz’aria: mercato comune, ma condizioni di lavoro agli antipodi tra un paese e l’altro; moneta unica, ma nemici finanziari; libera circolazione dei capitali, ma regimi fiscali concorrenziali. Non ci si può buttare in acqua con lo stesso salvagente e poi nuotare in direzioni opposte. O ci uniamo o ci lasciamo. O ci tuteliamo a vicenda dal pericolo che l’alleato si trasformi in carceriere o ci salutiamo. Anche se, certo, non a cuor leggero e solo come ultima ratio.
Costruire un’Europa solidale
L’auspicio è di poter andare avanti, ossia di costruire un’Europa federale e solidale al servizio delle persone e del bene comune. Un’Europa che non si fondi su trattati amministrati da tecnici nominati, ma su una Costituzione che si esprima in leggi emanate da un Parlamento eletto dal popolo. Un’Europa della sussidiarietà che, senza rinunciare alla solidarietà, sappia organizzarsi su più livelli per facilitare partecipazione, sostenibilità, presa in carico dei beni comuni. Un’Europa a sovranità monetaria socialmente orientata che, pur disponendo di una moneta comune, lasci spazio allo spontaneismo monetario territoriale per favorire l’autodeterminazione dei cittadini e lo sviluppo delle economie locali. Un’Europa dell’omologazione salariale e sociale affinché esista un’unica Europa sociale e del lavoro. Un’Europa a fiscalità condivisa che gestisca il debito pubblico europeo come un tutt’uno e redistribuisca le risorse in base ai bisogni dei singoli territori.
Il primo passo in questa direzione dovrebbe essere l’elezione di un’Assemblea costituente che scriva la nuova Costituzione europea contenente principi, diritti, doveri, assetti organizzativi e istituzionali. Ma, nell’attesa, sarebbe già un grande passo avanti se si cominciasse a riformare la Banca centrale europea per democratizzare l’euro e gestirlo in chiave sociale a partire dall’obiettivo di aiutare gli stati a liberarsi dai loro debiti pubblici. Sarebbe il segnale che ci stanno a cuore più le persone dei mercati, condizione senza la quale nessun’altra Europa è possibile.
Francesco Gesualdi