Torino, gli strumenti per non avere paura
Reportage periferie /
1
Erano gli anni
Sessanta quando cartelli affissi sulle porte degli edifici del capoluogo
piemontese avvertivano: «Non si affitta a meridionali». Nel 2014 sono ancora
tanti i torinesi che ricordano quegli anni e citano quelle scritte quasi a
sottintendere che la città ha già affrontato massicci flussi migratori e ha
saputo reagire, accogliere e integrare. Oggi basta salire su un tram come il 16
o spingersi nel quartiere Barriera di Milano per toccare con mano una città che
resta fedele alla sua lunga tradizione di accoglienza e, pur nelle difficoltà e
nelle contraddizioni, continua a cambiare volto.
Nell’inverno 2014 gli enti locali torinesi hanno siglato diversi accordi
il cui tema di fondo era la relazione con le comunità di migranti. Solo per
citare alcuni esempi, sono dello scorso febbraio l’adesione della Provincia di
Torino al protocollo d’intesa sulla prevenzione e il contrasto della tratta degli
esseri umani, e la formalizzazione della collaborazione fra la polizia
municipale e la comunità marocchina per la prevenzione dell’abbandono
scolastico, per la mediazione nei casi di conflitti tra i giovani immigrati e
per l’assistenza alle vittime di violenza domestica.
I temi relativi ai migranti hanno certamente un peso
notevole nel dibattito e nell’agenda politica della città che, sia attraverso
le istituzioni pubbliche sia con l’apporto del cosiddetto «privato sociale», si
attiva per cercare soluzioni ai problemi legati all’accoglienza e
all’integrazione delle comunità straniere. Non mancano ovviamente le polemiche
e le accuse a enti pubblici e associazioni di dare precedenza ai bisogni degli
stranieri rispetto a quelli dei torinesi. Ma in una città dove sono già
presenti le seconde generazioni, dove la crisi economica si fa sentire con tale
forza da spingere talvolta gli immigrati stessi ad abbandonare l’Italia per
rientrare nei paesi d’origine o per spostarsi in altre nazioni europee, dove le
scuole sono da anni laboratori di interculturalità, la rassicurante divisione
noi/loro è un semplicismo che fatica ogni giorno di più a descrivere la realtà.
L’ufficio per la pastorale migranti (Upm) della diocesi
di Torino è un punto di riferimento fondamentale per le comunità straniere.
Offre numerosi servizi fra i quali lo sportello per il lavoro, le consulenze
legali, l’insegnamento dell’italiano e molti altri. Sergio Durando, direttore
dell’Upm, traccia una sintesi della situazione: «Metà dei 385 mila immigrati
del Piemonte vivono a Torino: sono 200 mila nella provincia di cui 150 mila nel
territorio comunale». Secondo il XXIII Rapporto immigrazione 2013 (vedi
articolo pag. 28) di Caritas e Migrantes, nella regione la comunità più nutrita
è quella rumena, con 137 mila presenze, seguita dalle comunità marocchina,
albanese, cinese e peruviana. Un punto di partenza per provare a mettere ordine
nel complesso insieme di fenomeni legato ai migranti, suggerisce Sergio, può
essere il tema del lavoro: il Piemonte è la regione con il più alto tasso di
disoccupazione al Nord (9,8% nel 2013); l’agricoltura dà ancora lavoro ma
ovviamente non nel contesto urbano del capoluogo piemontese, dove i settori
colpiti dalla crisi sono l’edilizia, in cui tendono a concentrarsi i lavoratori
di origine rumena, l’industria e il settore manifatturiero, nei quali le
comunità di migranti maggiormente rappresentate sono quella marocchina e quella
albanese. «Il problema occupazionale», continua Durando, «si traduce facilmente
in un problema abitativo sia per i cittadini di origine italiana che per gli
stranieri, e per i migranti la marginalità economica diventa anche giuridica,
con la perdita dei permessi di soggiorno: nel 2012 i permessi persi sono stati
maggiori dei permessi di ingresso».

Categorie speciali: rifugiati
e titolari di protezione internazionale
All’interno della comunità dei migranti ci sono poi
delle categorie speciali: i rifugiati e i titolari di protezione
internazionale. Per quanto riguarda i rifugiati, il ministero dell’interno
guidato da Angelino Alfano, nel 2013, aveva aumentato da tremila a diciottomila
il numero dei richiedenti asilo che potevano essere accolti. Ma i tempi di
accoglienza, l’arretrato, l’accumulo di richieste e la difficoltà di reale
inserimento lavorativo rendono di fatto molto difficile approfittare
dell’aumento effettuato. «A Torino le strutture occupate da rifugiati, profughi
e titolari di protezione internazionale, sono sette più una casa di religiosi»,
interviene don Claudio Curcetti, sacerdote assegnato dalla diocesi all’Upm, «e
la situazione più esplosiva è forse quella del ex Moi, il villaggio olimpico
costruito nel 2006 e attualmente occupato da circa quattrocento persone» (vedi MC
8-9/2013, pp. 59-63). Si tratta di uomini, donne e bambini giunti in Italia
a causa della cosiddetta emergenza Nord Africa, cioè l’arrivo in massa di
migranti in fuga dai paesi del Maghreb interessati dalla guerra, a partire da
quella libica.
L’accoglienza dei rifugiati su tutto il territorio nazionale
è costata mediamente ventitremila euro a persona per circa ventimila persone,
ma gli interventi sono stati disorganizzati e approssimativi: i fondi – a
partire dal rimborso di 40 euro al giorno per rifugiato – hanno raggiunto solo
in minima parte i beneficiari, che si sono spesso trovati abbandonati, relegati
a spazi abitativi degradati e privati di un piano di rientro alla fine
dell’emergenza.
«Uno dei problemi è che le politiche nazionali in
materia di migranti sono più preoccupate della sicurezza che dell’accoglienza», continua don Claudio, «ma questo
genera enormi storture che oltretutto aumentano la tensione e l’insicurezza».
Per non parlare di costi: un «centro di identificazione e espulsione» (Cie)
costa circa 45 euro al giorno per singolo individuo trattenuto; un rimpatrio
arriva a seimila euro. Le periferie e il degrado, conclude Curcetti, sono in
fondo il fallimento di una società la cui amministrazione e la cui urbanistica
non sono state in grado di distribuire il disagio in modo da «diluirlo» nel
tessuto urbano, ma lo hanno concentrato e, in questo modo, amplificato. «Se in
un condominio o in un quartiere ci sono settanta famiglie in condizioni
economiche dignitose e trenta disagiate, le prime possono più facilmente
cercare di andare incontro ai bisogni delle seconde e aiutarle a uscire dal
disagio. Ma se le proporzioni sono invertite, come si può pensare che un trenta
per cento di persone si faccia carico dei bisogni del settanta per cento? È
ovviamente impossibile».
La corrispondenza fra periferia e disagio si è andata
allentando negli ultimi decenni, ma resta attuale nel caso dei Rom. Dagli anni
Settanta a oggi la provenienza delle popolazioni rom presenti a Torino è
cambiata, ma le aree in cui risiedono sono rimaste le stesse: baraccopoli ai
margini della città. Gli insediamenti abusivi di Lungo Stura Lazio hanno visto,
a partire dai primi mesi del 2014, un processo di graduale sgombero nell’ambito
di un progetto che mira a coinvolgere le famiglie stesse nello smantellamento
delle baracche attraverso l’autodemolizione. Del programma fanno poi parte la
sottoscrizione da parte dei Rom di un patto di emersione, l’accettazione delle
regole di convivenza e legalità, la compartecipazione alle spese e
l’inserimento in complessi di social housing, cioè soluzioni pensate per
le categorie che, prevalentemente per motivi economici, non sono in grado di
rispondere da sole ai propri bisogni abitativi.
L’intervento di Lungo Stura Lazio, oltre ad aver
provocato le ire degli esponenti della Lega («ai Rom le case popolari, ai
torinesi la mini-imu», ha commentato un esponente torinese), suscita qualche
apprensione anche fra gli addetti ai lavori. Finora lo sgombero di un campo,
avverte uno di loro che preferisce restare anonimo, ha spesso innescato un
processo simile alla mitosi cellulare, ha portato cioè alla formazione di più
campi sparsi. Inoltre occorrerebbe sfatare alcuni miti: ad esempio il fatto che
i Rom vivono nei campi per una questione culturale quando in realtà sono i
primi a non volerli; oppure il pregiudizio per cui l’avversione al lavoro è un
tratto caratteristico dei Rom quando invece ci sono, ad esempio, casi di
ragazze assunte come badanti o colf, le quali, fra l’altro, si guardano bene
dal rivelare che vivono in un campo. In questi casi, l’inserimento lavorativo è
avvenuto al prezzo del rinnegamento della propria origine.
Molto difficoltoso appare infine ridare vigore al patto
scolastico in base al quale i Rom si erano impegnati a mandare i loro figli a
scuola: molti Rom sembrano pensare che dopo quarant’anni di presenza in Italia,
e nonostante la scolarizzazione dei bambini, per loro nulla è cambiato, perché
continuare a impegnarsi?
Imparare per non
avere paura
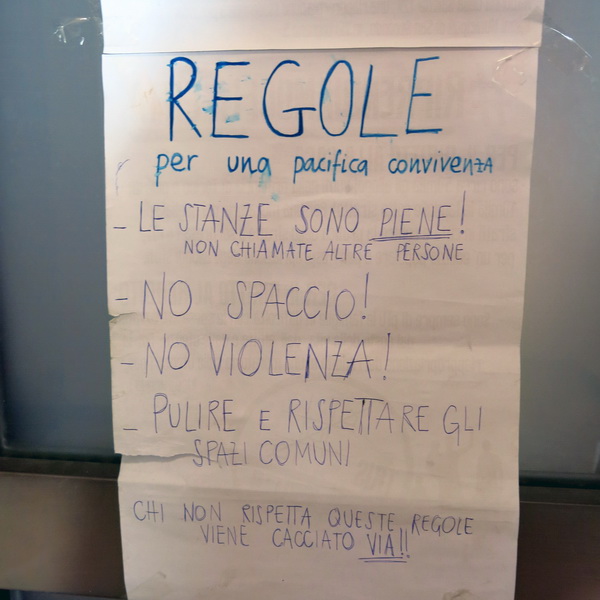
appare non meno articolata. In una scuola come la Gabelli di Barriera di
Milano, sempre a Torino, gli alunni con genitori di origine straniera sono il
settanta per cento e salgono al novanta per cento nelle prime classi. Siamo in
un borgo storico caratterizzato dalle cosiddette case di ringhiera, dove gli
affitti sono meno cari e per questo attirano famiglie a basso reddito, come
spesso sono quelle dei migranti. Lavorare in scuole come la Gabelli o la vicina
Pestalozzi richiede competenze specifiche e una professionalità avanzata che
permettano di gestire situazioni complesse come i casi delle iscrizioni ad anno
iniziato, di livelli diversi di conoscenza della lingua italiana e di
situazioni familiari molto difficili. A volte i bambini mostrano chiaramente di
non voler rientrare a casa dopo la scuola, segno questo della presenza di un
ambiente familiare teso, o spiegano di non aver fatto i compiti perché non sono
riusciti a leggere e scrivere a lume di candela, oppure ancora perché nel lungo
e freddo inverno torinese il problema principale della sera è quello di trovare
un modo di scaldarsi sotto le coperte in assenza di riscaldamento. I doveri
scolastici passano così in secondo piano anche a causa dei tagli delle utenze
elettrice, spesso abusive, che rendono ostile perfino l’ambiente domestico.
Ma i lati positivi dell’interculturalità in scuole come
queste non mancano: innanzitutto, i figli di stranieri hanno spesso sviluppato
un grado di autonomia e maturità maggiore e si rivelano più rispettosi delle
regole e più attentamente monitorati dai genitori che non i bambini italiani, i
quali vivono in quelle stesse aree degradate perché spesso appartengono a
famiglie disagiate e problematiche. I pochi italiani che decidono liberamente
di portare i figli in queste scuole, inoltre, lo fanno per una precisa volontà
di preparare i loro bambini a vivere nella Torino che verrà e sono generalmente
entusiasti dell’esperienza che i ragazzi, e loro stessi – spesso attivamente
impegnati nei consigli d’istituto – stanno vivendo.
Per quanto riguarda il doposcuola, molto attiva è
l’Associazione animazione interculturale (Asai), già protagonista fin dagli
anni Novanta dei primi e fruttuosi esperimenti di interculturalità a San
Salvario. Nella sede di via Gené, a Porta Palazzo, il «Cantiere S.O.S.» (Scuola
oltre la Scuola) offre, grazie ai suoi operatori e ai volontari, un servizio di
doposcuola ad almeno un centinaio di bambini delle elementari e medie, corsi di
italiano per minori e adulti e laboratori artistici. Un progetto in corso, spiegano
Fabrizio e Roberto, due degli educatori, è quello di giustizia riparativa (sul
tema, dossier MC 12/2013) che nasce da una collaborazione fra Asai,
Polizia municipale e Tribunale dei minori. «Nei casi di bullismo e reati minori»,
spiega Fabrizio, «la collaborazione consente l’inserimento dei ragazzi in un
percorso di servizio di riparazione alla comunità, mentre la Polizia municipale si occupa
della mediazione con la vittima». «Quello che si cerca di fare qui, attraverso
il progetto di giustizia riparativa come in tutte le altre attività con i
ragazzi» gli fa eco Roberto, «è di dare loro più strumenti per avere meno paura
di ciò che vivono giorno per giorno. Abbiamo visto miglioramenti oggettivi in
diversi casi di adolescenti problematici: se si liberano della paura cominciano
piano piano a liberarsi anche della rabbia».
Il lavoro con gli adolescenti si estende poi a quello
con la comunità. Riccardo, anche lui educatore Asai, racconta delle esperienze
di coinvolgimento dei cittadini in quartieri come San Salvario ma non solo.
L’obiettivo è creare una rete sul territorio che metta insieme le famiglie, i
commercianti, chiunque voglia spendersi per il quartiere, conoscere altre
persone e vivere una realtà più integrata. Riccardo cornordina un collettivo
interculturale di giovani musicisti che si chiama Barriera Republic: «Anche
un quartiere non facile come questo», spiega Riccardo, «è capace di generare
senso di appartenenza. Ci sono ragazzi con grandi capacità come musicisti,
videomaker, attori… Bisogna solo incanalare queste loro abilità in modo che
creino condivisione, confronto, inclusione».

l’offerta formativa (che comprende anche corsi di italiano) del «Centro
territoriale permanente» per l’istruzione e la formazione in età adulta di
Porta Palazzo (Ctp Parini). «Stiamo sperimentando una vera e propria emergenza
alfabetizzazione che, combinata con leggi complesse e con l’aumento della
burocratizzazione, genera sempre maggior esclusione per tutti coloro, e sono davvero
tanti, che non sanno leggere e scrivere, non sono in grado di compilare moduli
o di acquisire informazioni», avverte Rocco, uno degli operatori del centro. Il
Ctp Parini ha circa duemila utenti di cui un migliaio sono frequentanti. A un
analfabeta occorrono tre o quattro anni per arrivare al livello di
alfabetizzazione A1 del quadro europeo (livello base). Molti, dopo aver
raggiunto quel livello si rendono conto di quanto importante sia lo strumento
che prima non possedevano e decidono di continuare a frequentare.
I missionari della
Consolata e i migranti
Dal 2013
il lavoro dei missionari della Consolata con migranti di Torino si è
intensificato: padre Antonio Rovelli, responsabile della cooperazione di Mco,
fa ora parte del team di cornordinamento dell’Upm, e padre Godfrey Msumange,
coadiuvato dai viceparroci padre Nicholas Muthoka e padre Francesco Discepoli,
è parroco di Maria Speranza Nostra, una vasta parrocchia nel cuore di Barriera
di Milano a Torino.
I missionari vi hanno iniziato il loro servizio il 20 ottobre del 2013,
giornata missionaria mondiale, e hanno cominciato ad ascoltare, osservare,
visitare le famiglie e programmare. «È un quartiere molto vario», spiega padre
Nicholas, «che ha accolto immigrati del Sud Italia e del Veneto in passato e
che ora ha visto l’arrivo di rumeni, albanesi, nigeriani, polacchi, eritrei,
marocchini, tunisini e diversi latinoamericani». «Per il momento» aggiunge
padre Godfrey «stiamo attivando, o prevediamo di attivare, servizi come lo
sportello lavoro, la distribuzione di cibo e il centro d’ascolto, oltre
all’oratorio che adesso è dedicato all’aggregazione. Ma vorremmo sviluppare
anche attività di doposcuola, corsi e laboratori».
Altra
realtà è quella di San Gioacchino a Porta Palazzo, una parrocchia con sacerdoti
nigeriani, in cui padre José Jesus Ossa Tamayo, missionario della Consolata
colombiano, segue la comunità dei latinos, i migranti provenienti
dall’America Latina. «I latinos sono ventimila in Piemonte, seimila
nella sola Torino», spiega padre Jesus, «e per guadagnarsi da vivere lavorano
spesso come badanti o facendo le pulizie. Hanno una grande fame di Dio e, al di
là della messa, si rivolgono al parroco come a un punto di riferimento per
tante cose: farsi accompagnare a un colloquio di lavoro, chiedere consigli sui
problemi di coppia». A volte le situazioni familiari e le condizioni abitative
sono molto difficili: padre Jesus racconta dell’esperienza di un’anziana che è
stata portata in Italia dai figli perché non restasse sola in patria, ma ha
problemi di mobilità che le impediscono di fare le scale e la costringono in
casa dove «piange, piange e piange, tutto il giorno. Con persone come lei»,
conclude padre Jesus «il ruolo di noi missionari è la presenza: andare e
“piangere” con lei. Ultimamente i parrocchiani si sono offerti di far costruire
un bell’altare: per loro è molto importante, è un segno di appartenenza. Lo
faremo, certo, ma ho detto loro che il primo altare a cui devono pensare è la
vecchietta che piange, o il fratello che non lavora e non ha di che nutrirsi».
Chiara Giovetti


 1967
1967




















.JPG)
.JPG)
 Il centro più lontano dall’ospedale si trova a oltre
Il centro più lontano dall’ospedale si trova a oltre

 Parte
Parte La
La Monica
Monica