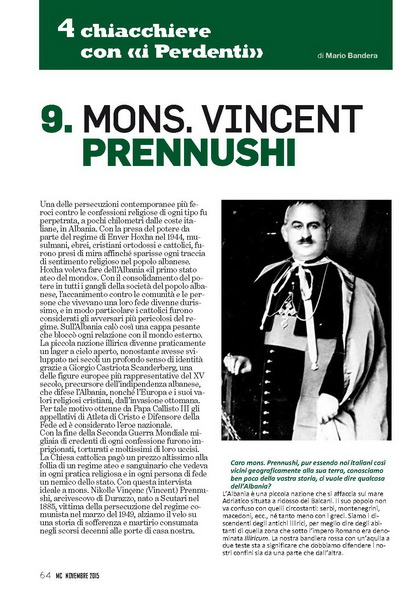I perdenti 11: i giovani della rosa bianca
La «Rosa Bianca» è il nome assunto da un gruppo di giovani universitari di Monaco di Baviera che si costituirono in un piccolo ma significativo movimento di resistenza all’interno della Germania nazista. Il gruppo era composto da 5 studenti: Hans Scholl, sua sorella Sophie Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell e Willi Graf, tutti poco più che ventenni. A essi si unirà il professore universitario Kurt Huber. Sebbene tutti fossero studenti universitari, i ragazzi avevano fatto il servizio militare partecipando agli eventi bellici sia sul fronte francese che su quello russo dove erano stati testimoni delle atrocità commesse contro la popolazione civile e in modo particolare contro gli ebrei. Essi erano convinti che la guerra scatenata dal nazismo avrebbe portato alla distruzione e alla sconfitta della Germania. Il loro modo di pensare si era formato seguendo le tesi del Quickbo (Sorgente di vita), un movimento culturale fondato e seguito dal sacerdote di origine italiana Romano Guardini (1885-1968).

La loro resistenza al nazismo si svolse principalmente all’interno dell’ambiente universitario della Baviera, riuscendo a stampare e distribuire clandestinamente sei volantini il cui contenuto avrebbe dovuto risvegliare la coscienza del popolo tedesco. Più la guerra si prolungava, più il gruppo della «Rosa Bianca» assumeva una posizione decisa contro Hitler, non solo distribuendo opuscoli all’interno dell’università, ma addirittura incollandoli sui cancelli di ingresso e dipingendo slogan anti hitleriani sui muri di Monaco e all’interno dell’edificio universitario. Scoperti da un bidello nazista, vennero arrestati dalla Gestapo, torturati e condannati a morte per decapitazione il 22 febbraio 1943 dopo un processo di poche ore.
Con i fratelli Hans e Sophie Scholl abbiamo voluto approfondire la loro storia di oppositori al nazismo. Sebbene calpestati, vilipesi e di fatto perdenti di fronte alla tirannia scatenata da Hitler, restano nella coscienza collettiva dei tedeschi e degli europei in generale, i veri vincitori dello scontro che avvenne in quegli anni.
![]() Sophie e Hans, come vi è venuto in mente di opporvi al nazismo in una forma che era già fin dall’inizio destinata all’insuccesso?
Sophie e Hans, come vi è venuto in mente di opporvi al nazismo in una forma che era già fin dall’inizio destinata all’insuccesso?
Dopo la sconfitta di Stalingrado nel febbraio 1943 fu chiaro, anche se non si osava dirlo apertamente, che le sorti della guerra erano segnate e che la Germania sarebbe stata sconfitta.
Altri cittadini come voi avevano la stessa sensazione, eppure non mossero un dito. Cos’è che vi ha spinto ad agire così pericolosamente in un ambiente come quello universitario profondamente segnato dall’ideologia nazista?
Noi e i componenti del nostro gruppo rigettavamo la violenza nazista che la nostra patria, la Germania, stava attuando in gran parte d’Europa. Noi tutti credevamo in un’Europa federale che aderisse ai principi cristiani di tolleranza e giustizia.
Anche il fatto di avere come riferimento Romano Guardini, vi dava una spinta ulteriore per non restare con le braccia conserte di fronte alla rovina della vostra patria.
Oltre che da Romano Guardini il nostro modo di pensare e di agire era stimolato anche dal parroco di Soflingen, un quartiere di Ulm in cui era presente una forte resistenza cattolica al nazismo, da Franz Weiss, da Carl Muth e da Theodor Haecker, intellettuali cattolici antinazisti, il cui pensiero influenzò molto le scelte di resistenza non violenta del nostro gruppo.
Con questi riferimenti religiosi e culturali non vi limitaste a una resistenza passiva, ma decideste di agire stampando e distribuendo volantini.
Sì. E fu una cosa non da poco tenendo conto che la carta era razionata e tutto era controllato. Anche ottenere buste e francobolli a sufficienza richiedeva molta prudenza per non dare nell’occhio. Producemmo sei volantini, gli ultimi due più forti degli altri. Infatti l’intestazione che avevamo messo ci autodefiniva: «Il movimento di resistenza in Germania».
Se non sbaglio, anche altri in Germania agivano allo stesso modo.
Ad essere sinceri il nostro modo di agire fu ispitaro dalla lettura di un volantino che arrivò nelle nostre case riportando le idee del vescovo di Munster (Monaco), Clemes August Von Galen (1878-1946 – ora beato), il quale certamente non le mandava a dire a Hitler: le sue omelie erano un vigoroso atto d’accusa contro l’ideologia nazista. Von Galen, fu uno dei pochi vescovi tedeschi che si oppose apertamente a quell’ideologia, e per questo si guadagnò il titolo di «leone di Munster».
![]() Ma anche a casa vostra l’atmosfera che respiravate non era certamente favorevole al nazismo.
Ma anche a casa vostra l’atmosfera che respiravate non era certamente favorevole al nazismo.
Nel gennaio del ’42 nostro padre Robert venne denunciato da una sua impiegata per aver definito Hitler «un flagello di Dio» e per aver detto che la guerra di Russia era un massacro insensato e che i sovietici avrebbero finito per conquistare Berlino.
Che conseguenze ebbe?
Prelevato dalla Gestapo, torturato e interrogato, venne condannato a 4 mesi di carcere che praticamente significarono la rovina economica della nostra famiglia, anche se un volta scontata la pena fu rilasciato.
Fu l’anticipazione di quello che in seguito successe a voi.
A quel tempo chiunque osava mettere apertamente in dubbio l’autorità del Führer e criticare quello che lui affermava, ovvero voler costruire un nuovo Reich che sarebbe durato oltre mille anni, veniva visto come un nemico della patria.
Quando decideste di passare all’azione?
Nell’estate del ’42, dopo aver battuto a macchina e ciclostilato qualche centinaio di copie del primo volantino, cominciammo a lasciarlo nei locali pubblici, alle fermate dell’autobus, nelle cabine telefoniche o a gettralo lungo le strade dai tram di notte.
Nessuno vi sorprese mentre compivate queste azioni di volantinaggio?
No, e sappiamo con certezza che anche la Gestapo, pur indagando meticolosamente su chi poteva essere il responsabile di queste azioni, non riusciva a cavare un ragno dal buco.
E voi non commetteste nessun errore compiendo queste azioni rischiose?
Purtroppo sì, il 18 febbraio del ’43, noi due all’interno dell’Università salimmo fino all’ultimo piano con una valigia contenente 1.500 copie del sesto (e ultimo) volantino. Una volta in cima alle scale, lanciammo verso gli studenti che stavano nell’atrio sottostante i nostri volantini. Un bidello ci vide e ci denunciò. Fummo arrestati e nel giro di pochi giorni la stessa sorte toccò agli altri membri della «Rosa Bianca», oltre a un’ottantina di persone che fiancheggiavano le nostre azioni contro il nazismo.
Alla Gestapo non pareva vero di avervi finalmente tra le mani.
Iniziarono subito a interrogarci, pestarci e a torturarci; alcuni di loro restarono sorpresi dal coraggio e dalla determinazione con cui rivendicavamo le ragioni del nostro dissenso all’ideologia nazista e a Hitler.
Prevedendo che vi aspettava la condanna a morte, quale fu il vostro atteggiamento di difesa?
Per prima cosa noi due cercammo di attribuirci interamente le colpe di cui tutti erano accusati allo scopo di scagionare gli altri membri della «Rosa Bianca». Allo stesso tempo, per far capire ai giudici nazisti che non eravamo un gruppo di esaltati, affermammo durante il processo: «Sono in tanti a pensare quello che noi abbiamo detto e scritto; solo che non tutti osano esprimerlo a parole».
Truccate le prove per la vostra condanna, il processo si concluse come volevano i gerarchi nazisti?
Naturale. Dopo un dibattimento farsa, il giudice Roland Freisler, emise il verdetto con queste parole: «In nome del popolo tedesco, gli imputati sono condannati a morte per favoreggiamento antipatriottico del nemico, alto tradimento e demoralizzazione delle forze armate. Inoltre il tribunale del popolo constatato che essi attraverso volantini hanno propagandato idee disfattiste, sabotato l’organizzazione militare e civile del sistema di vita del nazionalsocialismo del nostro popolo, insultato il Führer nella maniera più vile e infame aiutando in tal modo i nemici del Reich. Pertanto essi sono condannati a morte tramite ghigliottina».
I giovani del gruppo della «Rosa Bianca», composto da cattolici ed evangelici che cercavano di vivere con coerenza la loro fede, chiedono di ricevere i sacramenti prima dell’esecuzione. Cristoph Probst, l’unico a non essere battezzato, riceve il battesimo, la comunione e l’estrema unzione dal cappellano cattolico Heirich Sperr, al quale consegna un biglietto da dare alla madre su cui è scritto: «Ti ringrazio di avermi dato la vita. A pensarci bene, non è stata che un cammino verso Dio». I fratelli Hans e Sophie che vengono giustiziati in un’altra ala del carcere, vorrebbero un prete cattolico, ma non potendolo avere si confessano e celebrano la Santa Cena con il cappellano evangelico Karl Alt. Prima dell’esecuzione ai due fratelli viene permesso un ultimo e breve incontro con i genitori. Impressionato dal loro atteggiamento, uno dei secondini racconterà in seguito: «I giovani della “Rosa Bianca” si sono comportati con un coraggio fantastico, tutto il carcere ne fu impressionato. Perciò ci siamo accollati il rischio di riunire ancora una volta i condannati, volevamo che potessero fumare ancora una sigaretta insieme, non furono che pochi minuti ma certamente fu un gran regalo per loro». Le ultime parole di Cristoph Probst sono: «Fra pochi minuti ci rivedremo nell’eternità!». Poi si lasciano condurre alla ghigliottina senza battere ciglio, mentre viene condotto al patibolo Hans Scholl grida: «Viva la libertà!». Il 19 aprile 1943 sono processati tutti gli altri. Tredici sono ghigliottinati nei mesi successivi e altri trentotto incarcerati. Con la caduta del regime nazista vennero portate alla luce le molteplici attività che il gruppo della «Rosa Bianca» fece per opporsi al nazismo. Ancora oggi essi rappresentano la forma più pura di opposizione alla tirannia hitleriana in terra germanica, senza essere mossi da interessi personali o di partito, tutto il loro modo di vivere e di agire era mosso dalla fede cristiana e dall’amore per la libertà.
Don Mario Bandera, Missio Novara

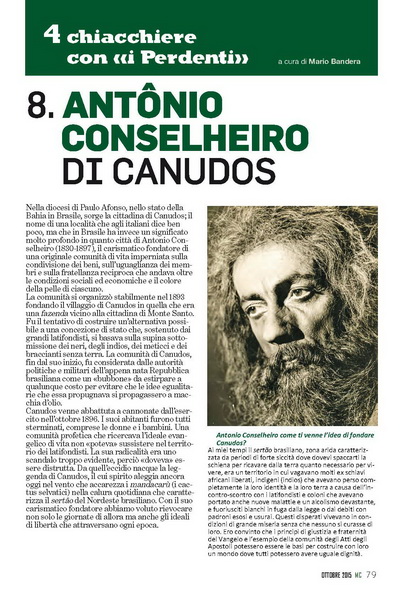




 Sì, e in più l’esercito repubblicano si era sentito umiliato da
Sì, e in più l’esercito repubblicano si era sentito umiliato da
.jpg)


 Pedro Calungsod Bissaya, originario della regione di
Pedro Calungsod Bissaya, originario della regione di
 FRANZ JÄGERSTÄTTER nacque nel 1907 a Sankt Radegund, in Austria, e come semplice contadino visse le vicende della sua patria fino a che Hitler nel 1938 con l’Anschluss (ovvero l’annessione) inglobò l’Austria, facendola diventare parte integrante della Germania nazista. Come tutti i giovani del suo tempo, doveva obbligatoriamente prestare servizio militare e giurare fedeltà alla dottrina del nazional-socialismo e al Führer tedesco, cosa che egli si rifiutò di fare per la sua tenace convinzione che il nazismo fosse incompatibile con il Cristianesimo e che non potesse assolutamente mettere in secondo piano i principi evangelici per assumere quelli della dottrina nazional-socialista.
FRANZ JÄGERSTÄTTER nacque nel 1907 a Sankt Radegund, in Austria, e come semplice contadino visse le vicende della sua patria fino a che Hitler nel 1938 con l’Anschluss (ovvero l’annessione) inglobò l’Austria, facendola diventare parte integrante della Germania nazista. Come tutti i giovani del suo tempo, doveva obbligatoriamente prestare servizio militare e giurare fedeltà alla dottrina del nazional-socialismo e al Führer tedesco, cosa che egli si rifiutò di fare per la sua tenace convinzione che il nazismo fosse incompatibile con il Cristianesimo e che non potesse assolutamente mettere in secondo piano i principi evangelici per assumere quelli della dottrina nazional-socialista.
 Franz: Io fui allevato da mia nonna perché mia mamma mi generò da una relazione
extraconiugale. Quando la mia mamma, dopo qualche anno dalla morte del mio papà
naturale, sposò Heinrich Jägerstätter, questi mi adottò e ne assunsi il
cognome. Nel 1933 morì senza figli propri e così ne ereditai le proprietà. Nel
1936 sposai Franziska Schwaninger e dal matrimonio nacquero tre figlie:
Rosalia, Maria e Aloisia. Qualche anno prima avevo riconosciuto la pateità di
una bambina nata da una relazione sentimentale con un’altra ragazza, Theresia
Auer. Per dirla tutta, non ero «uno stinco di Santo» e anche la mia famiglia
aveva qualche problema con la morale ufficiale della Chiesa.
Josef:
Nella ditta in cui lavoravo a Bolzano, ebbi la fortuna di conoscere Hildegard
Straub, una ragazza che era impiegata nello stesso posto e che proveniva anche
lei dal gruppo dei giovani dell’Azione Cattolica altornatesina. Dopo un breve
fidanzamento, nel maggio del 1942 ci sposammo e l’anno successivo nacque nostro
figlio, cui demmo il nome di Albert.
Franz: Io fui allevato da mia nonna perché mia mamma mi generò da una relazione
extraconiugale. Quando la mia mamma, dopo qualche anno dalla morte del mio papà
naturale, sposò Heinrich Jägerstätter, questi mi adottò e ne assunsi il
cognome. Nel 1933 morì senza figli propri e così ne ereditai le proprietà. Nel
1936 sposai Franziska Schwaninger e dal matrimonio nacquero tre figlie:
Rosalia, Maria e Aloisia. Qualche anno prima avevo riconosciuto la pateità di
una bambina nata da una relazione sentimentale con un’altra ragazza, Theresia
Auer. Per dirla tutta, non ero «uno stinco di Santo» e anche la mia famiglia
aveva qualche problema con la morale ufficiale della Chiesa.
Josef:
Nella ditta in cui lavoravo a Bolzano, ebbi la fortuna di conoscere Hildegard
Straub, una ragazza che era impiegata nello stesso posto e che proveniva anche
lei dal gruppo dei giovani dell’Azione Cattolica altornatesina. Dopo un breve
fidanzamento, nel maggio del 1942 ci sposammo e l’anno successivo nacque nostro
figlio, cui demmo il nome di Albert.

 Una santa «di colore» diremmo
oggi, eppure di santi provenienti dal continente africano ce ne furono parecchi
prima di te, non è così?
Una santa «di colore» diremmo
oggi, eppure di santi provenienti dal continente africano ce ne furono parecchi
prima di te, non è così? Fui
subito venduta al mercato degli schiavi e in pochi anni fui sballottata da un
padrone all’altro (ben sei) di diversi paesi. Ricordo che il padrone più
cattivo fu un generale turco ottomano che mi fece fare un tatuaggio su tutto il
corpo e anche delle incisioni che sfigurarono tutta la mia persona, tranne il
volto. Per fortuna alla fine questo ufficiale mi vendette.
Fui
subito venduta al mercato degli schiavi e in pochi anni fui sballottata da un
padrone all’altro (ben sei) di diversi paesi. Ricordo che il padrone più
cattivo fu un generale turco ottomano che mi fece fare un tatuaggio su tutto il
corpo e anche delle incisioni che sfigurarono tutta la mia persona, tranne il
volto. Per fortuna alla fine questo ufficiale mi vendette.  Sì.
Decisi di seguire quella che ormai consideravo la mia nuova famiglia, ma il
Console mi mandò al servizio di un amico suo, Augusto Michieli, perché facessi
da baby-sitter alla figlioletta Alice (Mimmina).
Sì.
Decisi di seguire quella che ormai consideravo la mia nuova famiglia, ma il
Console mi mandò al servizio di un amico suo, Augusto Michieli, perché facessi
da baby-sitter alla figlioletta Alice (Mimmina). Quando
manifestai questa mia intenzione, fui accolta a braccia aperte dalle care
sorelle dell’Istituto Figlie della Carità fondato da Maddalena di Canossa per
aiutare i bambini più poveri e analfabeti a elevarsi culturalmente e
spiritualmente mediante l’istruzione scolastica. Dopo tre anni di noviziato,
l’8 dicembre 1896 pronunciavo i voti religiosi di povertà, castità e
obbedienza. L’allora patriarca di Venezia, il Cardinale Giuseppe Sarto, il
futuro Pio X, dopo avermi esaminata e interrogata lungamente, mi incoraggiò
nella mia vocazione e mi disse: «Gesù vi vuole. Gesù vi ama; voi amatelo e
servitelo sempre così». Dopo i voti venni mandata nella comunità di Schio,
Vicenza, dove rimasi per quarantacinque anni e lì svolsi qualsiasi lavoro mi
veniva richiesto: lavoravo in cucina, lavavo la biancheria, accudivo la
portineria, imparai anche a ricamare.
Quando
manifestai questa mia intenzione, fui accolta a braccia aperte dalle care
sorelle dell’Istituto Figlie della Carità fondato da Maddalena di Canossa per
aiutare i bambini più poveri e analfabeti a elevarsi culturalmente e
spiritualmente mediante l’istruzione scolastica. Dopo tre anni di noviziato,
l’8 dicembre 1896 pronunciavo i voti religiosi di povertà, castità e
obbedienza. L’allora patriarca di Venezia, il Cardinale Giuseppe Sarto, il
futuro Pio X, dopo avermi esaminata e interrogata lungamente, mi incoraggiò
nella mia vocazione e mi disse: «Gesù vi vuole. Gesù vi ama; voi amatelo e
servitelo sempre così». Dopo i voti venni mandata nella comunità di Schio,
Vicenza, dove rimasi per quarantacinque anni e lì svolsi qualsiasi lavoro mi
veniva richiesto: lavoravo in cucina, lavavo la biancheria, accudivo la
portineria, imparai anche a ricamare.