Indagine sulla maternità surrogata
Le attuali conoscenze scientifiche dicono che il rischio di conseguenze psichiatriche sulla madre surrogata e sul bambino è elevato. È difficile sostenere la tesi che avere dei figli sia un diritto. È altrettanto difficile non considerare la maternità surrogata come una particolare forma di sfruttamento della povertà. Per ora la sola e indiscussa certezza è che la pratica si è trasformata in un enorme affare.
Testo di Rosanna Novara Topino
In Italia le tecniche di Procreazione medicalmente assistita (Pma) restano precluse alle coppie omosessuali, ai single e alle mamme-nonne. Sono inoltre vietate la fecondazione post-mortem, cioè l’utilizzazione dei gameti del marito o compagno deceduto e l’utilizzazione degli embrioni a scopo di ricerca (permessa invece dal 2016 in Gran Bretagna). Peraltro il Tribunale di Milano, con una sentenza del 15 ottobre 2013 che riguardava un caso di surrogazione di maternità richiesta da una coppia italiana in Ucraina, stabilì che doveva escludersi la consumazione del delitto, da parte della coppia italiana, di falsa dichiarazione di maternità poiché l’atto di nascita del figlio era conforme alla lex loci, che in Ucraina impone il riconoscimento dello status di madre alla madre sociale (la committente) e non alla madre surrogata (cioè della gestante) o alla madre biologica (cioè della donatrice degli ovuli). Per quanto riguarda le coppie omosessuali, che hanno avuto un figlio mediante maternità surrogata all’estero, attualmente in Italia il figlio viene registrato a nome di un unico genitore, come genitore single. Non è infatti passata la proposta di legge della stepchild adoption, che prevede il riconoscimento, come genitore adottivo, del compagno di un genitore biologico. Va detto che il Tribunale di Roma, la Corte d’Appello di Torino e la Corte di Cassazione hanno più volte concesso la stepchild adoption ai partner dei genitori biologici, nell’ambito di coppie omosessuali, sottolineando la preminenza dell’interesse del minore rispetto a qualsiasi altro interesse dello stato.
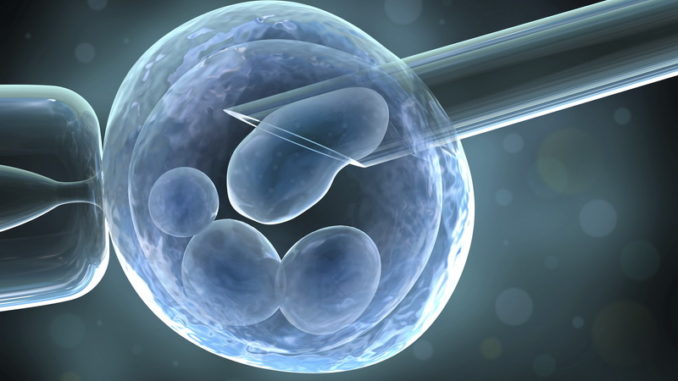
Affari e turismo riproduttivo
Nei paesi in cui è consentita la surrogazione della maternità, essa si è ben presto trasformata in un enorme giro d’affari. Negli Stati Uniti esistono oltre 400 cliniche dedicate. Le donne single o le coppie lesbiche possono scegliere su internet gli spermatozoi in base alle caratteristiche genetiche, al quoziente intellettivo e al carattere del donatore. L’acquisto viene recapitato dai corrieri in una notte, per cui si parla di overnight-male, cioè di «uomo di una notte». Gli ovociti di donne belle e intelligenti (spesso vengono messi annunci per cercarne sui giornali studenteschi universitari) arrivano a costare 50mila dollari. Naturalmente sono nate numerosissime agenzie specializzate nel far incontrare la domanda e l’offerta: forniscono le madri in affitto (che spesso possono essere scelte su catalogo), si occupano eventualmente della ricerca dei gameti se la coppia richiedente è sterile, delle visite mediche della futura gestante e della clinica in cui avverrà il parto e infine delle pratiche legali. Con un piccolo sovrapprezzo, di circa 250 dollari, è inoltre possibile scegliere il sesso del nascituro.
Naturalmente l’acquisto di gameti, il pagamento delle madri in affitto e tutte le spese mediche, assicurative, legali, di sostegno psicologico per la gestante che dovrà poi cedere il neonato alla coppia committente, sono a carico di chi richiede la Gestazione per altri (Gpa), quindi è evidente che il presunto «diritto alla procreazione», sbandierato da chi sostiene questa pratica, è senza alcun dubbio un privilegio per persone o coppie facoltose, che molto spesso alimentano il turismo riproduttivo per recarsi dai paesi come il nostro, dove la Gpa è vietata, in quelli dove tutto è permesso. In California nel 2010 sono nati 1.400 bambini con maternità surrogata, metà dei quali richiesti da coppie straniere, mentre in India, dove sono attive oltre 3.000 cliniche, nascono oltre 1.500 bambini l’anno con Gpa, un terzo dei quali per coppie straniere. In Ucraina nel 2011 sono state portate a termine con Gpa 120 gravidanze, ma il numero reale potrebbe essere più elevato.
Sfruttamento della povertà

Non c’è dubbio che la maternità surrogata sia una particolare forma di sfruttamento della povertà da parte di persone facoltose. Basti pensare a cosa prevedono i contratti di maternità surrogata: la donna che si presta per la gravidanza deve rinunciare a ogni diritto sul bambino, deve acconsentire all’aborto in caso di malformazione, deve essere disponibile a fornire il proprio latte dopo il parto e deve pagare delle penali se non rispetta gli standard sanitari richiesti. In alcuni stati, come la Thailandia, i committenti possono rifiutare il figlio con una malattia o un handicap, come capitato nel 2014: una coppia australiana committente di due gemelli ne rifiutò uno, nato Down e con una grave patologia cardiaca.
In realtà, secondo i risultati di alcune ricerche scientifiche, la maternità surrogata è un’autentica violenza perpetrata sia alle madri surrogate che ai figli.
Le madri surrogate, infatti, per favorire l’impianto degli embrioni, devono essere sottoposte a ingenti dosi di ormoni, che ne possono pregiudicare la salute. Oltre a questo bisogna considerare che, secondo una ricerca condotta da neuroscienziati dell’Università autonoma di Barcellona e pubblicata su Nature Neuroscience, i cambiamenti ormonali che avvengono in gravidanza modificano la struttura cerebrale della madre, riducendo per un lungo periodo di tempo il volume di alcune specifiche regioni cerebrali deputate alla cognizione sociale e funzionali alla focalizzazione della madre sul figlio. Si tratta della rete neurale associata alla teoria della mente, cioè la capacità di attribuire stati mentali (pensieri, sentimenti, intenzioni, desideri) a sé stessi e agli altri. In alcune di queste regioni si verificherebbe, durante la gravidanza, un aumento dell’attività neuronale, che rende le madri particolarmente sensibili alle immagini dei propri neonati, molto più che a quelle di altri bambini. Nel cervello dei futuri padri, secondo questa ricerca, non si verifica niente di analogo. Questi risultati ci fanno intuire quale violenza ci sia nella richiesta a una donna di cedere il proprio neonato alla coppia committente e, nel contempo, fanno pensare che una coppia di omosessuali maschi oppure un uomo single siano forse meno adeguati ad allevare il proprio figlio, senza la presenza materna.
Un’altra ricerca, condotta da studiosi della Stanford University e pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences, ha rivelato che per tutti i bambini, la voce della madre rappresenta una fonte importante di comfort emotivo, grazie alla complessa interazione tra diverse regioni cerebrali. Il feto sente la voce della madre mentre si trova in utero e, dopo la nascita, rappresenterà una costante nell’ambiente uditivo del bambino per tutta la fase del suo sviluppo. Essa inoltre accompagnerà molte delle informazioni fondamentali per il comportamento e l’apprendimento del piccolo. Durante l’ascolto della voce della propria madre, nel cervello dei bambini si attivano regioni che elaborano le informazioni uditive e le emozioni, le regioni che rilevano gli stimoli di ricompensa e li elaborano, le regioni che elaborano le informazioni sul sé e le aree che sono coinvolte nella percezione ed elaborazione dei visi. È chiaro che privare un bimbo della propria madre, sia pure surrogata, per farlo crescere con un single o una coppia di gay equivale a renderlo di fatto orfano di madre.
![]()
Conseguenze psichiatriche
Secondo le attuali conoscenze in campo psicanalitico e psichiatrico, la maternità surrogata è una pratica ad altissimo rischio di gravi patologie sia per la madre surrogata che per il bambino. L’osservazione del comportamento dei lattanti separati dalla madre che li ha portati in grembo e dei loro vissuti da adulti ha evidenziato la presenza di un grave trauma infantile. Il dialogo sensoriale ed emotivo fra madre e feto infatti si instaura durante la gravidanza, per cui, anche nel caso di maternità surrogata, si forma un vero e proprio legame madre-figlio. Inoltre, secondo le moderne teorie sull’epigenetica, l’espressività genetica viene modulata dall’ambiente che per il feto è rappresentato dalla madre che lo porta in grembo. Esperimenti condotti su animali hanno dimostrato che le madri e i cuccioli si riconoscono immediatamente dall’odore e dai suoni emessi, in linea con le ricerche sopra citate ed effettuate in campo umano. Cambiare la figura di riferimento, che per il neonato è soltanto la propria madre, può risultare pericoloso per la sua integrità psichica. Oltre a questo bisogna considerare le ripercussioni psichiche sulle donne, che hanno ceduto i figli portati in grembo. Spesso si verificano patologie psichiatriche di natura depressiva, che possono portare al suicidio. Un figlio ottenuto mediante maternità surrogata, una volta diventato adulto e venuto a conoscenza della sua reale origine, potrebbe vedere nei genitori sociali o biologici quasi degli aguzzini, nei confronti della propria madre surrogata.
L’assenza di una figura paterna, nel caso di figli di donne single o di coppie lesbiche, può avere ripercussioni altrettanto gravi, perché, secondo gli psichiatri, la figura paterna aiuta il bambino a comprendere le abilità sociali necessarie a vivere nel mondo esterno, nonché il senso del limite e del controllo. Inoltre la figura paterna aiuta a sostenere la frustrazione e a costruire l’autostima. L’assenza del padre determina un notevole senso di vulnerabilità, che può dare luogo a pensieri catastrofici riguardanti determinati accadimenti o la propria salute (con il rischio di cadere nell’ipocondria).
I sostenitori della gestazione per altri, della stepchild adoption o della genitorialità dei single dovrebbero seriamente prendere in considerazione i risultati di studi come quelli appena citati e ricordare che avere dei genitori è un diritto, mentre avere dei figli non lo è mai stato. In realtà al loro figlio mancherà per sempre un genitore.
Rosanna Novara Topino
(seconda puntata – fine)



