Divinamente Acqua

l’acqua è uno degli elementi simbolici più forti. L’acqua è vita, è
purificazione, è unione con il divino. In India è l’acqua del Gange, fiume
sacro per antonomasia, ad attrarre milioni di persone. Proviamo a spiegare il
significato di questo rapporto che è fisico e spirituale.
.jpg) Parlare e scrivere di India non è semplice, considerata la complessità
Parlare e scrivere di India non è semplice, considerata la complessità
culturale e filosofica del paese asiatico. Pur tra innumerevoli contrasti, esso
rimane la più grande democrazia al mondo, intrisa ancora di una profonda
dimensione spirituale, dove si percepisce un «intimo» rapporto tra l’uomo e le
forze divine, tra il microcosmo e il macrocosmo. Un misticismo che sopravvive
in maniera diffusa, sebbene l’influsso di alcune tendenze culturali, tipiche
dell’Occidente, stia scompaginando antiche tradizioni e valori millenari, come
a suo tempo rilevato dall’orientalista Giuseppe Tucci, quando scrisse che «l’India
ha cambiato più in quindici anni che in quindici secoli». Un’affermazione che
riguardava il periodo tra il 1925 e il 1940, epoca in cui si potevano già
scorgere diversi episodi di mera imitazione di modelli stranieri. Tuttavia,
andando oltre le mode di Bollywood e le avanguardie tecnologiche di Bangalore,
l’India rimane una terra avvolta da una profonda devozione, al di là di
avvenimenti caratterizzati da intolleranza religiosa, che in molti casi
nascondono motivazioni politiche e questioni intee di potere.
Nel subcontinente indiano, materia ed energia, uomo e
infinito s’incontrano a un livello molto sottile, osservabile nella vita
quotidiana di milioni di abitanti, da Nord a Sud. Infatti, l’induismo (San?tana-Dharma, Legge
eterna) si manifesta attraverso un’ortoprassi che consiste in una serie di
norme che regolano ogni aspetto dell’esistenza di un devoto, a cominciare dalle
abluzioni del mattino sino alle p?j? (offerte di fiori, frutta, foglie, riso, dolci e
acqua) alle divinità. Soprattutto nei luoghi considerati sacri, come Varanasi
(Benares) e Haridwar, si tocca con mano proprio questa profonda spiritualità,
in particolare, se ci si avvicina al Gange.
L’acqua
metafora della vita
Nell’antico testo induista Taittir?ya-Sa?hit? si legge: «L’acqua è la più grande nutrice ed è quindi
come una madre». I fiumi in India sono considerati le dimore degli dei. L’acqua
è simbolo di vita, oltre che di purificazione e di guarigione per molti popoli
(si pensi, per esempio, all’acqua benedetta della sorgente della Grotta di
Lourdes che alimenta le fontane, il cammino dell’acqua e il bacino destinato
alle piscine). Nel subcontinente indiano la centralità dell’elemento acqua
assume risvolti singolari ed è oggetto di una devozione che probabilmente non
ha eguali altrove.
Per i fedeli indù tutti i fiumi indiani sono avvolti da
un alone di sacralità: la loro corrente, simbolo del flusso della vita, si
rinnova dalla sorgente sino all’oceano, dove incontra le altre acque,
perdendosi in esse. Una metafora ben descritta dal poeta e mistico indiano Tuls?d?s
con queste parole: «Quando confluisce nell’acqua dell’oceano, l’acqua del fiume
s’acquieta, come l’anima quando trova il Signore». L’esistenza della corrente
del fiume è transitoria, proprio come la vita degli esseri umani, ma è
bagnandosi alla sorgente dei fiumi che l’essere umano trova la sua sorgente
spirituale. L’importanza in India dei corsi d’acqua è anche testimoniata dal
fatto che, spesso, un luogo di pellegrinaggio viene definito t?rtha, ovvero «guado» o
ancora t?rtha-y?tr?, «guado sacro».
Il fiume più venerato è il Gange, che incarna l’energia
divina ed è esso stesso divinità, onorato da milioni di indiani, in quanto
fonte di vita, non soltanto punto di transito da una città a un’altra, ma anche
canale di interconnessione fra la terra e i cieli. È così importante che gli
indiani hanno composto un’ode, il Gangastothra-sata-namavali, dove
vi sono ben 108 nomi attribuiti al fiume Gange (come viene raccontato
dall’ecologista Vandana Shiva nel libro Le guerre dell’acqua).
Nei luoghi sacri lambiti dal Gange si vedono, in
particolari momenti della giornata, uomini e donne di ogni età intenti nelle
abluzioni. In riva al fiume, sui larghi scalini (chiamati gh??) di pietra, grazie ai quali si discende nelle acque, si
osserva il fermento devozionale: sfilate di fedeli compiono il rito della p?j?, con offerte di
coloratissimi fiori profumati e lumini accesi. Bagnarsi nelle acque del Gange,
secondo gli induisti, permette di rimuovere tutte le impurità dell’anima,
generate da azioni non virtuose. Immergersi in esso significa essere accolti
dalla divinità. Un atto compiuto per rigenerarsi, eliminando dal proprio karma qualsiasi forma di
negatività.
Quando
la realtà si confonde col mito
La devozione che gli induisti nutrono verso i fiumi si
percepisce soprattutto in occasione del Kumbha-mel?. Si tratta di un evento che
si svolge, secondo precisi cicli astronomici, in quattro diverse località
indiane: Haridwar, Nashik, Ujjain e Allahabad (chiamata anche Prayag, parola
che significa «confluenza dei due fiumi», infatti qui confluiscono il Gange e
lo Yamuna). Luoghi che si rifanno alla mitologia induista. Per comprendere ciò
che avviene in occasione del Kumbha-mel? è infatti necessario ritornare al mito: senza di esso ciò
che accade sarebbe impenetrabile.
Questo racconto mitologico – riportato nelle antichissime
scritture vediche chiamate Purana e nel testo epico Mah?bh?rata – è strettamente collegato
al mito induista della creazione dell’universo. Si narra che Vi??u, una
delle tre divinità (Trim?rti) induiste più importanti insieme a Brahm? e a ?iva,
riuscì a riconciliare dèi (Deva) e anti-dèi (Asura), dopo un’aspra lotta, in
cambio della loro partecipazione alla creazione del mondo. Deva e Asura si
unirono, e servendosi del monte Mandara appoggiato sul dorso della tartaruga Ak?para,
presero il serpente V?suki come corda e iniziarono ad agitare l’oceano cosmico.
Ne ricavarono l’ám?ta, il nettare dell’immortalità, racchiuso
all’interno di una brocca (kumbh). Al momento della creazione dell’universo nacquero
creature, esseri celesti, la luna e altro ancora. Ma il patto iniziale fra Deva
e Asura si spezzò innescando un altro scontro per il possesso del nettare di
lunga vita. Durante questa lotta, che durò per 12 giorni e 12 notti, alcune
gocce di ám?ta caddero sulla Terra, in corrispondenza di alcuni
fiumi e città.
Secondo il mito l’ám?ta toccò le città, divenute
sacre, di Nashik, Ujjain, Haridwar e Allahabad. Questi sono i quattro siti dove
ogni 12 anni, a rotazione, ha luogo il grandioso raduno del Kumbha-mel?.
Questo intervallo ciclico si spiega con la credenza
secondo cui 12 anni per l’uomo corrispondono a 12 giorni per le divinità. Da
qui l’usanza di celebrare questo festival ogni 12 anni in ognuno dei quattro
luoghi sacri, lungo le rive del fiume Godavari a Nashik, del fiume Kshipra a
Ujjain, del Gange a Haridwar, e alla confluenza tra Gange, Yamuna, e il
Saraswati a Allahabad.
Tra la
moltitudine dei fedeli
Il Kumbha-mel? è la festa più mistica di tutto il subcontinente
indiano, a cui accorrono milioni di fedeli (si parla di 10 milioni). Le
immersioni sacre vengono effettuate secondo un calendario specifico, le cui
date sono scelte in base a precisi calcoli astrologici, stabiliti considerando
sia la posizione del Sole, sia quella del pianeta Giove, che caricano l’acqua
di energie positive. Grazie a queste «irradiazioni benefiche», l’immersione nel
fiume permette al fedele di ritrovare salute, prosperità e il suo karma viene purificato da
ogni contaminazione. Chi compie le abluzioni rituali durante il Kumbha-mel? può
raggiungere inoltre la liberazione (mok?a o anche mukti), interrompendo il
ciclo delle morti e rinascite.
Questa impressionante riunione di fedeli, è l’occasione
migliore per capire l’essenza spirituale dell’India.
Si vede una folla immensa di uomini e donne che
inneggiano a ?iva e ad altre divinità indiane, pronte poi a immergersi a tuo
nella corrente tumultuosa.
Ad Haridwar, si possono scorgere nitidamente le catene
collegate lungo i gh?? o
penzolanti dai ponti, a cui si appigliano i pellegrini per non venire travolti
dalle acque del Gange, spesso impetuose. Durante i Kumbha-mel?
s’incontrano poi personaggi solitamente irraggiungibili e questo è uno degli
elementi centrali che rendono questa festa un evento unico, eccezionale.
Soltanto in questi giorni si possono vedere i misteriosi e talvolta inquietanti
Naga, in genere nascosti negli anfratti impervi dei monti himalayani. Un
rifugio che abbandonano soltanto in particolari circostanze. Sono uomini votati
all’eremitaggio, che si mostrano di rado, completamente nudi, per testimoniare
il loro distacco totale dal mondo e dagli attaccamenti terreni, coperti solo da
una coltre di cenere, simbolo dello stadio ultimo dell’esistenza. Oltre a loro
sono numerosi i s?dhu, gli asceti, e i samny?sin, monaci erranti che hanno
abbandonato ogni bene materiale per vivere solo di pura spiritualità.
Haridwar,
la porta divina
Haridwar rimane una delle città più sacre dell’India del
Nord, protetta dalla trinità indù: Brahm?, ?iva e Vi??u. La
città, sorta alle pendici dell’imponente catena montuosa dei Shivalik, è detta
la «porta del Gange», poiché è il primo luogo dove il sacro fiume incontra la
pianura, dopo essere sceso dalle vette dell’Himalaya.
La vita ad Haridwar pullula attorno al Gange; non a caso,
la struttura urbana si distende lungo le sue rive, dove si trovano i gh??, che permettono di raggiungere le acque. Il più
importante è situato accanto al tempio dove, narra la leggenda, è custodita
l’impronta del piede di Vi??u. Ad Haridwar, essendo una delle città più sacre
dell’India, si radunano migliaia di devoti per i riti di abluzione, o per
adempiere alle cerimonie di cremazione dei defunti. Qui si percepisce la forte
sensazione di essere parte di un immenso flusso esistenziale. Lungo le rive del
fiume il ciclo della vita e della morte si intreccia con la potenza dei quattro
elementi della natura, in occasione dei riti funebri: il fuoco lentamente
consuma il corpo, la terra sostiene il feretro, il vento alimenta le fiamme e
l’acqua trasporta le ceneri nella corrente eterna scandita da un inizio e da
una fine.
La
sacra confluenza
In tempi antichi, era conosciuta con il nome di Prayag,
che in sanscrito significa «luogo del sacrifico», ma è più comunemente chiamata
Allahabad, anch’essa città santa per gli indù. La sua peculiarità è quella di
essere situata alla confluenza dei fiumi Gange e Yamuna, oltre che, narra la
mitologia, del Saraswati, improvvisamente scomparso, che tuttavia ancora
scorrerebbe, invisibile, sotto il suolo e si unirebbe alle altre due correnti
sacre.
Questo importante centro spirituale è talmente rispettato
che il 12 febbraio 1948 furono versate parte delle ceneri del Mahatma Gandhi
proprio alla convergenza dei tre fiumi. «Coloro che si bagnano alla confluenza
dei corsi d’acqua vanno in cielo; coloro il cui spirito è saldamente eretto e
che muoiono qui, raggiungono l’immortalità», si legge nei Rig Veda, uno dei quattro
libri che compongono i Veda, antichi testi rivelati dagli dèi ai ??i, gli uomini saggi. Ad Allahabad, proprio come a
Haridwar, sembra che le differenze tra ricchi e indigenti si annullino,
nell’istante in cui i devoti s’immergono nella sacralità delle acque.
Kumbha-mel?
2015
Nel 2015 Giove e il Sole sono nel segno zodiacale del
Leone e quindi il Kumbha-mel? sarà celebrato a Nashik. Le celebrazioni più importanti
si terranno dal 14 luglio sino al 25 settembre. Situata nel Maharashtra,
nell’India centro-occidentale, a circa 200 km da Mumbai, la città è
attraversata dal sacro fiume Godavari, lungo il quale vi sono templi e gh??. Ma il luogo forse più santo per i fedeli è
Trimbakeshwar, uno dei 12 Jyotirlingas dell’India, ovvero uno dei simulacri della
manifestazione di ?iva nella sua forma di luce infinita. Si narra anche che sia
il luogo in cui nacque Ganesha (chiamato anche Ganapati), il famoso dio
raffigurato come essere umano dalla testa di elefante: una rappresentazione
dell’unità del piccolo essere (microcosmo) che è l’uomo e il grande essere
(macrocosmo) simboleggiato dall’elefante. È proprio a Trimbakeshwar che si
svolgono i rituali principali del Kumbha-mel? 2015, in particolare presso
Kushavarta. Secondo le credenze locali, bagnarsi in questo luogo significa
annullare i propri peccati. Da qui le folle di devoti che si immergono nelle
acque del Godavari. Una scena che si ripete lungo i gh?? di Ujjain, Haridwar e Allahabad. Le moltitudini di
fedeli che accorrono ai Kumbha-mel? e ad altre celebrazioni sacre indiane esprimono qualcosa
che va oltre la dimensione religiosa. Sono eventi di importanza sociale i
pellegrinaggi, poiché ad essi possono partecipare tutti, bambine, bambini,
giovani, anziani, donne, uomini, senza alcuna distinzione di casta.
Donna, è colpa tua, agosto-settembre 2014.
Silvia C. Turrin




 Toiamo a parlare di
Toiamo a parlare di

 Diario di un giovane
Diario di un giovane
 23 settembre
23 settembre 28 settembre
28 settembre




 In margine al
In margine al


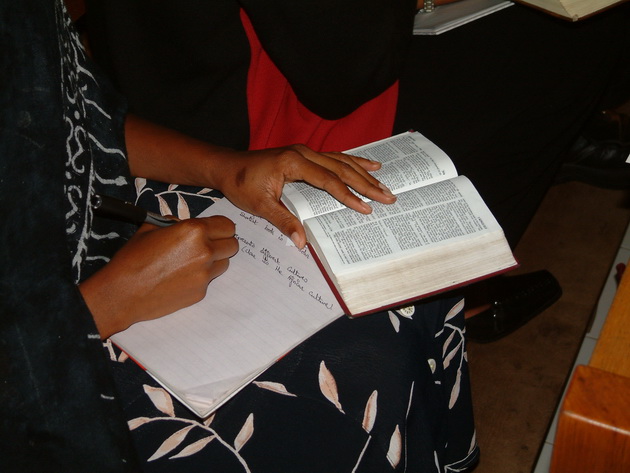
 B) Sensus
B) Sensus

 Comincio commentando tre frasi. La prima di Paolo VI che
Comincio commentando tre frasi. La prima di Paolo VI che Chibly Langlois,
Chibly Langlois,













 Dopo
Dopo Proprio come Kunta
Proprio come Kunta
 Sheriff e Sekou sanno di essere stati comunque più
Sheriff e Sekou sanno di essere stati comunque più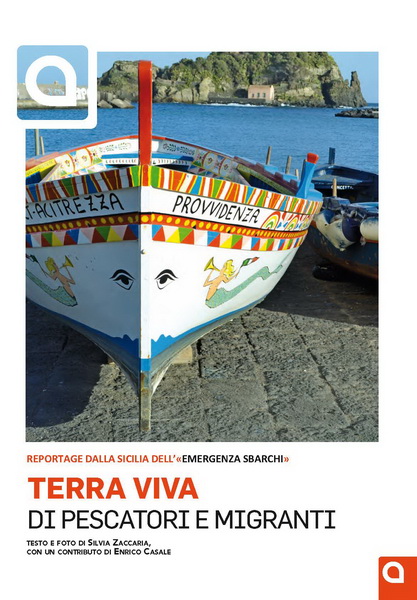



 Tappa di passaggio per naviganti della mitologia antica,
Tappa di passaggio per naviganti della mitologia antica,

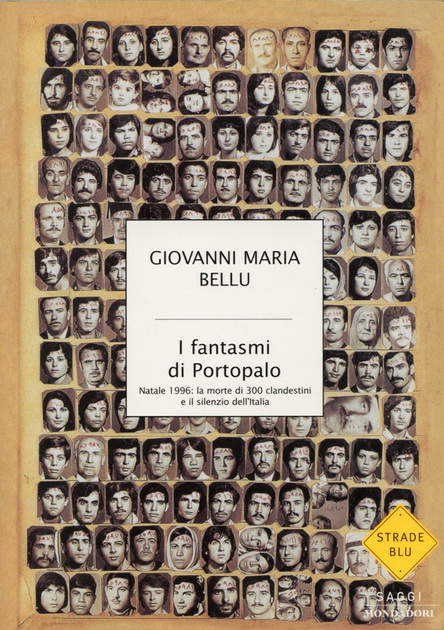






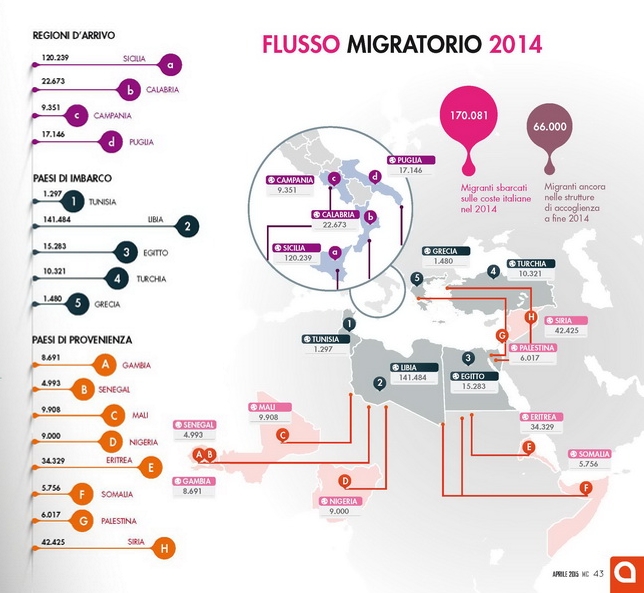

(1).jpg)

(1).jpg)
 Sì, nel 1930 partii per il Giappone
Sì, nel 1930 partii per il Giappone