Biodiversa è meglio
Manaus 2015: Forum sulla Biodiversità
 Sommario
Sommario
1. Difendiamo i colori
del mondo
2. La biodiversità indigena
3. Aree protette e
popoli indigeni
4. La voce delle imprese
idroelettriche (Uhe)
5. Lince pardina chiama
tonno rosso
Biodiversità e Popoli indigeni
1. Difendiamo i colori
del mondo
Per parlare di
biodiversità l’Amazzonia è il luogo ideale. Non esiste altro posto al mondo che
ne ospiti di più. L’Amazzonia e la sua biodiversità sono però in grave
pericolo, a causa dell’azione umana. Preservare la diversità della vita è
sempre più complicato, ma forse non impossibile. Il primo passo è il rispetto
dei popoli indigeni, per i quali la natura è una «casa» e non una «miniera» da
sfruttare.
Manaus. Sono parecchie le donne indigene
venute al Fórum social mundial da biodiversidade pensando di vendere i
loro prodotti artigianali (bigiotteria, oggetti in legno, tessuti), ma l’evento
non ha richiamato molta gente. Il Centro de convenções Vasco Vasques di Manaus,
costruito a lato della Arena Amazonas (lo stadio degli ultimi campionati
mondiali di calcio), è accogliente, luminoso e funzionale, ma partecipanti e
visitatori quasi si perdono negli spazi della struttura.
Un vero peccato, perché le
tematiche messe in agenda dagli organizzatori sono del massimo interesse:
difesa dell’Amazzonia e della biodiversità, diritti umani, cambiamenti
climatici, agroecologia, sicurezza e sovranità alimentare, economia solidale e
lavoro degno, bioetica, ambiente e progetti idroelettrici. Organizzato da una
serie di realtà sindacali, movimenti sociali e cornoperative, il Forum sulla
biodiversità si inserisce nella tradizione dei Forum sociali mondiali nati nel
2001 a Porto Alegre, nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul.
Da qui proviene Lélio Luzardi Falcão, già proiettato
sugli eventi futuri: a gennaio 2016 il Forum toerà infatti a Porto Alegre. Più
concentrata sul presente è Rosane Pinheiro da Silva, che nega la scarsa
partecipazione all’evento di Manaus: «Abbiamo fatto tutto senza soldi e senza
l’aiuto che sponsor e autorità ci avevano promesso. Nonostante ciò siamo
riusciti a coinvolgere 5 mila persone». Probabilmente i numeri non sono quelli
della vulcanica Rosane. Certamente al Forum sulla biodiversità la
partecipazione degli indigeni è significativa. Sono venuti per parlare, per
ascoltare o anche soltanto per vendere, ma tutti con l’orgoglio
dell’appartenenza.
La lotta dei
Munduruku contro la prepotenza del potere
Da anni in Brasile si litiga sulla
proliferazione delle grandi centrali idroelettriche (usinas hidrelétricas)
previste dal Pac, il Piano di accelerazione della crescita (Programa de
aceleração do crescimento) ideato dal governo Lula e proseguito da Dilma.
Molte centrali sono già in funzione, altre sono in costruzione o in fase di
progetto, sempre in un mare di polemiche, principalmente per due motivi: perché
le opere producono grandi impatti ambientali e perché troppo spesso sono localizzate
in terre abitate da popolazioni indigene. La questione non poteva dunque
mancare al Forum di Manaus.

Roseninho Saw è un giovane indigeno
munduruku. Il popolo dei Munduruku conta circa 12 mila persone. Vive negli
stati di Amazonas e Mato Grosso, ma soprattutto nella regione Sud del Pará
lungo il fiume Tapajós e i suoi affluenti. Sul Tapajós il governo di Brasilia
ha in programma la costruzione della centrale di São Luiz, che dovrebbe
diventare la terza più grande del paese. L’opera comporterà l’allagamento della
terra Sawré Muybu, appartenente ai Munduruku (anche se essa non è ancora
ufficialmente demarcata). Oltre a ciò, sconvolgerà le modalità di vita della
popolazione, considerando che si inserisce in un progetto complessivo che, nel
bacino idrografico del Tapajós e del Tele Pires, prevede la costruzione di ben
nove centrali.
Roseninho Saw parla senza alzare la
voce, ma le sue parole sono dure come pietre. «Io chiedo: se il governo
considera l’energia tanto importante, perché non fa un progetto migliore, che
non preveda la distruzione della nostra foresta? Il governo sta cercando di
dividere il nostro popolo: comunità contro comunità, associazioni contro
associazioni. Ma noi indigeni parliamo una sola lingua e abbiamo il consenso
anche della popolazione ribeirinha e di quella che vive nei municipi
coinvolti». Roseninho parla di diritti non rispettati, ad iniziare dall’obbligo
di consultazione, previsto dalla Convenzione 169 sui popoli indigeni.
«Ci dicono – conclude il giovane
leader munduruku – che l’energia andrà anche a nostro beneficio. Ma non è così:
l’energia sarà per gli imprenditori, i proprietari terrieri e i produttori di
soia. Per noi la foresta è vita, casa, piante medicinali. Per tutto questo la
lotta non può fermarsi». Il pubblico presente, composto in buona parte da
indigeni, apprezza salutando l’oratore con applausi e rulli di tamburi.
 Se la biodiversità sta (anche) nel nome
Se la biodiversità sta (anche) nel nome Meno arrabbiate di Roseninho Saw
Munduruku sono tre simpatiche signore indigene che hanno allestito banchetti
artigianali negli ampi spazi del Centro di convenzioni Vasco Vasques. Indossano
copricapi, orecchini e collane, tutti coloratissimi. Sono meno arrabbiate, ma
non meno orgogliose del loro essere indigene.
Maria Valda Feitosa (Martequi, in
lingua indigena) è tikuna. «Nella nostra comunità – dice – siamo più di mille
persone. Non c’è acqua potabile, la luce è una calamità e il medico viene
soltanto una volta alla settimana quando non è impegnato altrove. Se abbiamo
necessità di una cosa urgente, è necessario venire a Manaus. Per raggiungerla
dobbiamo prendere la lancia che, andata e ritorno, costa 12 reais a persona.
Come può sostenere questo costo una famiglia?».
Maria do Carmo Rarê (Hari Wor) è sateré mawé. «Non è
vero che le istituzioni pubbliche aiutano gli indigeni. La sanità è gratuita,
ma pessima. I medici non hanno mai le medicine. Come le nostre scuole non danno
mai la merenda ai nostri ragazzi». E aggiunge: «Siamo discriminati in quanto
indigeni. Ad esempio, se io salgo su un autobus di Manaus con questi vestiti e
queste pitture sulla pelle, la gente si dà delle gomitate. Pensa che sia una
cosa da drogati, mentre per noi dipingersi è un atto di felicità. Anni fa,
quando io avevo circa 30 anni, feci un colloquio di lavoro e lo superai. Quando
mi presentai per iniziare, il datore di lavoro vide i miei tattuaggi e con una
scusa mi disse di tornare a casa e che mi avrebbe richiamato più avanti. Ci
rimasi malissimo dato che avevo bisogno di quel lavoro. Tuttavia, non mi sono
mai arresa davanti alle avversità perché sono una guerriera come la gran parte
delle donne indigene». Una guerriera divenuta sportiva: Hari Wor è stata più
volte campionessa indigena della specialità «arco e freccia». Come dice lei,
scherzando sulla sua età, è la «vovó de arco e flecha», la nonna dell’arco e
della freccia.
Wall França (Wytá) viene da una
famiglia con papà xavante e mamma sateré mawé. «Sì, è vero, spesso c’è
discriminazione nei confronti di noi indigeni. Anche per questo sono grata agli
organizzatori del Forum sociale che ci hanno dato la possibilità di venire qui
a far conoscere il nostro lavoro artigianale».
Le tre donne appartengono a gruppi
etnici diversi, ma i loro nomi indigeni fanno tutti riferimento alla natura:
Martequi significa «macchia di leopardo», Hari Wor indica la «termite bianca»,
Wytá sta per «uccellino». Non si tratta di una banale tradizione, ma di un dato
culturale che evidenzia l’intima connessione dei popoli indigeni con la madre
terra. Stesso discorso vale per i prodotti artigianali che le signore indigene
vendono. Tutti rimandano alla natura dell’Amazzonia. O perché sono fatti con
materie vegetali o perché raffigurano animali.
La foresta: come «casa»
o come «miniera»
Ezequiel Feandes André – in
lingua indigena Yauatucü, «foglia verde» – è un giovane tikuna di Tabatinga. È
venuto a Manaus per studiare psicologia all’Università.
«Nei nostri confronti ci sono
preconcetti e discriminazioni. E razzismo. Inoltre, la mia gente patisce lo
shock culturale di trovarsi schiacciata tra due filosofie, quella indigena e
quella dei non indigeni. Io ho scelto di studiare psicologia anche per riuscire
a capire gli uni e gli altri».
In quest’ottica delle due filosofie
Ezequiel spiega la diversa attitudine nei confronti della biodiversità. «Per
esempio, a differenza del capitalismo, noi dobbiamo preservare la natura e
avere cura della nostra casa che è la foresta da cui noi ricaviamo alimenti e
benessere».
Anche Henoc Pinto Neves, 33 anni, è
tikuna. «Sono tikuna nell’anima e nel sangue – dice -. Non mi vergogno a
esserlo, né a dirlo a chiunque». Magari anche a quel sindaco che, qualche anno
fa, gli disse che un indio non ha la capacità di diventare dottore. Nel 2012
Henoc si è laureato in biomedicina e oggi è un analista clinico.
Con le idee chiare anche sull’Amazzonia,
«un patrimonio da difendere strenuamente. Noi indigeni abbiamo cura della
natura ed essa ci ricompensa ampiamente quando peschiamo, cacciamo e
coltiviamo. Al contrario di noi, il bianco pensa soltanto a sfruttae le
risorse senza preoccuparsi del futuro».
Eledilson Corrêa Dias, genitori
kaixana e tikuna, si nota più degli altri. Alto, magro, torso nudo, una grossa
e rumorosa collana di conchiglie al collo, un copricapo di piume in testa, ma
soprattutto il volto dipinto di color nero pece. Proviene dall’Alto Solimões,
municipio di Santo Antônio do Içá, ma adesso risiede con la famiglia alla
periferia di Manaus.
«Sono venuto a Manaus perché voglio
che i miei tre figli studino. Perché, dopo gli studi, possano far valere i
nostri diritti come promotori di giustizia, avvocati o giudici. Il governo
brasiliano deve ricordare che noi siamo popoli originari e che stiamo qui da più
di 600 anni. In passato ci hanno ucciso e massacrato. Oggi ci disprezzano.
Vogliamo che i nostri diritti passino dalla carta alla pratica».
Anche dalle sue parole esce una
foresta intesa come «casa», lontanissima dalla concezione dei bianchi, che la
vedono invece come una «miniera» da sfruttare.
In lingua indigena il nome di
Eledilson è Kauixe, che – tanto per confermare la simbiosi con la natura –
significa «albero grande e forte». «Noi siamo nati nella natura. Noi facciamo
parte di essa. Se la distruggiamo, distruggiamo noi stessi». •
Sono tempi duri per i
popoli indigeni del Brasile. Le loro terre sono invase o sotto assedio. Le loro
modalità di vita si stanno perdendo o vengono messe in discussione. Difendere i
popoli indigeni significa difendere anche la biodiversità. Al loro fianco, in
una battaglia che pare improba, si sono schierati Laurindo e Gilmara, una
coppia di volontari rispettosa delle diversità, competente e appassionata. Ecco
cosa ci hanno raccontato.
Tabatinga. Gilmara Feandes e Laurindo Lazzaretti sono una di quelle coppie che ti
fanno dire: «Si sono trovati». Tanta è la complicità, il desiderio di camminare
assieme verso una meta comune: la difesa dei popoli indigeni e delle loro
modalità di vita. Hanno chiamato il loro figlio – oggi ha un anno – Giovani
Kamuu, dove la seconda parola significa «sole» in lingua wapixana. Dopo varie
esperienze a Roraima, Gilmara e Laurindo ora lavorano con il Conselho
indigenista missionário (Cimi) nella Vale do Javari, una terra indigena
abitata da vari popoli: Matsés, Matis, Kulina-Pano, Korubo, Marubo, Kanamari e
anche alcune etnie isolate.
Secondo voi, in Amazzonia quali sono i
maggiori pericoli per la biodiversità?
«La domanda
mondiale di beni naturali, le cosiddette materie prime, fa sì che l’Amazzonia
sia vista come una grande fonte di guadagni. L’intervento umano per l’apertura
di strade, la fondazione di centri urbani, la costruzione di enormi dighe per
la produzione di energia elettrica, la sfrenata ricerca di minerali di tutti i
tipi, l’occupazione di spazi per la produzione di alimenti destinati al mercato
mondiale rappresentano una grande minaccia per i differenti biomi dell’Amazzonia.
È necessario trovare modalità diverse d’azione altrimenti tutto è a rischio, a
iniziare dalla stessa sopravvivenza della specie umana».
È giusto affermare che i popoli indigeni
sono i primi difensori della biodiversità? E che, proteggendo le loro caratteristiche
esistenziali, si difende al tempo stesso la biodiversità?
«Per i popoli
indigeni i fiumi, i laghi, le montagne, le pietre hanno vita. La foresta è
piena di spiriti della vita. Difendere questo spazio sacro significa dunque
difendere la continuità dell’esistenza.
Le vite degli
animali della foresta, di pesci e tartarughe nei fiumi e nei laghi sono
sinonimo di più vita umana. La morte o la scomparsa di altre specie significa
mettere a rischio anche la vita umana e l’esistenza di un popolo. Per i popoli
indigeni la vita umana è inconcepibile senza la diversità di altre vite attorno
a essa. Per loro è vitale e unico difendere la biodiversità, perché è la
garanzia per continuare a esistere sulla terra.
Ci sono popoli
che sono stati sradicati dal loro ambiente e adesso vagano da un luogo a un
altro, senza meta, senza gioia, senza speranza. Altri hanno dovuto adattarsi
per sopravvivere. Tutti hanno in comune il sogno di tornare un giorno nella
loro terra promessa dove c’è vita in abbondanza. Possiamo qui ricordare la
tristissima vicenda dei Guarani Kaiowá, che sono stati espulsi dalle loro
terre, in cui abitavano lungo la costa del Brasile e nella parte centrale. Oggi
vivono in campi ai margini delle autostrade (è l’etnia indigena con il più
alto tasso di suicidio, ndr)».
 Sembra che i governi Lula e Dilma abbiano
Sembra che i governi Lula e Dilma abbiano
lavorato per favorire l’agrobusiness (soia, allevamenti, piantagioni, ecc.) e
lo sfruttamento delle risorse naturali (foreste, sottosuolo, ecc.) a discapito
degli ecosistemi e dei diritti dei popoli indigeni. Qual è la vostra opinione
al riguardo?
«Noi avevamo
una grande speranza nella piattaforma di governo del Partito dei lavoratori (Partido
dos trabalhadores, Pt). I valori fondamentali erano l’eguaglianza delle
opportunità e la lotta alle disparità che rendono i ricchi sempre più ricchi e
i poveri sempre più poveri.
Il Brasile
usciva da governi per i quali le privatizzazioni rappresentavano l’unica
opzione di politica economica. In quel contesto aveva assunto il comando del
paese prima il governo Lula (dal 2003 al 2010) e poi Dilma (dal 2011).
Molte cose buone sono state fatte, ma davanti alle ingiustizie dei grandi
capitalisti ci sono state troppe battute d’arresto. In nome della governabilità
sono stati concessi spazi ancora più vantaggiosi alle grandi imprese. In nome
di una certa idea di sviluppo finiscono per aprire spazi nella legislazione a
imprenditori che non si fermano davanti agli ecosistemi, spinti come sono
dall’unico desiderio di massimizzare i loro profitti. Pressioni inteazionali
e dell’oligarchia nazionale rendono il governo debole, non rappresentativo e
sempre coinvolto in scandali. Questa posizione fa sì che le classi più
svantaggiate si sentano di nuovo completamente impotenti. La grande delusione,
quindi, nasce dal fatto che il partito e i suoi eletti non hanno risposto alle
aspettative. Per esempio, realizzare finalmente la tanto attesa riforma agraria
e garantire i diritti alle popolazioni indigene di questo paese. Purtroppo,
niente di tutto questo accadrà e quindi dovremo continuare a lottare e a
sognare.
Oggi il
governo Dilma è fortemente legato ai gruppi agricoli, ai grandi proprietari
terrieri e ai produttori di monocoltura, come dimostra il curriculum della
nuova ministra dell’agricoltura (la latifondista Kátia Abreu, ndr).
Contando i parlamentari evangelici, la camera e il senato federale sono in mano
ai rappresentanti dei gruppi politici ed economici che vedono i popoli indigeni
e le loro terre come un ostacolo allo sviluppo del Brasile. Nel corso degli
ultimi quattro anni, grandi lotte sono state combattute in campo legislativo e
giudiziario per abbattere o quantomeno ridurre i principali diritti dei popoli
indigeni, come ad esempio la garanzia sulle proprie terre.
La
Costituzione federale ha festeggiato il suo 27mo anno di promulgazione: con
essa, nel 1988, i popoli indigeni cominciarono a essere riconosciuti (articolo
231). È proprio per difendere quanto conquistato che oggi il movimento indigeno
si è organizzato e unito nella lotta».
Dire che l’invasione fisica e culturale dei
bianchi è passata anche attraverso un uso distorto della religione è
un’affermazione veritiera?
«Qualsiasi
presenza religiosa che non riconosca e non rispetti le modalità di vita dei
popoli indigeni è nociva. In molti hanno eliminato simboli religiosi, credenze
profonde, luoghi sacri, lasciando i popoli indigeni in un vuoto esistenziale
che li ha spesso condotti ai bordi delle strade o delle discariche, o nelle
periferie delle città. Gli evangelici sono i primi responsabili, ma in passato lo
hanno fatto anche molti cattolici».
Voi lavorate con il Cimi, un’istituzione
della chiesa cattolica brasiliana molto nota per la sua combattività. Per
evitare gli errori del passato, in che modo vi relazionate con i popoli
indigeni?
«Oggi la
chiesa cattolica e il Cimi lavorano per la formazione delle coscienze, per il
rispetto della diversità della vita sulla terra e per la costruzione dei
diritti in uno stato rappresentativo e rispettoso. Noi lavoriamo anche per
organizzare la speranza e per non lasciare che le forze che distruggono la vita
prevalgano sul bene.
In
particolare, nel nostro servizio ai popoli indigeni, noi cerchiamo di
sviluppare un dialogo interreligioso, di rispetto e valorizazione dei costumi,
di promozione della dignità, dell’autonomia e del protagonismo dei popoli
indigeni affinché essi siano soggetti della loro storia.
Continueremo a
essere una voce che grida nel deserto o nel mezzo della foresta. Per dire che
l’ultima parola non è quella del mercato che tutto trasforma in merce o quella
dei prepotenti che vogliono dominare su tutto e tutti. La nostra meta è la vita
nel senso più ampio, completo e profondo. In una parola, il Bem viver».
Se ragioniamo però facendo prevalere il
pessimismo, il «Bem viver» pare soltanto uno slogan, magari bello e romantico
ma sempre slogan. Un po’ come «Um outro mundo é possível» dei Forum sociali
mondiali. Che potete dire al riguardo?
«Il Bem
viver è una proposta di vita presente in ciascun popolo indigeno. In essa
si ritrovano lingua, credenze, costumi, organizzazione sociale, consonanza con
la biodiversità.
Con la sua
prepotenza e il suo desiderio di universalità, il progetto economico
capitalista introduce nelle altre culture concetti e modi di vita estranei a
quelle popolazioni, rompendo l’armonia. Cercare il Bem viver significa
riprendere le vere tradizioni spirituali, economiche e organizzative.
Secondo noi,
il Bem viver sarà la salvezza dell’umanità, del pianeta terra, della
biodiversità». •
Aree protette e
popoli indigeni
3. ![]() I parchi hanno
I parchi hanno
bisogno dei Popoli
di Francesca Casella
(Survival Inteational)*
 In nome della
In nome della
«conservazione», molti popoli indigeni sono stati sfrattati da aree naturali di
cui da sempre sono i migliori custodi. Si tratta di una scelta profondamente
sbagliata: per i popoli e per l’ambiente.
Quasi tutte le aree protette del
mondo, siano esse parchi nazionali o riserve faunistiche, sono o sono state le
terre natali di popoli indigeni che oggi vengono sfrattati illegalmente nel
nome della «conservazione». Questi sfratti possono distruggere sia la vita dei
popoli indigeni sia l’ambiente che essi hanno plasmato e salvaguardato per
generazioni.
Spesso, le terre indigene sono
erroneamente considerate «selvagge» o «vergini» anche se i popoli indigeni le
hanno vissute e gestite per millenni. Nel tentativo di proteggere queste aree
di cosiddetta wildeess, governi, società, associazioni e altre
componenti dell’industria della conservazione si adoperano per fae «zone
inviolate», libere dalla presenza umana.
Per i popoli indigeni, lo sfratto
può risultare catastrofico. Una volta cacciati dalle loro terre, perdono
l’autosufficienza. E mentre prima prosperavano, spesso si ritrovano poi a
vivere di elemosina o degli aiuti elargiti dal governo nelle aree di
reinsediamento. Una volta privato di questi suoi tradizionali guardiani
indigeni, inoltre, anche l’ambiente può finire per soffrire perché il
bracconaggio, lo sfruttamento eccessivo delle risorse e i grandi incendi
aumentano di pari passo con il turismo e le imprese.
Con la campagna Parks Need
Peoples, il movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni
Survival Inteational denuncia il lato oscuro della
conservazione e spiega perché parchi e riserve hanno bisogno dei popoli
indigeni oggi più che mai.

Contro
i «selvaggi»
L’idea di preservare le aree di wildeess
attraverso l’espulsione dei suoi abitanti nacque in Nord America nel XIX
secolo. Si fondava su una lettura arrogante della terra che mancava
completamente di riconoscere il ruolo giocato dai popoli indigeni nel plasmarla
e alimentarla. La convinzione era quella che a sapere cosa fare per il bene
dell’ambiente fossero gli scienziati conservazionisti e che essi avessero il
diritto di liberarlo dalla presenza di qualsiasi essere umano. A promuovere
questo modello esclusivista dei parchi nazionali fu il presidente Usa Theodore
Roosevelt (1858-1919), secondo il quale «la più giusta fra tutte le guerre è
quella contro i selvaggi, sebbene si presti anche a essere la più terribile e
disumana. Il rude e feroce colono che scaccia il selvaggio dalla terra rende
l’umanità civilizzata debitrice nei suoi confronti… È d’importanza
incalcolabile che America, Australia e Siberia passino dalle mani dei loro
proprietari aborigeni rossi, neri e gialli, per diventare patrimonio delle
razze dominanti a livello mondiale».
Il primo parco nazionale della
storia è stato quello di Yellowstone, negli Stati Uniti. Quando fu creato, nel
1872, ai nativi che vi vivevano da secoli fu inizialmente permesso di restare,
ma cinque anni dopo furono costretti ad andarsene. Ne scaturirono battaglie tra
le autorità governative e le tribù degli Shoshone, dei Blackfoot e dei Crow. In
una sola e singola battaglia si dice siano morte 300 persone. Dettagli storici
come questo vengono spesso omessi o imbellettati per preservare il fascino del
parco. Tuttavia, tale modello di conservazione fondato sugli sfratti forzati è
diventato consuetudine in tutto il mondo e la visione di Roosevelt continua a
influenzare molte importanti organizzazioni conservazioniste, con impatti
devastanti non soltanto per i popoli indigeni, ma anche per la natura. In
un’intervista rilasciata nel 2003, Mike Fay, un influente ecologista della Wildlife
Conservation Society (www.wcs.org), dichiarava: «Nel 1907, quando gli Stati
Uniti si trovavano a un livello di sviluppo paragonabile a quello del bacino
del fiume Congo oggi, il presidente Roosevelt istituì 230 milioni di acri di
aree protette facendone un pilastro della sua [politica intea]… In pratica,
il mio lavoro nel bacino del Congo è stato quello di cercare di riprodurre il
modello statunitense in Africa». E se qualcuno fosse tentato di pensare che in
questo processo non si siano ripetuti gli eccessi che hanno flagellato i popoli
del Nord America, gli basterà una rapida scorsa alla storia recente di
persecuzione delle tribù pigmee dell’Africa Centrale per cambiare idea. A mero
titolo d’esempio, tra gli anni ’60 e ’80 le autorità congolesi hanno espulso almeno 6mila Batwa
dal «Kahuzi-Biega National Park». Un rapporto suggerisce che la metà di queste
persone sia morta in seguito agli sfratti, mentre i sopravvissuti versano in
cattive condizioni di salute (A. K. Barume, Heading Towards Extinction?, 2000).

Dall’Asia
all’Africa, l’altra
faccia delle aree protette
Nel mondo esistono oggi oltre
120.000 aree protette, pari al 13% della terra emersa. Anche se è impossibile
fare stime precise, le persone che sono state sfrattate dalle loro case nel
nome della conservazione, o che vivono sotto la minaccia incombente di sfratto,
sono molti milioni. La maggior parte sono popoli tribali.
Le aree protette si differenziano
per il grado di restrizioni a cui sono soggette ma, spesso, chi dipende dalle
risorse dei parchi si vede ridurre drasticamente ogni attività. I popoli
tribali devono cambiare stile di vita e/o trasferirsi altrove, il legame con i
territori e i mezzi di sostentamento viene reciso, e le possibilità di scelta
che vengono lasciate loro sono spesso nulle, o quasi.
Un caso esemplare è quello dei
Wanniyala-Aetto dello Sri Lanka, conosciuti anche con il nome di Vedda. Nel 1983,
i Wanniyala-Aetto, o «popolo della foresta», furono sfrattati dalla loro patria
che oggi prende il nome di Maduru Oya National Park. La tribù aveva già subito
ingenti perdite di terra a causa di dighe, coloni e deforestazione: il Maduru
Oya era il loro ultimo rifugio. Una volta estromessi dalla foresta dovettero
cambiare tutto, dal modo di vestirsi a quello di vivere, e furono costretti a
conformarsi alla società dominante, mentre i loro vicini e le autorità li
trattavano come «demoni» e «primitivi». La loro autosufficienza, legata alle
foreste, è andata perduta e oggi stentano a sopravvivere alla povertà e a tutti
i problemi ad essa connessi.
Poche comunità sono disposte a
rinunciare volontariamente a tutto il loro mondo per far spazio ai parchi. Ma
quando resistono, le conseguenze sono gravi. Ovunque, i popoli indigeni
denunciano pestaggi, arresti arbitrari, persecuzioni e persino torture.
Nelle terre dei Baka del Camerun
sudorientale sono state istituite alcune aree protette – comprendenti sia
parchi nazionali sia riserve di caccia sportiva – senza il loro consenso. Le
eco-guardie, in parte finanziate dal «Fondo mondiale per la natura» (Wwf) e dal
governo tedesco, non permettono ai Baka di praticare la caccia e la raccolta
nelle foreste che un tempo erano la loro casa, o addirittura di entrarvi.
Le eco-guardie, talvolta
accompagnate da personale militare, minacciano, arrestano e picchiano uomini,
donne e addirittura i bambini baka accusandoli di bracconaggio. Interi villaggi
sono stati rasi al suolo e molte persone baka sono state torturate. Secondo
varie testimonianze, anche fino a morie.
Nel maggio 2013, la Commissione
nazionale del Camerun per i diritti umani e la Fusion-Nature hanno
denunciato un raid anti-bracconaggio durante il quale sono stati torturati
dieci Baka, uomini e donne. Mancando strumenti concreti a difesa dei Baka,
nella maggior parte dei casi le eco-guardie possono agire impunemente.
Oltre ad avere l’effetto di
alienarsi le popolazioni locali, questa gestione militarizzata dei programmi di
conservazione non riesce a contrastare le cause politiche del mercato della
selvaggina e la corruzione che spesso lo sorreggono. Il bracconaggio
finalizzato al commercio della carne è organizzato da un network che include
personaggi influenti, che spesso usano il loro potere per mantenere i loro
circuiti di traffico liberi dai controlli. Benché esistano organizzazioni che
lottano contro il bracconaggio dei «colletti bianchi», l’obiettivo principale
delle eco-guardie rimangono le popolazioni locali. Essendo i meno potenti, i
Baka sono quelli colpiti più duramente.
Drammatica anche la situazione dei
Boscimani del Botswana. Storicamente, i Boscimani dell’Africa meridionale erano
cacciatori-raccoglitori. Oggi, la maggior parte delle comunità sono state costrette
ad abbandonare questo stile di vita, ma la «Central Kalahari Game Reserve» del
Botswana è ancora la casa degli ultimi Boscimani a vivere in gran parte di
caccia. Nel 2006, dopo una lunga battaglia legale contro il governo, l’Alta
Corte ha confermato il loro diritto di vivere e cacciare nella riserva.
Nonostante la sentenza dell’Alta
Corte, tuttavia, da allora i funzionari non hanno rilasciato ai membri della
tribù nemmeno una singola licenza. Di conseguenza, la caccia di sussistenza
praticata dai Boscimani è stata equiparata al bracconaggio commerciale. A
decine sono stati arrestati semplicemente per aver cercato di sfamare le loro
famiglie.
Survival riceve segnalazioni di
Boscimani torturati sin dagli anni ‘90 e recentemente ha pubblicato un rapporto
che documenta più di 200 casi di abusi violenti registrati tra il 1992 e il
2014, tra cui un Boscimane morto a seguito delle torture e un bambino ferito
allo stomaco da un colpo di pistola dopo che il padre si era rifiutato di far
entrare la polizia nella sua capanna senza un mandato. Nel 2012, due Boscimani
sopravvissero alle torture inflitte loro delle guardie del parco perché avevano
ucciso un’antilope. Pare che uno dei due uomini, Nkemetse Motsoko, rischiò di morire
quando la polizia lo prese alla gola per soffocarlo, e lo seppellì vivo. Nel
2014 si è verificato un altro terribile attacco. «Mentre mi aggredivano – ha
raccontato Mogolodi Moeti a Survival – mi dissero che persino il presidente
sapeva quel che stava succedendo, che potevano uccidermi senza essere accusati
di nulla, perché quello che mi stavano facendo era per ordine del governo. Mi
dissero che volevano usarmi come esempio, per dissuadere gli altri dal
ritornare nella Central Kalahari Game Reserve e mancare di rispetto al governo».
Il diritto dei Boscimani del
Kalahari a cacciare per nutrirsi è un diritto umano fondamentale e il
comportamento del governo è stato duramente criticato da varie istituzioni
inteazionali tra cui l’Onu e la Commissione africana per i diritti umani e
dei popoli. Ciò nonostante, recentemente il presidente Khama ha anche vietato,
illegalmente, la caccia in tutto il paese a eccezione, però, che per i ricchi
cacciatori di trofei. Continua a giustificare la persecuzione di questo popolo
unico nel nome della «conservazione», ma allo stesso tempo permette
l’estrazione di diamanti e il fracking (modalità di estrazione di
idrocarburi dalle rocce, ndr) nella riserva, creata nel 1961 come «santuario»
proprio per permettere ai Boscimani di mantenere il loro stile di vita. Non
avendo alcuna possibilità di procurarsi cibo nella terra ancestrale, molti sono
costretti a vivere nei campi di «reinsendiamento» governativi, da loro definiti
come «luoghi di morte».
Una situazione inaccettabile e paradossale
se si pensa che, per stessa ammissione dei funzionari governativi, i Boscimani
non cacciano con armi, e non esistono prove che il loro modo di cacciare non
sia sostenibile. Anzi, come la maggior parte dei popoli indigeni del mondo, i
Boscimani sono più motivati di chiunque altro a proteggere l’ambiente che
abitano da tempo immemorabile.
E devono farlo: per vivere e
prosperare dipendono da esso.

Dove
sta la biodiversità
Se l’80% della biodiversità
terreste si trova nei territori dei popoli indigeni, e la stragrande
maggioranza dei 200 luoghi a più alta biodiversità sono terra indigena, non è
un caso. Avendo sviluppato stili di vita sostenibili, adattati alle terre che
abitano e amano, i popoli tribali hanno contribuito direttamente all’altissima diversità
di specie che li circonda, a volte nel corso di millenni. Ma i popoli indigeni
sono anche i migliori custodi del mondo naturale. In Amazzonia, per esempio,
studi scientifici dimostrano che i territori indigeni, che coprono un quinto
dell’Amazzonia brasiliana, costituiscono una barriera estremamente efficace
alla deforestazione e agli incendi. Le immagini satellitari sono
impressionanti: in molti casi la deforestazione si ferma esattamente là dove
iniziano le aree indigene. Effetti simili si registrano nell’Amazzonia
boliviana, dove la deforestazione è sei volte minore nelle foreste comunitarie,
e in Guatemala (venti volte minore). I popoli indigeni conoscono la loro terra
intimamente.
«Non stiamo rispolverando il mito
del buon selvaggio. Non stiamo dicendo che i popoli indigeni siano tutti
eccellenti custodi delle loro terre – puntualizza Stephen Corry, direttore
generale di Survival -. Quello che sosteniamo, dopo un’attenta valutazione
delle prove, è che in generale loro sappiano conservare i loro ambienti meglio
di quanto abbiamo mai fatto noi». È un dato di fatto. Nel corso di generazioni
hanno accumulato una conoscenza ineguagliabile della flora e della fauna
autoctone, nonché delle relazioni che le uniscono, e questo sapere li ha resi i
più efficienti ed efficaci manager delle loro terre. Questa tesi è sostenuta
oggi anche da alcune organizzazioni responsabili dello sfratto dei popoli
indigeni. La Banca Mondiale è stata una delle istituzioni più distruttive degli
ultimi decenni, eppure uno dei suoi studi dimostra che nei luoghi in cui vivono
i popoli indigeni, la deforestazione è minore. Il Wwf afferma che l’80% delle «ecoregioni»
più ricche del pianeta sono la casa dei popoli indigeni e che questo «testimonia
l’efficacia dei sistemi di gestione delle risorse adottati dagli indigeni».
È dunque tempo di mettere fine alle
gravi violazioni dei diritti umani compiute nel nome dell’ambiente, e fare in
modo che i diritti dei popoli indigeni, incluso quello di consultazione, siano
pienamente rispettati così come sancito anche dall’Onu e da molti codici di
condotta adottati, in linea teorica, dalle stesse associazioni
conservazioniste, ma spesso del tutto ignorati o raggirati nella pratica. Se si
vuole realmente proteggere l’ambiente, si devono esplorare soluzioni innovative
fondate sul rispetto dei diritti indigeni, in particolar modo quello alla
proprietà collettiva della terra e quello a proteggere e alimentare le terre
natali. E chiede rispetto per le loro conoscenze e i loro sistemi di gestione
delle risorse naturali. I popoli indigeni meritano di essere riconosciuti e
aiutati a confermarsi come i migliori guardiani delle loro terre e, di
conseguenza, della natura da cui tutti dipendiamo. •
 4.
4. ![]() La voce delle imprese
La voce delle imprese
idroelettriche (Uhe)
«Stiamo lavorando per
voi»
Itaipu è la seconda centrale idroelettrica al mondo. Belo
Monte sarà la terza. Il Brasile (come altri paesi) vuole sfruttare le risorse
idriche dell’Amazzonia per produrre energia. Il futuro della produzione
dell’energia dai fiumi non risiede però nei grandi progetti, ma in impianti di
piccole dimensioni, meno dannosi dal punto di vista umano e ambientale.
Manaus. «Nella regione della centrale di Belo Monte abbiamo
già investito 2 miliardi (di reais, circa 570 milioni di euro, ndr) in progetti
socioambientali». Alcuni numeri: «90% di riduzione dei casi di malaria nella
regione del Xingu, 205 milioni investiti nelle comunità indigene, 26 mila
ettari di area di preservazione o recupero ambientale, 27 punti di salute, 3
ospedali, 458 milioni investiti in strutture fognarie, 95 milioni in azioni per
rafforzare la sicurezza nella regione del Xingu». E ancora: «Andremo a generare
energia pulita e rinnovabile con rispetto dell’ambiente e delle persone. Belo
Monte è un esempio di sviluppo sostenibile per il mondo». Essere d’accordo con
queste affermazioni risulta impossibile, ma sono alcuni stralci di una pagina
pubblicitaria inserita in una rivista brasiliana e firmata da Norte Energia, il
consorzio di imprese pubbliche e private che sta costruendo una centrale
destinata a diventare la terza al mondo, dopo quella cinese delle Tre gole e
quella brasiliana di Itaipu.
La centrale di Itaipu, situata sul fiume Paraná, al confine
tra Paraguay e Brasile, è in funzione dal 1984. Sul proprio sito, l’impresa si
vanta di essere la più grande produttrice di energia pulita e rinnovabile del
pianeta.
Al Forum di Manaus incontriamo Jair Kotz, responsabile della
gestione ambientale di Itaipu e gerente esecutivo del programma Cultivando Agua
Boa.
 Ci racconti in due
Ci racconti in due
parole le dimensioni di Itaipu.
«Itaipu genera il 20 per cento della energia consumata dal
Brasile e il 95 per cento di quella consumata in Paraguay. Fino al 2013 era il
più grande produttore di energia elettrica del mondo».
Perché un’impresa
idroelettrica come la vostra ha deciso di presenziare a un evento come il Forum
sulla biodiversità?
«Siamo qui perché dal 2003 stiamo portando avanti un
progetto di sviluppo territoriale sostenibile che ha l’acqua come elemento
centrale. Il progetto include 65 azioni su tutto il territorio e coinvolge
tutta la gente che su quel territorio vive. Esso tocca ogni tipo di aspetto:
economico, sociale, culturale, ambientale e ovviamente quello della
biodiversità».
In Brasile, ovunque
ci siano progetti di centrali idroelettriche, ci sono proteste, in particolare
da parte dei popoli indigeni.
«Secondo una nostra inchiesta dell’anno scorso, il 95% delle
persone del territorio in cui operiamo considera Itaipu essenziale per lo
sviluppo della regione. Si tratta della prova che un’impresa può e deve essere
strategica per il luogo dove va ad operare. Può e deve portare benefici per le
persone che vi abitano, siano esse brasiliane, giapponesi, italiane o indigene.
Noi lo abbiamo fatto attraverso Cultivando Agua Boa».
Produzione e ambiente
possono coesistere?
«Noi pensiamo che sia possibile conciliare la produzione di
energia con le esigenze di preservazione ambientale. Una volta si riteneva che
l’ambiente fosse un nemico dello sviluppo. Oggi la visione è cambiata:
l’ambiente è essenziale per la sostenibilità di oggi e di domani».
 Perché prevale sempre
Perché prevale sempre
e comunque lo stesso modello di sviluppo?
«Noi abbiamo invitato a parlare personaggi come Leonardo
Boff (teologo ed ecologista, ndr).
Per noi discutere il modello è fondamentale. Lo dimostra il fatto che abbiamo
introdotto nel dibattito temi quali il cambio climatico e la “felicità intea
lorda”».
Se i progetti socioambientali attuati nell’ambito del
programma Cultivando Agua Boa sembrano interessanti (non abbiamo però avuto
modo di verificarli sul campo), non possiamo dimenticare alcuni fatti storici.
Per esempio che, per costruire Itaipu, furono sacrificate le
cascate di Guaira, considerate le maggiori del mondo per portata d’acqua, e
obbligate al trasferimento decine di comunità guarani, mai indennizzate.
D’altra parte, oggigiorno anche la comunità scientifica internazionale è concorde
nell’affermare che il futuro per l’energia idroelettrica risiede in impianti di
piccole dimensioni. Troppe infatti sono le conseguenze negative prodotte dalle
grandi dighe sulle persone e sull’ambiente. Forse il governo di Brasilia
dovrebbe capire che è giunto il tempo di tornare al dialogo, mettendo da parte
prepotenza e arroganza.
Paolo Moiola
![]() 22 maggio: «Giornata
22 maggio: «Giornata
mondiale della biodiversità»
5. Lince pardina chiama
tonno rosso
Mai come oggi la diversità biologica del pianeta è stata in
pericolo. La globalizzazione mercantilista ha aumentato a dismisura i fattori
di pressione. Gli stessi che minacciano la diversità culturale. In un caso e
nell’altro, si dimentica che la diversità è ricchezza.
Pare che della lince pardina rimangano circa 150 esemplari,
della foca monaca 350-450 (Commissione europea, Natura 2000), dei gorilla di
montagna 880 (Wwf, Living Planet). Per salvare queste specie animali una
persona comune può al massimo aderire a qualche campagna internazionale. In
generale, se si ha a cuore la biodiversità, esistono però anche ambiti d’azione
più diretti. Il tonno rosso, pescato anche nel mar Adriatico, è un pesce in
pericolo d’estinzione. Non richiederlo nei ristoranti di sushi che lo offrono
(soltanto i più esclusivi, considerato il costo del piatto) è un gesto di
protesta piccolo ma significativo. Stessi problemi vigono per le piante. In
Europa si sta assistendo alla progressiva riduzione della diversità vegetale.
Questi sono soltanto alcuni esempi di biodiversità in
pericolo. Per rendersi conto dell’entità del problema è sufficiente visitare il
sito dell’«Unione internazionale per la conservazione della natura»
(www.iucn.org). L’organizzazione pubblica regolarmente una «lista rossa» delle
specie minacciate, divisa in 9 categorie a seconda della portata del rischio
d’estinzione.

Una definizione e
qualche numero
Una prima definizione di biodiversità viene dall’etimologia
del termine: biodiversità è «diversità della vita». Secondo l’articolo 2 della
«Convenzione sulla diversità biologica», firmata (da quasi tutti i paesi) a Rio
de Janeiro nel 1992, la biodiversità include gli organismi viventi di ogni
origine (animali, piante, microrganismi, geni in essi contenuti), ma anche le
differenze tra individui della medesima specie e tra gli ecosistemi. Gli
scienziati hanno fino a oggi catalogato circa 1.900.000 specie viventi diverse.
Si ritiene però che il loro numero effettivo sia molto superiore: ci sono stime
che indicano in 100 milioni gli organismi viventi.
La biodiversità consente la vita umana. Da essa dipendono
infatti il cibo, l’energia, i medicinali, le materie prime: tutto ciò che ci
permette di vivere. Eppure il tasso d’estinzione delle specie è in continuo
aumento. Detta in altri termini, oggi la biodiversità si riduce a un ritmo ben
più elevato del normale tasso d’estinzione.

I fattori di
distruzione
Esistono diversi fattori che determinano – da soli o più
spesso in combinazione – la perdita di biodiversità. I ricercatori del Living
Planet Index hanno individuato 7 minacce principali: il degrado e la perdita
degli habitat, lo sfruttamento attraverso caccia e pesca indiscriminate, il
cambiamento climatico, l’introduzione e la diffusione di specie aliene,
l’inquinamento, le malattie.
L’esempio più eclatante di degrado o perdita di habitat
riguarda le foreste tropicali, localizzate soprattutto in Indonesia, Congo e
Amazzonia (Brasile, in primis). La
distruzione di queste foreste per fare posto a monocolture (soprattutto di
soia), per prelevare legname o minerali, per allevare bestiame o per costruire
dighe, produce enormi perdite di biodiversità di cui queste aree sono molto
ricche. «Il danno non si limita alla sola perdita di biodiversità. A?causa
della distruzione delle foreste si liberano in atmosfera enormi quantità di
gas-serra, responsabili del riscaldamento globale» (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
Altro fattore di distruzione è l’introduzione di specie
aliene (alloctone), che entrano in competizione con quelle autoctone e che
possono diffondere patologie sconosciute. È importante ad esempio ricordare che
le foreste native (con i loro serbatorni di biodiversità) non potranno mai essere
recuperate con piantagioni di Eucalyptus grandis o di Acacia mangium: «green
deserts», le chiama Rainforest News, l’organizzazione internazionale di
salvaguardia delle foreste.
Negli ultimi anni hanno assunto sempre più importanza i
cambiamenti climatici in tutte le loro manifestazioni: aumento delle
temperature medie, alterazione del regime delle piogge, innalzamento del
livello dei mari, scioglimento dei ghiacciai, maggiore frequenza di eventi
estremi (alluvioni, siccità, cicloni, ecc.). Le mutate condizioni climatiche
stanno producendo importanti effetti su animali, vegetali ed ecosistemi. «La
rondine anticipa la data media di arrivo alle nostre latitudini», ma
soprattutto in Europa, negli ultimi 10 anni, è diminuita del 40% (Lipu-BirdLife).
Quanto alle piante: «Alcune specie di salice presenti sulle Alpi stanno
conquistando fasce altitudinali mai colonizzate in precedenza» (Lipu,
Cambiamenti climatici e biodiversità).
«La diversità culturale è, per il genere umano, necessaria
quanto la biodiversità per qualsiasi forma di vita». Così afferma l’articolo 1
della «Dichiarazione universale sulla diversità culturale», adottata
dall’Unesco nel 2001. E seguita, nel 2005, dalla «Convenzione per la protezione
e la promozione delle espressioni culturali» che tra l’altro riconosce
«l’importanza del sapere tradizionale, in particolare per quanto riguarda i
sistemi di conoscenze dei popoli indigeni».
La relazione tra diversità biologica e diversità culturale è
analizzata da Vandana Shiva. «La diversità biologica – scrive la nota scienziata indiana (spesso
oggetto di attacchi a causa della sua battaglia contro gli Ogm) – ha plasmato
le diverse culture del mondo. L’erosione della diversità biologica e l’erosione
della diversità culturale costituiscono le due facce di un unico problema.
Entrambe sono minacciate dalla globalizzazione di una cultura industriale
basata su conoscenze riduzionistiche, su tecnologie meccanicistiche e sulla
mercificazione delle risorse».
Tags: biodiversità, popoli indigeni, ambiente, Amazzonia, foreste, parchi, conservazione
Paolo Moiola e Francesca Casella















 La Sindone è stata finora conservata arrotolata in una
La Sindone è stata finora conservata arrotolata in una




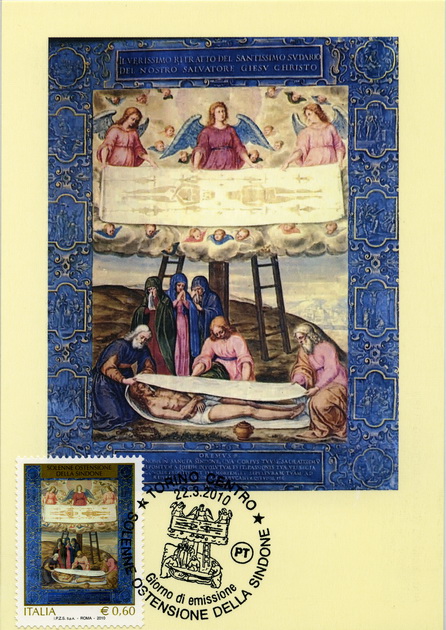
 Nacque a Domrémy,
Nacque a Domrémy,
_03.jpg)










 Ricordando Giancarlo?Pegoraro
Ricordando Giancarlo?Pegoraro
 Giancarlo arrivò a Milaico
Giancarlo arrivò a Milaico Arrivammo
Arrivammo


 Le missionarie della
Le missionarie della




 Racconto / in collaborazione con LINGUA MADRE
Racconto / in collaborazione con LINGUA MADRE
 Ogni
Ogni


