Paesi e popolazioni
allo sbaraglio.
Govei e popolazioni di Sierra Leone, Guinea, Liberia e
Nigeria sono alle prese con un’emergenza sanitaria probabilmente senza
precedenti. In paesi con strutture sanitarie inesistenti o inadeguate,
l’epidemia di Ebola potrebbe avere conseguenze difficilmente immaginabili.
Soltanto l’intervento internazionale può evitare che la situazione precipiti.
In attesa di un vaccino che ancora non esiste. Nel frattempo il virus è
arrivato in Spagna e negli Stati Uniti.
Leggi tutto il dossier sul pdf sfogliabile. Clicca qui.

Anno
2013. Inizio di dicembre. Il piccolo di due anni non sta bene, ha la febbre, è
molto debole, sembra gli facciano male i muscoli, la testa, la gola. È piccolo:
difficile capire. Potrebbe essere un’infezione virale, passerà. Ma poi compare
vomito, diarrea. Sarà una forma gastrointestinale, ce ne sono spesso in giro,
meglio portarlo dal pediatra. Il bambino però non è in Italia, è in Africa:
vive in Guinea, Guéckédou, una regione boschiva. Non è così facile portarlo da
qualcuno che lo visiti. E possono essere tante le cause del suo malessere:
potrebbe essere malaria, tifo, colera, meningite o una delle altre patologie
infettive diffuse in questo continente, spesso con nomi sconosciuti o
dimenticati da molti nel Nord del mondo.
La situazione non migliora perché questa non è una delle
solite malattie con cui quotidianamente la popolazione si confronta, spesso
avendo la peggio.
Ecco, si potrebbe immaginare così l’inizio dell’ultima
epidemia di Ebola, una febbre emorragica causata da un virus che l’Africa ha già
conosciuto. La prima volta è stata nel 1976. Poi l’Ebola si è ripresentata, con
epidemie mortali in alta percentuale. Questa volta, dalla vittima morta
a dicembre e identificata (ma soltanto il 22 marzo) come il «caso indice» (noto
anche come «paziente zero»), il primo dell’epidemia (forse)1,2,3,
l’infezione si è diffusa con velocità, dimensioni e portata assai maggiori
rispetto alle occasioni precedenti, passando dalla Guinea ai paesi vicini,
Liberia e Sierra Leone, e poi arrivando anche in Nigeria e Senegal.
Secondo i dati diffusi all’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms)4, al 7 settembre 2014 i casi (tra probabili, confermati
e sospetti) in Africa occidentale erano quasi 4.400, con circa 2.200 morti,
praticamente uno su due. Nel continente non c’è però un sistema sanitario che
permetta di avere dati certi che coprano tutto il territorio, comprese le zone
rurali più distanti. E poi la gente ha paura e non tutti – lo vedremo più
avanti – vanno a farsi visitare. Per questo le cifre potrebbero essere
incomplete o non precise. Senza contare che sarebbero da aggioare ogni giorno
(dati più recenti a pag. 43).
Dopo Guinea, Liberia e Sierra Leone, a fine luglio 2014
l’infezione è arrivata anche in Nigeria, con la morte di un paziente liberiano
arrivato in aereo a Lagos. Nell’ultimo rapporto dell’Oms in Nigeria sono stati
contati 21 casi (tra confermati, probabili e sospetti) e 8 morti4.
Infine, è stato segnalato un caso anche in Senegal, a fine agosto: un paziente
arrivato a Dakar dalla Guinea. Al 7 settembre i casi erano tre, nessun morto.
L’8 agosto, a nove mesi dall’ipotizzato inizio dell’epidemia, il direttore
generale dell’Oms ha dichiarato l’Ebola un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale5 e il 28 agosto ha pubblicato una roadmap per
assistere governi e partner nei piani di risposta all’epidemia e cornordinare il
supporto internazionale6.
All’inizio di agosto sono stati segnalati casi anche
nella Repubblica Democratica del Congo, ma a inizio settembre l’Oms ha
affermato che quest’epidemia è slegata da quella che sta flagellando l’Africa
occidentale da fine 20137. In ogni caso, anche in Congo R.D. l’Ebola ha seminato
morte, con 35 decessi (7 fra operatori sanitari) su 62 casi8.

Quel fiume in Congo
Era il 1976 quando, nella Repubblica Democratica del
Congo e in Sudan, fu identificato per la prima volta il virus responsabile
della malattia. Allora si era trattato di due epidemie contemporanee, causate
da due sottotipi diversi (sono in tutto cinque) del virus: quello chiamato «Zaire»,
responsabile anche dell’epidemia attuale, e il tipo «Sudan»9.
Il nome Ebola deriva dall’omonimo fiume, vicino alla
zona del Congo ove si era verificata l’epidemia (Yambuku). Da allora varie
segnalazioni di casi singoli e di epidemie (24, la maggior parte causate dal
sottotipo Zaire) si sono succedute in diversi paesi africani. Le ultime
segnalazioni del 2012 provenivano dall’Uganda e ancora dalla Repubblica
Democratica del Congo. La letalità è stata diversa, passando dalla più bassa
del 25 per cento (dunque, un malato morto ogni quattro) alla più alta del 90
per cento (nove morti ogni dieci malati).
Cosa favorisce la
diffusione
Riguardo all’epidemia attuale – iniziata in Guinea
sudorientale nel dicembre 2013 -, sembra che i primi pazienti si siano ammalati
perché esposti a cacciagione locale infetta e che la diffusione sia poi stata
veicolata dalla partecipazione a cerimonie funebri che hanno portato al
contatto con persone morte per l’Ebola o con persone già infettate10.
L’Oms ha segnalato tre fattori principali responsabili della diffusione
dell’Ebola11. In primis, aspetti culturali come la mancanza di
fiducia, preoccupazione e resistenza nei confronti delle raccomandazioni di
sanità pubblica volte a prevenire la diffusione e bloccare il contagio. Rientra
in questo anche la mancata ricerca dell’assistenza sanitaria (in paesi in cui
la rete sanitaria è fragile e precaria), la scelta di curare i malati a casa e
di tenerli nascosti, la partecipazione a cerimonie funebri con rituali che
espongono al contagio. Un altro aspetto critico è rappresentato dai massicci
spostamenti delle persone sia all’interno dei paesi che attraverso le
frontiere. Un terzo fattore è venuto dalla non completa copertura dell’epidemia
con misure di contenimento efficaci, quindi una risposta inadeguata alla
dimensione e diffusione del contagio.
La trasmissione
Il virus dell’Ebola causa una febbre emorragica molto
pericolosa e spesso fatale negli esseri umani, tanto da poter uccidere fino a
nove persone su dieci infettate12. Finora le epidemie si sono
verificate in villaggi isolati, vicino alle foreste tropicali, in Africa
centrale e dell’Ovest. Il virus viene trasmesso alle persone da animali e un
tipo particolare di pipistrello – appartenente alla famiglia Pteropodidae
– ne viene considerato l’ospite naturale (si veda l’infografica a pag. 42).
L’infezione viene trasmessa dal contatto con sangue, secrezioni o altri fluidi
del corpo di animali infettati dal virus. Una volta passato dall’animale
all’uomo, il virus si trasmette da una persona all’altra secondo modalità
analoghe, attraverso il contatto diretto o indiretto con sangue e fluidi del
corpo13.
I riti attorno al
defunto
Uno dei problemi affrontati dagli operatori sanitari
nella prevenzione della diffusione del virus, è quello delle cerimonie di
sepoltura, come racconta Maria Cristina Manca, antropologa di Medici senza
frontiere, che ha lavorato diverse settimane in Guinea, proprio a Guéckédou
dove pare tutto sia iniziato. «Le ritualità intorno alla morte – ci racconta –
sono fondamentali. Sia i malati, sia i morti, vengono appoggiati, seguiti,
aiutati da tutte le persone che sono loro vicine. Per i malati ciò accade a causa
della mancanza di un servizio sanitario. L’unico servizio presente è a
pagamento: per questo le persone non vanno a farsi curare o comunque ci vanno
soltanto se sono molto gravi. Quando arriva la morte, vi sono una serie di
congiunti che lavano il corpo, lo vestono, lo abbracciano, lo baciano. Più
l’individuo deceduto era importante, più cresce il numero di soggetti
coinvolti. Addirittura, se il morto era influente nel villaggio, la salma viene
portata a “salutare” una serie di persone. Tutto questo significa circolazione
del virus tra chi lava il corpo, chi si trova nel luogo in cui viene portato,
chi arriva da lontano per salutarlo: a questa mobilità enorme corrisponde
un’enorme diffusione. Per il rischio di contagio, è chiaro che il corpo non si
deve né toccare, né lavare, né abbracciare. Ci sono tuttavia alcune cose che si
possono fare. L’Ebola è una malattia terribile, che obbliga a soluzioni
drastiche. Personalmente, quello che ho cercato di fare è stato di non vietare
il rito ma di trasformarlo, nei limiti del possibile. Per esempio, nel sacco
bianco, dove bisogna porre il corpo del malato morto di Ebola, si possono
collocare gli oggetti rituali che in genere vengono messi nella tomba; le
persone, con guanti e protezioni adeguate, possono prendere il sacco e
tumularlo; si può anche esporre il corpo, purché a metri di distanza e con le
precauzioni del caso; infine si può concedere un ultimo saluto, un’ultima
preghiera prima che il sacco venga chiuso».

Senza medici e
infermieri
L’incubazione della malattia – dal momento
dell’infezione all’inizio dei sintomi – può variare da 2 a 21 giorni. I sintomi
comprendono febbre, debolezza intensa, dolori muscolari, mal di testa e mal di
gola, cui seguono vomito, diarrea, segni sulla pelle, malfunzionamento di reni
e fegato e in alcuni casi, sanguinamenti sia estei sia interni (grafico
dei sintomi a pag. 43). Le persone sono infettive finché il sangue e le
secrezioni contengono il virus, che può rimanere per un certo periodo anche
dopo la guarigione14. In questa epidemia è stato alto il prezzo pagato da
chi lavora per curare gli ammalati. Infatti, proprio la modalità di
trasmissione dell’infezione espone a un alto rischio il personale sanitario,
anche a causa dei sintomi che all’inizio sono poco specifici (la conferma di
infezione da Ebola è possibile solo tramite esami di laboratorio). Al 7
settembre erano 144 gli operatori sanitari deceduti in Guinea, Liberia e Sierra
Leone su 301 casi di contagio15. E questo in paesi dove vi è una
scarsità di base di personale sanitario, sia medico che infermieristico: già
prima della morte degli operatori sanitari, vi erano soltanto 90 medici in
Liberia e 136 in Sierra Leone, paesi che ne avrebbero bisogno rispettivamente
per circa dieci e venti volte di più. E in Guinea la situazione è solo
lievemente migliore, con 1.000 medici per più di 11 milioni di persone16.
Clara Frasson, di Medici con l’Africa-Cuamm,
all’ospedale di Pujehun in Sierra Leone per un progetto di aiuto a mamme e
bambini, descrive la devastazione di un paese in ginocchio: «A causa
dell’epidemia, il sistema sanitario, messo in piedi con grandi sforzi, è in
crisi. Le mamme non fanno più le visite prenatali, non portano i bambini a
vaccinare; le gravide riprendono a partorire in casa senza assistenza; i
malnutriti non vanno più ai centri dove potrebbero essere nutriti
correttamente, curati e salvati. Questa emergenza è paragonabile alla guerra.
L’economia del paese è allo stremo, il commercio è interrotto, le compagnie
aeree non fanno più scalo a Freetown. Molte zone del paese sono chiuse e la
popolazione non può più muoversi liberamente. Il cibo comincia a scarseggiare,
non è ancora la stagione del raccolto e purtroppo le persone stanno usando le
scorte alimentari destinate alla vendita o alle sementi. Tutte le persone
(familiari, amici, ecc.) che hanno avuto contatto con un malato vengono poste
in quarantena per 24-25 giorni. Con il team sanitario del distretto noi
organizzazioni distribuiamo cibo, che però non è mai sufficiente. I prelievi di
sangue di persone con sintomi di Ebola vengono portati a Kenema, dove c’è
l’unico laboratorio nazionale in grado di testare il virus. Se il risultato è
positivo, il paziente viene trasferito in uno dei due centri di trattamento del
paese, che non bastano più. È stato programmato un controllo casa per casa in
tutta la Sierra Leone per trovare tutti i malati di Ebola, dato che purtroppo
si nascondono, e tutte le persone e familiari che sono stati a contatto con
loro e che sicuramente verranno contagiati. Qui la foresta è grande ed è facile
nascondersi. Per fermare questa epidemia l’unica soluzione è trovare le persone
malate, isolarle, trattarle e cercare di tenerle in vita. Abbiamo visto che, se
si cura precocemente, la sopravvivenza è alta. Usiamo tutti i mezzi possibili
per informare la popolazione, perché abbia fiducia nel sistema sanitario: non è
facile ma è la nostra sfida. Un sistema che ora è al collasso e che, dopo
l’Ebola, bisognerà riorganizzare completamente. Questa nuova emergenza ha
portato ancora povertà, morte e disperazione. I nostri colleghi africani hanno
paura che ce ne andiamo. Ogni giorno ci cercano, se non ci vedono mandano
messaggi, telefonano, chiedono dove siamo. Per loro siamo una speranza ed è per
questo che teniamo duro: rimaniamo nonostante il rischio reale».
Costruire il presente
e il futuro
Oltre alla difficile diagnosi, alla modalità di
diffusione, alla mortalità alta, al rischio per il personale sanitario in paesi
dove la situazione assistenziale di base è già assai precaria, si aggiunge un
altro punto critico di questa infezione: la mancanza di una terapia specifica.
Al momento non vi sono infatti vaccini disponibili (anche se sono allo studio),
non vi sono farmaci, e quelli sperimentali provati non hanno ancora dato
risultati certi e non sono diffusamente disponibili17,18.
Al momento quindi la terapia possibile è solo quella di reidratazione, supporto
e assistenza del paziente. La prevenzione, il monitoraggio, il controllo
rappresentano quindi una strada fondamentale da percorrere per arginare e
interrompere le epidemie da Ebola, e far sì che una diffusione del genere non
si ripeta.
Questa tragedia ha sottolineato ancora una volta la
debolezza e fragilità dei sistemi sanitari africani. E la necessità di
investire nel loro rinforzo perché possano far fronte alle emergenze, ma anche
ai bisogni sanitari della quotidianità.
Valeria
Confalonieri
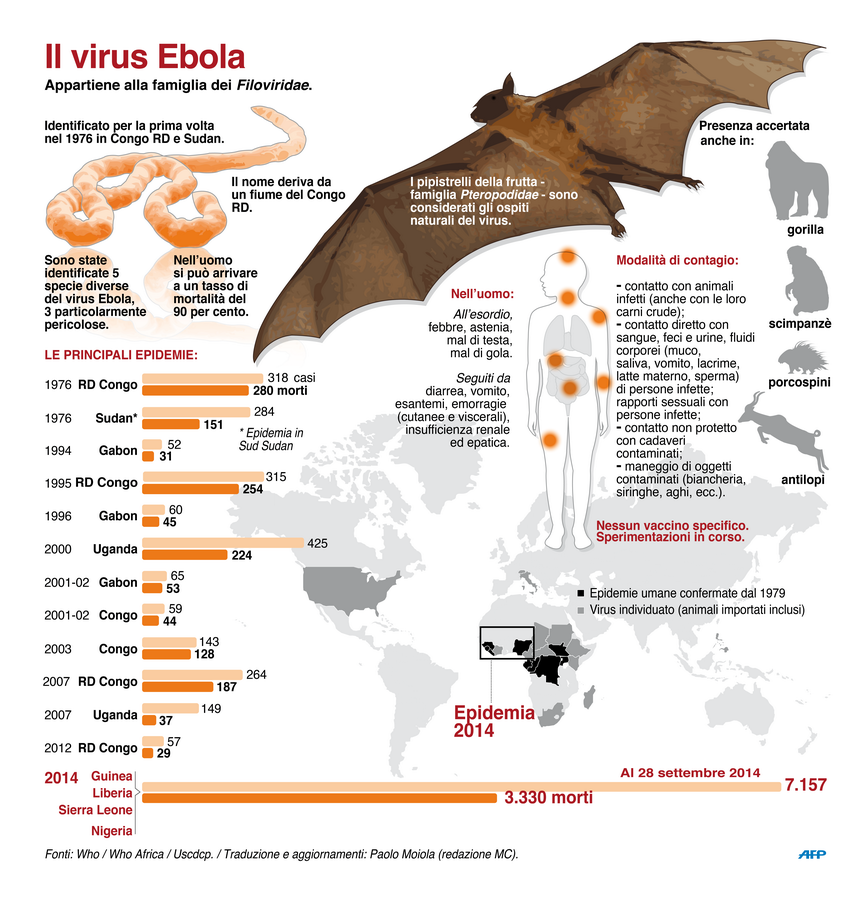
Fonti bibliografiche
1 – Ebola: a failure of
inteational collective action, The Lancet (editoriale), 23 agosto 2014.
2 – Gostin LO, Ebola: towards an Inteational
Health Systems fund, The Lancet, 5 Settembre 2014.
3 – «Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute», www.epicentro.iss.it.
4 – World
Health Organization, Ebola Response
Roadmap Situation, Report 3, 12 September,
www.who.int.
5 – World
Health Organization, Who Statement on
the Meeting of the Inteational Health Regulations Emergency Committee
Regarding the 2014 Ebola Outbreak in West Africa.
6 – World
Health Organization, Ebola response
roadmap, 28 agosto 2014.
7 – World Health Organization, Virological analysis: no link between Ebola outbreaks in west Africa and Democratic Republic of Congo.
8 – World
Health Organization, Ebola virus disease
– Democratic Republic of Congo, 10 settembre 2014.
9 – World
Health Organization, Ebola virus disease. Fact sheet N. 103.
10 – Fonte
citata, nota 3.
11 – World
Health Organization, Ebola virus disease, West Africa – update. Disease
outbreak news, 3 July 2014.
12 – Fonte
citata, nota 9.
13 – World
Health Organization, Frequently asked questions on Ebola virus disease.
14 – Fonte
citata, nota 9.
15 – Fonte
citata, nota 4.
16 – Fonte
citata, nota 2.
17 – Fauci
AS, Ebola –
Underscoring the Global Disparities, in
Health Care Resources, New England Joual of Medicine, 13 agosto 2014,
www.nejm.org.
18 – Goodman
JL., Studying “Secret
Serums” – Toward Safe, Effective Ebola Treatments,
New England Joual of Medicine, 20 agosto 2014, www.nejm.org.
Info
e aggioamenti:
• World Health Organization: www.who.int
• Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza
e Promozione della Salute: www.epicentro.iss.it
• Centers for Disease Control and Prevention
(Atlanta, Usa): www.cdc.gov.
L’autrice
dell’articolo:
Di formazione medico, dopo alcuni anni di esperienza in
ospedale, Valeria Confalonieri (1965) ha deciso di dedicare il suo lavoro
esclusivamente al giornalismo medico-scientifico. Si occupa in particolare di
argomenti sanitari e sociali nei paesi impoveriti e in generale di diritto e
accesso alla salute delle popolazioni più vulnerabili. Su tali temi ha
collaborato con diverse testate on line e cartacee e alla scrittura di libri. È
membro dell’«Osservatorio italiano sulla salute globale».
Interviste a cura
di:
Marco Bello, redazione MC.
Le foto delle
copertine:
• In prima pagina: Guinea, Conakry, personale con indumenti protettivi
trasporta una vittima dell’Ebola nel centro gestito da Medici senza frontiere, vicino
all’ospedale Donka (settembre 2014).
• In ultima pagina: Costa D’Avorio, Abidjan, bambini osservano il poster
sui sintomi dell’Ebola in una scuola del quartiere di Koummassi (settembre
2014).
Dossier a cura di:
Paolo Moiola, redazione MC.

Valeria Confalonieri
 Inchiesta «mobile money» – Denaro virtuale / 3
Inchiesta «mobile money» – Denaro virtuale / 3
.JPG) Padre Bruno Del Piero e il Caquetá
Padre Bruno Del Piero e il Caquetá





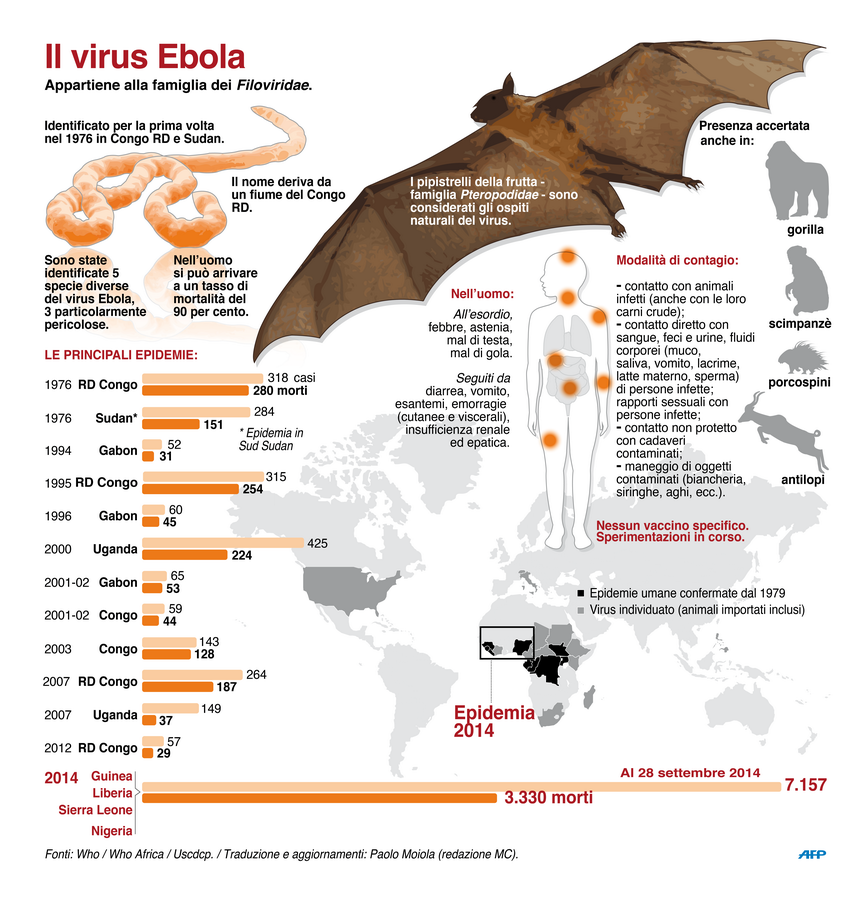

 Il Mozambico affronta, questo mese di ottobre, la sua quinta elezione presidenziale dal 1994, anno dell’introduzione del multipartitismo dopo una devastante guerra civile durata vent’anni e conclusa con la pace di Roma del 1992. In queste pagine racconto il viaggio che, come responsabile dell’ufficio progetti della MCO, ho fatto lo scorso giugno nel paese lusofono. Una panoramica sulla situazione politica e qualche istantanea della quotidianità nelle missioni.
Il Mozambico affronta, questo mese di ottobre, la sua quinta elezione presidenziale dal 1994, anno dell’introduzione del multipartitismo dopo una devastante guerra civile durata vent’anni e conclusa con la pace di Roma del 1992. In queste pagine racconto il viaggio che, come responsabile dell’ufficio progetti della MCO, ho fatto lo scorso giugno nel paese lusofono. Una panoramica sulla situazione politica e qualche istantanea della quotidianità nelle missioni.
 Amin e Nyerere: figli per la riconciliazione
Amin e Nyerere: figli per la riconciliazione 

.JPG) Terra amazzonica di foreste e savane, Roraima è lo stato brasiliano con la maggiore percentuale di popolazione indigena. I cui diritti sono stati conquistati con una lotta quasi sempre cruenta (e tuttora non conclusa). A Boa Vista, capitale di Roraima, abbiamo visitato la Casa de Saúde Indigena (Casai), scoprendo che i «mondi indigeni» resistono nelle proprie diversità.
Terra amazzonica di foreste e savane, Roraima è lo stato brasiliano con la maggiore percentuale di popolazione indigena. I cui diritti sono stati conquistati con una lotta quasi sempre cruenta (e tuttora non conclusa). A Boa Vista, capitale di Roraima, abbiamo visitato la Casa de Saúde Indigena (Casai), scoprendo che i «mondi indigeni» resistono nelle proprie diversità.
 Tante ombre sul dopo Karzai.
Tante ombre sul dopo Karzai. 