Qualcosa di magico

/ 2
Gioalista spagnolo,
autore di un noto manuale di comunicazione radiofonica, Santiago García Gago da
oltre 15 anni percorre l’America Latina – Venezuela, Perù, Ecuador, Guatemala –
per fare e insegnare radio in ambito comunitario e indigeno.
Con una missione:
contrastare gli oligopoli dell’informazione facendo conoscere e diffondendo liberamente
la tecnologia.

Il
manuale di chi vuole fare radio è scaricabile gratuitamente da internet: Manual para radialistas analfatécnicos, che si può tradurre con «Manuale per operatori radio
senza cognizioni tecniche». Il libro è strutturato su 100 domande e risposte
che vogliono servire ad alfabetizzare tecnicamente chi desidera fare radio. Si
tratta di una panoramica completa che spazia dalla spiegazione del suono alla
differenza tra radio Am e radio Fm, dalla descrizione del mixer alla
digitalizzazione dell’audio, dalle nuove tecnologie alla radio online.
Il manuale è nato per aiutare chi è meno rappresentato,
chi non riesce a emergere nell’arena dei grandi mezzi di comunicazione. Per
questo esso ha trovato l’appoggio prestigioso dell’Unesco, l’organizzazione
delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
Il suo autore si chiama Santiago García Gago, spagnolo di
Salamanca, da oltre 15 anni vagabondo dell’etere in vari paesi latinoamericani:
Venezuela, Perù, Ecuador e oggi Guatemala, sempre al servizio di emittenti
comunitarie e indigene. È membro dell’associazione Radialistas apasionadas y
apasionados, una ong latinoamericana (con sede a Quito) il cui obiettivo è
democratizzare l’informazione, in particolare quella radiofonica. Lo abbiamo
raggiunto per rivolgergli qualche domanda.
Santiago, che
significa per te lavorare in radio?
«Più che un lavoro, la radio è una passione. In verità è
un mezzo che mi è piaciuto fin da bambino. Ho sempre desiderato essere un
giornalista. Ho finito per legarmi alla radio, non tanto per la parte parlata
quanto piuttosto per i controlli e la tecnologia. La cosa appassionante di essa
è che ti permette di essere molto più creativo rispetto ad altri mezzi di
comunicazione come la televisione o la carta stampata. In televisione si vede
tutto e dunque c’è poco spazio per l’immaginazione. Anche la carta ha molto
poco margine di manovra. Al contrario la radio possiede qualcosa di magico.
Puoi far parlare un cestino della spazzatura per educare
alla pulizia delle città. Puoi trasmettere dal vivo facendo partecipare molte
persone allo stesso tempo».
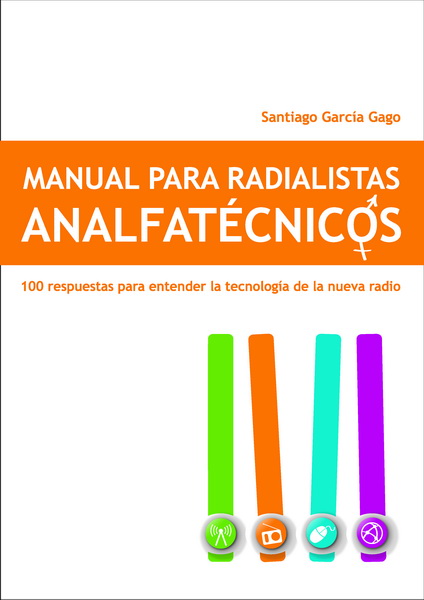
Nell’epoca di
internet e della televisione via satellite, gli abitanti dell’America Latina
ascoltano ancora la radio?
«Sì, e anche molto. Non fosse altro perché ancora oggi,
nel continente latinoamericano, l’accesso a internet è un privilegio che
riguarda soltanto il 30-35% della popolazione. La radio tradizionale è
gratuita. Alcune batterie possono durare un anno e consentire alla radio di
tenere compagnia per tutto il giorno. A parte il discorso economico, la radio
presenta alcuni vantaggi rispetto agli altri mezzi di comunicazione. In primo
luogo, essendo eminentemente locale, può adattarsi alle esigenze delle
popolazioni che abitano contesti differenti e parlano lingue diverse. Proprio
per questo si ascolta molto, principalmente in zone isolate e rurali. Si può
dedicare tempo alle notizie locali, parlare la lingua del posto, soprattutto se
le popolazioni sono indigene. Al contrario, le televisioni e internet sono
pensate più per un pubblico di massa e nazionale.
Altro fattore importante è l’accesso al mezzo. Così, ad
esempio, mentre è impossibile o molto difficile portare la televisione o
internet in un autobus (anche quando esista connessione, gli abbonamenti al web
sono ancora molto costosi), la radio ti può sempre accompagnare».
Santiago, proviamo a
parlare della qualità dell’informazione. Oggi il pericolo è quello di un
eccesso di informazione (conosciuto come «information overload», sovraccarico
informativo) e – allo stesso tempo – un pericolo di superficialità. Mi
riferisco in particolare al ruolo assunto e giocato dalle reti sociali (social
networks) come Facebook, Twitter, YouTube, etc. Qual è la tua opinione al
riguardo?
«Credo che i buoni giornalisti continuino ad esserlo
anche nell’epoca dell’informazione digitale. Ciò che invece accade è che i
cattivi giornalisti hanno oggi più opportunità di mettersi in mostra e di farlo
in maniera più importante. Mi spiego. Davanti a una illazione, un giornalista
serio investiga, fa confronti e verifiche prima di lanciare la notizia. I mezzi
digitali consentono di fare informazione in maniera più rapida e profonda. I
cattivi giornalisti – che nell’era predigitale si affrettavano a raccontare la
voce senza verificarla – adesso fanno lo stesso però in maniera più
generalizzata utilizzando le reti sociali. La loro mancanza di professionalità
raggiunge un pubblico ancora più vasto.
Io non credo che il problema sia nelle nuove tecnologie,
ma piuttosto nel modo in cui esse vengono utilizzate. Faccio un esempio.
In precedenza, per conoscere la storia, si faceva ricorso
a una enciclopedia scritta da un gruppo di persone a cui si credeva. Adesso
possiamo cercare in Wikipedia, l’enciclopedia digitale, e avere versioni
differenti di quanto accaduto. Ci sarà chi si accontenterà di quanto racconta
l’articolo di Wikipedia e non cercherà altre fonti, come quelli che prima
leggevano l’enciclopedia e lì si fermavano.
Però coloro i quali già prima, oltre all’enciclopedia,
andavano a consultare altri libri, oggi andranno a cercare i collegamenti verso
altre fonti e i rimandi degli articoli per approfondire di più.
In definitiva, internet aiuta a essere più superficiali
coloro che già lo erano. Allo stesso tempo, aiuta chi
realmente vuole investigare, approfondire, comprendere. Mai nella storia
dell’umanità si è avuta tanta informazione a propria disposizione. L’uso che di
essa facciamo dipende da ognuno».
Nonostante la
proliferazione dei mezzi informativi, persiste la tendenza alla concentrazione
dei mezzi più influenti in poche mani (oligopoli). Esiste uno spazio reale per
i mezzi di comunicazione alternativi?
«Come si può parlare di libertà di espressione o di
democrazia in America Latina quando nella maggioranza dei paesi il 90% dei
mezzi di comunicazione appartiene a una fetta minuscola della popolazione? Questa
concentrazione è stata smisurata però si stanno intravvedendo cambiamenti
promettenti. In vari paesi, nel corso degli ultimi 10 anni, sono state
approvate norme di legge che favoriscono l’accesso di comunità e organizzazioni
alle frequenze di radio e televisione. Oggi, tra gli altri, Argentina, Uruguay,
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia hanno leggi che riservano o dividono lo
spettro radioelettrico tra i diversi mezzi di comunicazione: comunitari,
pubblici e privati.
Questo ha consentito a molte radio e televisioni
comunitarie di accedere a una frequenza. Tuttavia manca ancora molto. Ribaltare
tanti anni di oligopolio in così poco tempo non è facile. La cosa buona è che i
paesi riformatori non stanno abbandonando questa linea».
I mezzi di
comunicazione piccoli o alternativi quasi sempre hanno problemi economici. Cosa
si può fare?
«Credo che questa domanda se la pongano ogni giorno tutti
i mezzi alternativi. Non è facile dare una risposta. È certo che queste radio
sono nate senza fini di lucro. Questo però non significa che esse non possano
trasmettere pubblicità e fare “commercio”, perché di qualcosa debbono pur
vivere, almeno per riuscire a pagare le bollette della luce.
Credo che i mezzi alternativi debbano utilizzare gli
stessi metodi per raccogliere denaro di qualsiasi altra radio. Soltanto gli
scopi per cui lo fanno debbono rimanere distinti. Però questo esige che le
radio alternative e i piccoli comunicatori entrino in una logica di competizione,
che pare suscitare paura. Qualcuno ha messo nella testa di questi mezzi di
comunicazione che non debbano competere, che non debbano entrare nella logica
“commerciale”. Io non sono d’accordo. Da quando abbiamo preso in mano il
trasmettitore siamo entrati in competizione con le altre radio per raggiungere
più ascoltatori. Perché non farlo anche sul terreno pubblicitario? Ovviamente
ci saranno clienti commerciali, come Monsanto, che non ci interesserà
pubblicizzare. Per questo si dovrà lavorare ragionando su una base etica e
coerente, ma pur sempre muovendosi in una direzione di competizione, anche
commerciale. L’idea è fare soldi affinché il nostro mezzo possa pagare le
fatture. Non per produrre profitti, ma semplicemente per sopravvivere».
Che ruolo possono
avere le radio alternative nel campo dei diritti umani e dei popoli originari?
«I gruppi di potere che posseggono la maggioranza dei
mezzi di comunicazione nel mondo non sono interessati ai diritti umani o ai
popoli originari. Le loro priorità sono altre: l’obiettivo è fare denaro. Oltre
a possedere i mezzi d’informazione, questi gruppi di potere posseggono le
banche o sono amici delle multinazionali (dei semi, del petrolio o delle
miniere). Imprese – e ci sono centinaia di casi che lo dimostrano – che passano
sopra la testa della gente pur di fare soldi. Ciononostante i mezzi
d’informazione commerciali non si interessano di queste ingiustizie e non le
riportano. Men che meno danno voce ai contadini, agli indigeni, alle donne. Gli
unici mezzi che aprono i loro microfoni a queste persone sono le radio
alternative. Senza di esse, i silenziati del sistema non avrebbero canali per
farsi sentire».
Nel prologo del tuo
manuale José Ignacio López Vigil (autore, tra l’altro, di un altro conosciuto
manuale per le radio) parla di «democratizzare la tecnologia». È questo lo
scopo del tuo volume?
«Quando lavoravo a Puerto Ayacucho, nella regione
amazzonica del Venezuela, mi resi conto che il tema della tecnologia stava
avanzando molto rapidamente. Vidi che, se prima era il tecnico della radio che
conosceva e sistemava i retroscena tecnici, adesso giornalisti e annunciatori
lavoravano con la tecnologia tutto il tempo. Usando la console, editando i loro
audio, navigando in internet. Il problema era che – se succedeva qualcosa –
essi non sapevano cosa fare. Per questi motivi mi decisi a scrivere il manuale:
per avvicinare alla tecnologia la gente della radio in generale, non soltanto i
tecnici. Per raggiungere lo scopo ho cercato di scrivere un testo molto chiaro
ma allo stesso tempo piacevole».
Sul prezioso sito di Radialistas
ho trovato, tra le tante cose, una serie radiofonica dedicata a una rilettura
del Vangelo. Che cosa puoi raccontarci al riguardo?
«Rispetto a “Un tale Gesù” (Un Tal Jesús),
la serie ideata e scritta dai fratelli María e José Ignacio López Vigil, io non
ricordo molto dato che a quei tempi ero piccolo e vivevo ancora in Spagna. Fui invece più vicino a Maria e José durante la
“seconda parte” di quella serie, quella che essi titolarono “Un altro Dio è
possibile” (Otro Dios Es Posible). La prima serie fu molto perseguita
dalla gerarchia della Chiesa cattolica. Era l’inizio degli anni Ottanta, i
tempi della Teologia della liberazione e del Vaticano II in pieno vigore. I
fratelli Vigil dovettero ritirarsi dalla Chiesa perché la loro visione
rinnovatrice e di liberazione contrastava con quella della gerarchia. Entrambi
servivano in luoghi poveri e umili e credevano che questo Gesù giusto, vicino,
divertente e di caagione scura (moreno) poteva aiutare la gente a
uscire dalla miseria. Quella non era però la forma in cui la gerarchia
intendeva il Regno. I fratelli Vigil abbandonarono quindi gli abiti religiosi
che indossavano (José Ignacio era un gesuita, Maria una suora, ndr). La
loro serie radiofonica Un Tal Jesús provocò la chiusura del Serpal (Servicio
Radiofónico para América Latina). La cosa che più dava fastidio era che Gesù
era descritto fuori dai canoni consueti: con la pelle scura e come una persona
scherzosa, divertente, ballerina. Secondo me, quella serie racchiude un
profondo sentimento teologico liberatore. È un Gesù nel quale si può credere.
Un dato va ricordato: ancora oggi le 144 puntate del programma vengono
scaricate quotidianamente dal web e la gente continua ad avvicinarsi al moreno».
Santiago, per
chiudere questa nostra conversazione, che cosa vorresti fare per migliorare le
radio e il loro ruolo nell’ambito della comunicazione?
«In questo momento siamo molto impegnati nel tentativo di
far comprendere alle radio e ai mezzi alternativi l’importanza di internet e
delle nuove tecnologie. E stiamo lottando perché esse siano libere. Anche per
questo abbiamo aperto il sito radioslibres.net. Un progetto che cerca di
discutere e formare in software libero. E cerca di spingere le radio a utilizzarlo
e allo stesso tempo a diffondere la filosofia della cultura libera e della
conoscenza aperta. Per dirla in altri termini, stiamo tentando di trarre
vantaggio dalle nuove tecnologie partendo da un’idea di libertà».
(fine
seconda puntata – continua)
Da questi siti è scaricabile l’audio di moltissimi programmi
radio. Sono inoltre scaricabili gratuitamente sia il Manual para radialistas
analfatécnicos che la versione scritta dei programmi radiofonici
Un
tal Jesús. La Buena Noticia contada al pueblo de América Latina e Otro Dios es posible. I tre volumi sono in formato PDF e in lingua
spagnola.

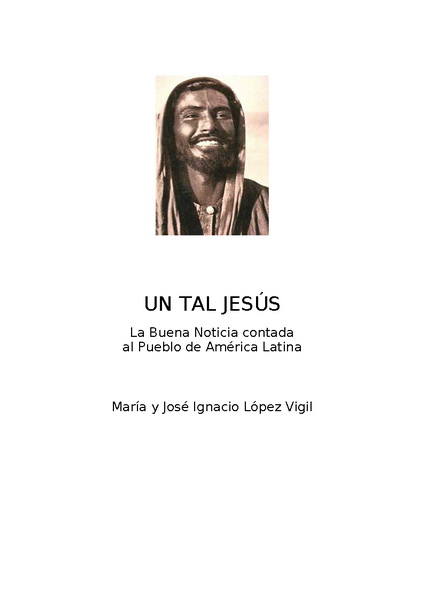
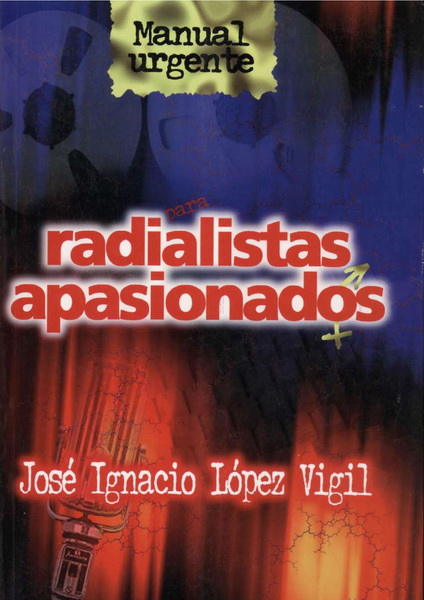
Tags: informazione, radio, oligopoli informativi, mezzi di comunicazione, nuove
tecnologie, radio comunitarie, radio indigene, software libero
Paolo Moiola




 Ai confini
Ai confini











.JPG) Diario di viaggio e
Diario di viaggio e.JPG)

.JPG)




.JPG)
.JPG)
.JPG)

.jpg) Una storia coloniale
Una storia coloniale








.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)
.JPG) 1976-1980 / Rutilio Grande e monsignor Oscar
1976-1980 / Rutilio Grande e monsignor Oscar.jpg) L’arcivescovo Romero prese
L’arcivescovo Romero prese.JPG)
.jpg)

