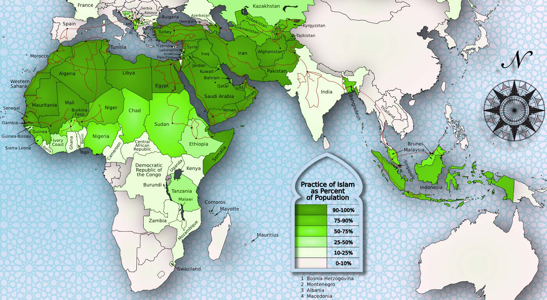CARLO E GERY, CUORE ASHÁNINKA
 Lui è un prete e missionario, lei un’infermiera. Arrivarono in Perú dalla provincia di Caserta rispettivamente 32 e 25 anni fa. Lui opera nella selva
Lui è un prete e missionario, lei un’infermiera. Arrivarono in Perú dalla provincia di Caserta rispettivamente 32 e 25 anni fa. Lui opera nella selvacentrale, tra le popolazioni indigene (shipibo, asháninka ealtre) calpestate dallo stato e dalle multinazionali. Lei
lavora nella periferia urbana di Lima con la popolazione a rischio, bambini e
adolescenti soprattutto.Si chiamano Carlo e Geremia (Gery) Iadicicco, fratello e sorella. Questa è la
loro storia. Piena di sorprese.
Villa El Salvador.
Sulla maglietta bianca scende un rosario di fattura indigena, sul viso
forte un vecchio paio di occhiali a goccia. Carlo Iadicicco, prete e missionario fidei donum, ha 67
anni, ma mette in mostra un fisico sportivo e un’energia coinvolgente che esce
prepotente dalla voce e dalla gestualità.
Padre Carlo è di passaggio a Villa El Salvador, periferia di Lima.
![]()
«Sono in Perú da 32 anni. A parte qualche
capatina in Italia, un breve periodo sulla costa e qui a Villa, la metà di
questi anni li ho trascorsi nella Cordigliera centrale delle Ande, in Ancasch.
Dal 1995 vivo invece nella selva subtropicale, conosciuta come bosco umido
amazzonico o selva bassa. Però, in quanto “missionario itinerante”, mi muovo in
un territorio vasto quanto l’Italia meridionale». Quell’Italia meridionale da
cui padre Carlo proviene: Bellona, provincia di Caserta. Mamma Anna e papà Ciro
Iadicicco hanno fatto le cose in grande: undici figli, di cui due emigrati in
Perú. Qualche anno dopo la sua partenza per il paese andino, Carlo è stato
infatti seguito dalla sorella Geremia detta Gery, maestra e infermiera, che a
Villa El Salvador vive e lavora.
DA GUSTAVO
GUTIÉRREZ AGLI INDIOS
«Erano gli anni Settanta ed io – racconta padre Carlo – ero
un giovane di belle speranze dentro il contesto della Chiesa. Ci fu un
terremoto devastante, che fece oltre 80 mila vittime. Io però cominciai a
interessarmi di Perú non soltanto a causa di quel tragico evento, ma anche
perché vi operava una Chiesa che faceva un cammino molto interessante,
capeggiata dal vescovo di Chimbote, mons. Bambarén1. A Chimbote c’erano le
prime conferenze di Gustavo Gutiérrez sulla teologia della liberazione2. Io ne
ero affascinato sia dal punto di vista intellettuale che umano. Qualche anno
dopo questi eventi, riuscii a farmi mandare in Perú».
![]()
Oggi padre Carlo lavora nel dipartimento di Ucayali, nella
zona centro-orientale del Perù, al confine con il Brasile. Ha una parrocchia
nella cittadina di Bolognesi, provincia di Atalaya. Tuttavia, egli si descrive
come un «missionario itinerante».
«La maggior parte della mia quotidianità la passo andando di
comunità in comunità. E ciò mi impedisce di avere una équipe pastorale, con la
quale sarebbe difficile muoversi. C’è stata anche una circostanza scatenante
che mi ha fatto pendere per questo stile di vita. È stato quando ho cominciato
a seguire un gruppo di indios – un sottogruppo di Nahua – che erano stati
cacciati dai luoghi dove vivevano da un’invasione di madereros (tagliaboschi).
Il mio primo contatto è stato invece – era il 1995 – con gli indigeni della
famiglia asháninka del Basso Urubamba e del Tambo. Da allora ho scoperto che io
potevo dare senso alla mia vita di missionario e di uomo sposando la causa
indigena».
Per raggiungere i diversi villaggi, si muove specialmente
via lancia o canoa, percorrendo il grande Ucayali e i suoi affluenti. Oltre che
con gli Asháninka, padre Carlo lavora con gli Shipibo-Conibo, ma ha contatti
anche con gruppi di Yaminahua, Amahuaca e Cashinahua.
Spesso, almeno per le persone estranee alla tematica, gli
indigeni sono un’entità unica e omogenea. Non è così.
«Quello indigeno – spiega il missionario – è un mondo di
straordinaria ricchezza e varietà. Tuttavia, esiste una matrice comune che lo
attraversa e che lo rende differente dal nostro Occidente. Il mondo indigeno
non prevede un’esistenza fatta di accumulazione di beni. In secondo luogo, noi
occidentali, a partire dalla cultura greca e dalla filosofia socratica in
particolare, abbiamo diviso il mondo in Dio, uomini e natura. I popoli indigeni
non prevedono una divisione tanto meccanica. Al contrario, cercano una vita di
armonia con se stessi, con la natura e con gli spiriti».
Padre Carlo ha idee sue. Come quando nega l’esistenza dei
popoli isolati («un’esagerazione di etnologi e antropologi», sostiene) o quando
contesta il sistema delle Nazioni Unite sulla riduzione delle emissioni dovute
alla deforestazione3. Ma diventa serio e perentorio quando spiega le emergenze
attuali.
«Il primo problema è il collasso dell’Amazzonia. Io non mi
iscrivo dentro il grande, rispettabile e ammirevole movimento ambientalista. Né
voglio fare del terrorismo ecologico. Io sono semplicemente un prete che vede
nella natura e nell’Amazzonia una creazione di Dio. A me interessa la vita, sia
essa umana, animale o vegetale. Il fatto certo è che la sopravvivenza delle
popolazioni indigene è legata in maniera indissolubile all’ambiente in cui esse
vivono. Tre quarti del territorio amazzonico del Perú è in concessione a
compagnie straniere che vanno ad operare direttamente su terre, territori e
risorse dei popoli indigeni».
Dal punto di vista dello sfruttamento petrolifero, la vasta
zona geografica dove opera padre Carlo corrisponde al Lotto 1264. Titolare
della concessione è la True Energy, società petrolifera a capitale canadese. «Si
sono piazzati con alcuni pozzi anche se il petrolio è di pessima qualità e
molto profondo. Con un prezzo oltre i 100 dollari al barile anche un prodotto
scadente genera profitti. Questi stanno rovinando tutto e non hanno nessun
contatto con le popolazioni indigene del luogo. Arrivano con l’elicottero,
usato per portare di tutto, fin’anche l’acqua in bottiglia per gli operai. La
mia avversione non è soltanto verso l’inquinamento ambientale, ma anche verso
un inquinamento che è etico, morale e civile».
La tracotanza delle compagnie minerarie è conosciuta. In Perú,
nulla è cambiato dopo i fatti di Bagua (i tragici scontri tra indigeni e
polizia)5 e dopo l’approvazione della legge di consultazione preventiva delle
popolazioni indigene6. Nel Perú della crescita economica su base estrattiva, il
«pericolo-tenaglia» è concreto: nel sottosuolo ci sono le risorse petrolifere,
sopra c’è il legname pregiato, in mezzo i popoli indigeni.
«Purtroppo – spiega padre Carlo -, si è diffuso un virus che
vede l’Amazzonia come un magazzino di beni da depredare. L’utopia è sempre
migliore della realtà. L’utopia ha mosso i grandi uomini, da san Francesco al
Mahatma Gandhi. La soluzione utopica sarebbe di rendere l’Amazzonia off-limits».

Se l’utopia non è praticabile (almeno per il momento), la
domanda è: cosa si può e deve fare?
«Facciamo un esempio – spiega -, comparando la situazione
del Canada e della Svezia a quella dell’Amazzonia. Da secoli il Canada e la
Svezia riescono a vendere i propri pini senza compromettere i loro boschi,
perché il Perú non potrebbe vendere il cedro e il mogano senza distruggere le
proprie foreste? Ecco, almeno uno sviluppo sostenibile di questo tipo andrebbe
perseguito. Certamente non è facile, considerando che queste imprese
transnazionali sono più forti degli stati, soprattutto di stati come il Perú».
Padre Carlo è un uomo di cultura: sa spaziare con cognizione
di causa dalla Bibbia a Gramsci. Ma è anche e soprattutto un uomo pratico che,
al cospetto della realtà, vuole poter agire concretamente. «Con Gery, ho sempre
sostenuto che la nostra filosofia deve essere dettata dalla “passione per il
possibile”. Che significa: facciamo quello che possiamo fare, partendo da
relazioni microsociali. Se cerchiamo lo scontro, dobbiamo sapere che
storicamente i poveri e dunque anche gli indigeni hanno quasi sempre perso.
L’importante è ricordare che gli indigeni non sono relitti storici. Né sono
quelli descritti da Rousseau con il mito del buon selvaggio7. Faccio un esempio
banale: se dai a un indigeno un cellulare, puoi essere certo che non se lo
scollerà dall’orecchio finché vive. Oppure si guardi ai giovani indios che
studiano in città. Quando tornano al villaggio, passano con totale disinvoltura
dall’indossare scarpe e occhiali a camminare a piedi nudi e con le frecce in
mano. Io li chiamo “pendolari della cultura”».
Chiediamo a padre Carlo se, a suo parere, la causa indigena
non finisca per interessare soltanto a ristretti gruppi di persone come, ad
esempio, antropologi, etnologi e ambientalisti.
«Non lo credo. Gli indigeni sono essenziali per il mondo non
soltanto a motivo dell’ecosistema in cui essi si muovono ma anche per le
alternative di vita e di modello economico che portano avanti. Per questo ne ho
la certezza: la causa indigena non riguarda soltanto i popoli indigeni ma tutta
l’umanità».
Geremia detta Gery ha ascoltato in rispettoso silenzio la
nostra conversazione con il vulcanico fratello missionario. Ma anche lei ha
molte cose da raccontare (la sua storia qui sotto)8. Una, la più
bella tra tutte, le siede accanto. Sono Shany e Gery, sorelline asháninka, che
lei ha adottato e che ora si stringono attorno allo zio Carlo. Prete italiano
dal cuore asháninka.
Note
1 – Sulla figura di mons. Bambarén si legga l’intervista La
vita prima del debito (MC, maggio 2000), a cura di Paolo Moiola.
2 – Su Gustavo Gutiérrez si leggano le interviste Gli esclusi
non si arrenderanno (MC, febbraio 1998) e Ma i giovani statunitensi mi dicono
che… (MC, dicembre 2003), entrambe a cura di Paolo Moiola.
3 – Si tratta del programma delle Nazioni Unite denominato «Redd».
Il sito ufficiale: www.un-redd.org.
4 – Sulla questione dei lotti in cui è stato suddiviso il
Perú, si legga: Paolo Moiola, Splendori e miserie del lotto 122, MC, novembre
2011.
5 – Gli scontri avvennero il 5 giugno 2009. Lasciarono sul
terreno almeno 33 morti, tra indigeni e poliziotti. Il numero reale di vittime
potrebbe però essere stato maggiore.
6 – Si tratta della Legge 29785, del 6 settembre 2011, dal
titolo di: «Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u
originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización inteational del
trabajo (Oit)».
7 – Secondo il «mito del buon selvaggio», in origine l’uomo è
un animale buono e pacifico, corrotto successivamente dalla società e dal
progresso.
8 – Le foto di questo reportage e la foto della copertina
del numero sono di Annalisa Iadicicco e Marlon Krieger: www.annalisaiadicicco.com.

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; }
Box:
Geremia Iadicicco
Dagli ospedali dell’Italia ai centri di salute della selva
amazzonica. Dalle scuole italiane a quelle di Villa El Salvador. Un percorso professionale
ma soprattutto di vita.
Villa El Salvador. Non diremo l’età di Geremia detta Gery
perché non sta bene. Diremo soltanto che porta benissimo i suoi anni. Quando ha
poco meno di 18 anni, parte da Bellona, provincia di Caserta, per andare a lavorare
al Nord, in Liguria, con il suo diploma di maestra sotto il braccio. Lavora
come maestra-educatrice per 5 anni in vari istituti dove, prima della riforma
della scuola, si tenevano i bambini con qualche problema. Dopo la riforma,
questi istituti vengono chiusi e Geremia decide di frequentare una scuola per
infermieri professionali all’ospedale Galliera di Genova. Ottenuta la
qualifica, per 13 anni rimane fedele al suo ruolo di infermiera-caposala. Poi
la svolta.
«In quegli anni – racconta – maturai il desiderio di
viaggiare e inserirmi in un altro contesto sociale e politico, per darmi
l’opportunità di vivere, in una forma più coerente e autentica, i miei ideali
cristiani, politici e sociali. Scelsi il Perú perché lì viveva da molti anni
mio fratello Carlo, sacerdote e missionario, con cui condividevo molti di
quegli ideali».
Gery parte da Genova 25 anni fa con la Ong Mlal (Movimento
laico America Latina), inserita in un progetto di «Salute comunitaria», che si
svolge alla periferia di Lima, in una città in costruzione chiamata Villa El
Salvador, dove tuttora vive. Negli anni successivi, lavora per diversi progetti
sociali e di sviluppo, sempre all’interno di gruppi professionali impegnati con i settori della
popolazione più a rischio, come bambini e adolescenti. Trova aiuto e supporto
in molte persone: «Sono stata costantemente accompagnata – ricorda lei con
riconoscenza – da persone di alto valore morale e grande sensibilità sociale,
sia peruviani che italiani. Mio fratello Carlo, la mia famiglia, amiche e amici
inseparabili hanno fatto e fanno il possibile per aiutarmi – non soltanto dal
punto di vista economico – nella realizzazione dei progetti a cui mi sono
dedicata e ancora oggi mi dedico».
Gery trascorre tre dei suoi venticinque anni in Perú nella
selva amazzonica, accompagnando il fratello nella sua missione dedicata ai
nativi di varie etnie. Lavora in un piccolo progetto di salute, con i promotori
di varie comunità indigene, asháninka soprattutto. Condivide le proprie
conoscenze della medicina occidentale, ma impara anche i fondamenti della
medicina indigena.
«Questi anni vissuti nella selva furono per me i piú
significativi, soprattutto sul piano umano e personale. Dalla selva infatti
portai a Villa El Salvador il regalo più bello: una bimba asháninka a cui demmo
il nome di Shany. Aveva solo un anno, ora ne ha 16 ed è stata raggiunta dalla
sorellina Gery di 11 anni, che vive con noi da 6».
A vivere con loro c’é anche la nipote Paola, che collabora
nel programma di cui Geremia Iadicicco è responsabile. Si tratta di un progetto
educativo che si svolge nella periferia di Villa El Salvador. «Circa 13 anni fa
– racconta -, al ritorno dalla selva, insieme ad un gruppo di persone iniziammo
un lavoro con bambini e adolescenti della zona periferica della città. Era la
zona più povera, abitata da una popolazione emarginata ed esclusa. Creammo due
programmi. Il primo è formale: una scuola matea, “Arenitas del Mar”, che
adesso è anche elementare. Il secondo è invece un doposcuola comunitario –
l’abbiamo chiamato “Escuela Deporte y Vida” (Scuola sport e vita) -, aperto a
tutti i bambini, bambine ed adolescenti, che cercano uno spazio dove poter
risolvere le loro necessità: fare i compiti, stare insieme facendo sport, arte,
manualità, così come dice il nome». Questi programmi sono gestiti dal Cedec («Centro
de educación y desarrollo comunitario»), un’associazione senza scopo di lucro
di cui Gery è presidente.
I progetti di Geremia Iadicicco e del fratello Carlo hanno
trovato l’entusiastico appoggio di molti abitanti di Bellona, loro paese
natale. Tanto che, nella cittadina casertana, sono nate due associazioni di
supporto, la recente «Pachacamac» e soprattutto «Alas de Esperanza»1.
Quest’ultima è nata come gruppo musicale che suona musica andina con strumenti
tipici della tradizione musicale latinoamericana. Quando una favola diventa
realtà, anche la musica deve essere all’altezza.
de Esperanza» (Ali di speranza): www.alasdeesperanza.it. Sul sito è possibile
ascoltare brani della loro musica.
Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; }
Paolo Moiola