.jpg) Dopo la morte di Hugo Chávez e le elezioni del 14 aprile.
Dopo la morte di Hugo Chávez e le elezioni del 14 aprile.
Il 5 marzo 2013 è morto Hugo Chávez.
Personalità forte e di enorme carisma, il presidente venezuelano ha segnato la
storia latinoamericana degli ultimi 15 anni. È stato un personaggio grandemente
amato e grandemente odiato. Dell’opera
di Chávez, della risicata vittoria del nuovo presidente Nicolás Maduro e dei
problemi del paese abbiamo parlato con padre Pablo Urquiaga, parroco in un
quartiere popolare di Caracas. Queste sono le sue risposte, appassionate e mai
banali.Hugo Chávez Frias, presidente del Venezuela (Repubblica
bolivariana del Venezuela), è morto il 5 marzo 2013. È stato sconfitto da un
tumore all’età di 58 anni.
Personaggio unico e controverso, amato dalla maggioranza
del suo popolo, odiato dalle oligarchie di tutto il mondo, deriso e insultato
dai principali media inteazionali, Hugo Chávez si era imposto in tutte le
elezioni venezuelane a partire dal 1998. Nell’aprile del 2002 era stato deposto
da un colpo di stato guidato da Pedro Carmona Estanga, presidente di Federcameras
(la Confindustria locale), con l’appoggio di Washington e Madrid, delle
televisioni private del paese e della Chiesa cattolica venezuelana. A partire
da quegli eventi i rapporti del presidente Chávez, cattolico dichiarato, con la
gerarchia della Chiesa venezuelana sono sempre stati tesi, con vicendevole
scambio di accuse e parole forti.
Per discutere del ruolo avuto da Chávez nella storia
recente del Venezuela, dei principali problemi del paese e dei rapporti con la
Chiesa cattolica abbiamo conversato lungamente con padre Pablo Urquiaga Feández.
Nato nel 1945 a Pinar del Río, Cuba, dopo alcuni anni a Miami, nel 1968 Pablo
Urquiaga arriva in Venezuela. Conclude gli studi all’Università cattolica Andrés
Bello di Caracas. Nel 1975 viene ordinato sacerdote. Dopo 4 anni a Petare, nel
1980 diventa parroco della chiesa La Resurrezione del Signore, a
Caricuao, un quartiere di Caracas abitato da classi medio-basse.
 Padre Pablo, in Europa e in generale nel mondo
Padre Pablo, in Europa e in generale nel mondo
occidentale il Venezuela di Hugo Chávez ha sempre goduto di una pessima stampa.
Ad esempio, in occasione delle elezioni di ottobre 2012, i principali
quotidiani italiani – Corriere della sera, La Stampa, la Repubblica –
hanno fatto a gara per scrivere editoriali (a volte per mano di persone che mai
sono state in Venezuela) contro il presidente Chávez. Qualche anno fa Missioni
Consolata pubblicò una serie di reportage sul paese e ci furono proteste
perché non si parlava male di Chávez. Da prete cattolico, come spiega questa
nomea?
«La mia opinione è che tutte queste persone non hanno
conosciuto il presidente Chávez. Lo ripeto ogni volta anche alla mia stessa
famiglia: voi vi accanite contro un “mostro virtuale” – che non esiste e che
non è mai esistito – chiamato “Chávez”. Questo mostro è stato costruito
attraverso i media che io definisco “perversi” in quanto strumenti di
manipolazione e confusione sociale, sottoposti a precisi interessi economici e
politici. Media creati dalle oligarchie per opprimere e sottomettere la povera
gente. Media non interessati a fare conoscere la vera immagine di Chávez.
Il vero Hugo Chávez, profeta e martire, si è visto il 5
marzo 2013, giorno in cui il Dio di Gesù lo ha glorificato e milioni di persone
hanno reso gloria a Dio per la sua vita. Persone che hanno dimostrato il loro
apprezzamento e il loro amore formando lunghe processioni davanti al suo
feretro esposto nella Scuola militare di Caracas. Code che sono durate 10
giorni lungo le 24 ore senza mai fermarsi. Siamo stati testimoni in prima
persona di un evento che nessun mezzo di comunicazione ha potuto nascondere. Io
ne sono convinto: il Dio di Gesù lo ha glorificato attraverso il suo popolo,
quello più umile e semplice».
Quando una persona viene colpita da una grave malattia,
ci dovrebbe essere più rispetto, più umana pietas o – come dovrebbe avvenire
per i credenti – più carità cristiana. Con Chávez non è stato così. Al
contrario, avversari in patria e fuori ne hanno approfittato per chiedere il
suo allontanamento. Quando infine è morto, molti hanno trattenuto a stento il
proprio compiacimento. Perché?
«È vero. In Venezuela e nel mondo molti hanno pregato per
la sua morte, credendo che egli fosse un vero mostro. Altri perché lo odiavano
come fu odiato Gesù di Nazareth, per invidia, vendetta e sete di potere. Hugo
Chávez era venuto ad “aprire gli occhi dei ciechi”, per far prendere coscienza
a un popolo sottomesso. Il presidente ne ha risvegliato la dignità. Tutto
questo non poteva essere accettato dai potenti, vale a dire da quelli che si
ritengono “migliori di tutti gli altri”.
Era accaduto lo stesso per Gesù di Nazareth e per
l’arcivescovo Romero 33 anni fa in Salvador, e ancora per Gandhi in India e
Martin Luther King negli Stati Uniti. Non dimentichiamo che una parte degli
oppositori non credevano che il presidente fosse malato, ritenendo la malattia
un imbroglio come quelli di cui essi sono normalmente artefici. Senza accennare
al fatto che molti tra noi hanno forti sospetti che il cancro del Presidente
sia stato indotto dai suoi stessi nemici, stranamente sempre molto ben
informati sull’evoluzione della malattia».
In Occidente si contesta la lunga permanenza di Chávez al
governo del Venezuela. Non interessa il fatto che il presidente sia sempre
stato scelto tramite libere elezioni, strumento principe della democrazia. Si
parla senza mezzi termini di «caudillismo» e spesso di dittatura. Cosa pensa al
riguardo?
«Hugo Chávez è stato il più grande democratico che questo
paese abbia avuto in tutta la sua storia repubblicana. Un capo o un dittatore è
colui che si impone contro la volontà
popolare. Hugo Chávez è stato rieletto molte volte dal suo popolo, con elezioni
limpide e certificate, con un Consiglio nazionale elettorale pulito.
Il contrario di quanto normalmente avveniva nei
governatorati di Miranda e Zulia (i due stati con il più vasto bacino
elettorale), vinti più volte dall’opposizione tramite frode e compravendita dei
voti. Il popolo non avrebbe mai prevalso, se non attraverso un numero enorme di
voti, assai più difficile da adulterare. Proprio ciò che accadde nel dicembre
1998, quando Chávez conquistò per la prima volta la presidenza della Repubblica
bolivariana del Venezuela».
Nel 2009 un referendum popolare approvò – con scandalo e
clamore mondiali – il cambio degli articoli della Costituzione che vietavano la
rielezione. Quella stessa Costituzione che, con l’articolo 72, consente di
revocare tutte le cariche elettive dopo metà mandato. Un esempio straordinario
di democrazia che i paesi occidentali e i media hanno quasi sempre
dimenticato…
«È così. Con la nuova Costituzione, voluta da Chávez nel
1999, siamo andati oltre la “democrazia rappresentativa” in cui un eletto, dopo
essere stato votato, fa quello che vuole, in cui occorre aspettare cinque anni
per “cacciare dal potere” un rappresentante inadeguato o indegno con il rischio
di votare un altro con le stesse abitudini del precedente. La Costituzione
bolivariana ha creato una “democrazia partecipativa e protagonista”, dove la
gente non soltanto vota ma il “prescelto”, una sorta di portavoce del popolo,
deve rendere conto del suo operato. E se, dopo due anni, questo viene giudicato
insoddisfacente è possibile revocare il mandato. L’opposizione vuole salvare la
sua “democrazia”, mentre la gente comune vuole difendee “una diversa”, quella
istituita con la Costituzione del 1999. Questa è la differenza».

Il Venezuela è uno dei principali produttori mondiali di
petrolio. Lei ritiene che il governo abbia utilizzato bene le grandi entrate
petrolifere?
«La società Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una
delle aziende più ricche e importanti del mondo, era proprietà privata di circa
40.000 famiglie. Ovvero 200.000 venezuelani erano i padroni della sola impresa
in grado di produrre ricchezza per il paese. Peccato che il Venezuela abbia 16
milioni di abitanti. Prima di Chávez, soltanto una piccola percentuale della
popolazione si avvantaggiava del Venezuela saudita. Con i miei occhi sono stato
testimone di questa spaventosa ingiustizia. Venezuelani che arrivavano a Miami
per comprare edifici di quattro piani e venti appartamenti pagando tutto in
contanti. Gli statunitensi rimanevano stupefatti perché nessun’altro agiva così.
Pensavano che tutti i venezuelani fossero ricchi. Per decenni un’esigua
minoranza ha sperperato la ricchezza petrolifera del paese. Oggi il petrolio
appartiene a tutte e tutti i cittadini del Venezuela».
Gran parte dei profitti derivanti dal petrolio sono stati
utilizzati per finanziare le cosiddette «misiones». I critici – più o meno
attendibili – parlano di spreco e di occasione persa per far progredire
l’economia del Venezuela.
«I proventi del petrolio – pur in presenza della
corruzione – sono stati messi a disposizione dei più bisognosi, attraverso gli
investimenti nelle missioni sociali.
Pensiamo ai servizi per la salute della Missione Barrio
Adentro. O alle missioni nel campo dell’istruzione: la Missione Robinson
attraverso la quale milioni di persone analfabete hanno imparato a leggere e
scrivere; la Missione Ribas, con la quale chi già aveva un diploma di scuola
primaria ha potuto accedere alla secondaria e ottenere un diploma; e infine la
Missione Sucre, attraverso la quale molti sono stati in grado di studiare
all’Università e si sono laureati in diverse specialità. Sogni diventati realtà
per molti emarginati. E ancora ricordo la Missione Negra Hipolita, attraverso
la quale gente senza fissa dimora è stata recuperata a un’esistenza dignitosa.
E poi la Missione Vivienda, con cui migliaia di famiglie hanno beneficiato di
una casa dignitosa, soprattutto coloro che erano rimasti danneggiati da eventi
naturali. Le missioni hanno aiutato le classi più povere, ma ovviamente sono
costate un sacco di soldi. In esse è stata investita la maggior parte degli
utili di Pdvsa, utili che prima finivano nelle mani dei privilegiati di questo
paese.
Questa è la verità che l’opposizione e i media
occidentali non vogliono riconoscere. Per costoro investire nel sociale è un
assurdo economico. “Perché sprecare denaro con persone che non producono?”,
affermano».
Al successo delle missioni fanno da contraltare gli
insuccessi in materia di sicurezza. Leggendo i giornali e alcune statistiche,
parrebbe che il Venezuela sia un paese con alti o altissimi livelli di
criminalità comune. È così?
«Purtroppo è così. Il problema dell’insicurezza peggiora
ogni giorno. È una questione che non è nata con Chávez, ma che deriva dal
deterioramento di un sistema capitalista corrotto ereditato dal passato. Non è
un problema risolvibile con la bacchetta magica. Per affrontarlo seriamente
occorre cambiare la “cultura della corruzione” che ancora domina il nostro
paese e tutto il mondo. Giudici e avvocati corrotti sono ancora in vendita per
denaro, l”idolo” che occorrerebbe distruggere. C’è la polizia abituata a farsi
corrompere. C’è il narcotraffico, che si è infiltrato nel governo e
nell’opposizione. Ma anche all’interno delle classi popolari, dove spesso i
bambini vengono arruolati come “muli”, cioè come trafficanti di droga
che – in quanto minori – non sono imputabili per i loro reati. In questo modo i
“colletti bianchi” non vengono mai toccati.
Il problema è serio e complesso. Il governo sta facendo
molti sforzi per affrontare la questione, ad esempio con una campagna per il
“disarmo”. Ha già raggiunto alcuni risultati, ma non quelli che ci
aspettavamo. In verità, abbiamo bisogno di “disarmarci nella mente e nel cuore”,
perché qui sta il problema principale. Noi della Chiesa, in forza del nostro
ruolo, stiamo lavorando in questa direzione».

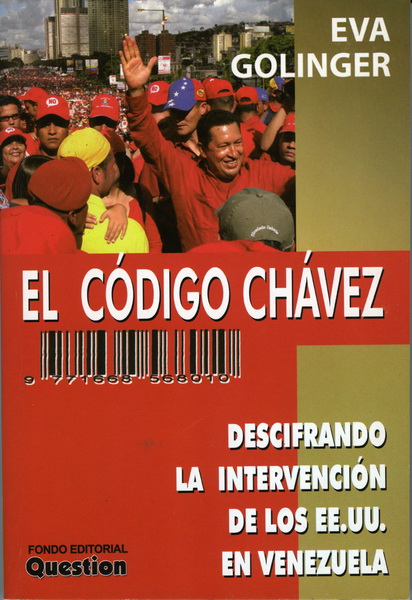
Altra accusa mossa al Venezuela riguarda la libertà di
espressione. I proprietari dei media venezuelani sostengono di essere
danneggiati dal governo bolivariano con la legge sulle Tv e con la «cadena
nacional», cioè l’obbligo di trasmettere programmi o messaggi delle autorità
governative. Cosa risponde a queste critiche?
«Le “catene televisive” del presidente – e in
particolare il suo programma “Aló, Presidente” – hanno rappresentato
l’unico modo che il governo di Hugo Chávez aveva per comunicare con veridicità
tutto quello che stava facendo la rivoluzione bolivariana. Una verità
completamente occultata dai media privati.
Prima della rivoluzione in questo paese tutti i mezzi di
comunicazione erano in “mani private” ovvero nella totale disponibilità delle
oligarchie che manipolavano (e continuano a manipolare) le persone con le loro
bugie o “mezze verità” per confondere e favorire i propri esclusivi interessi.
Senza dubbio, i media privati, molto più forti e potenti in termini di qualità
e portata rispetto alla televisione pubblica, sono perennemente “in catena
nazionale”, cercando di distorcere la realtà 24 ore al giorno. In Venezuela
dobbiamo affrontare una vera e propria “guerra mediatica”».
Una guerra che ebbe il suo apice durante il golpe
dell’aprile 2002 quando i canali televisivi privati ebbero un ruolo di primo
piano nella (temporanea) destituzione del presidente Chávez.
«Appunto per questo, nel dicembre 2004, è stata emanata
la “Legge di responsabilità sociale nelle radio e in televisione” (nota con
l’acronimo di Resorte), che regola l’uso dei mezzi di comunicazione di
massa.
Mi ricordo che, dopo averla tenuta tra le mani e averla
letta attentamente, andai a trovare un amico e fratello, “dottore in Teologia
morale”. Gli chiesi la sua opinione sulla legge. Egli mi rispose: è così buona
che l’unica cosa che manca sono le “citazioni bibliche” a margine. Al ché io
gli ribattei: e perché voi non lo dite in pubblico? Mi rispose: se lo
dicessimo, direbbero che siamo “chavisti”, cioè partigiani di Chávez».
Oltre a quella legge, i media e l’opposizione contestano
la chiusura – nel maggio 2007 – del canale privato Radio Caracas de Television
(Rctv).
«In Venezuela non si è mai chiuso alcun media
dell’opposizione. Per quanto riguarda il caso di Rctv, la sua cessazione fu
determinata dal mancato rinnovo della concessione. Questa non fu rinnovata a
causa della violazione della legge e dell’uso improprio dell’etere, uno spazio
pubblico di cui – è bene ricordarlo – non si è mai proprietari, essendo esso un
bene di tutti».
Il Venezuela di Chávez ha ottimi rapporti con Cuba. Ciò
viene preso a pretesto dagli Stati Uniti per attaccarlo. Tuttavia, alcune
relazioni con paesi come l’Iran e la Bielorussia sono effettivamente
discutibili. Che strategia segue il Venezuela nel campo delle relazioni
inteazionali?
«La Repubblica bolivariana del Venezuela è una nazione
libera e indipendente e come tale ha il diritto di avere rapporti con tutti i
paesi che ritenga opportuno, senza alcun tipo di ingerenza straniera. Come
nazione noi desideriamo avere le migliori relazioni con tutti i paesi fratelli.
La sola cosa che pretendiamo è il rispetto per la nostra indipendenza e
sovranità. Condivido pienamente la politica internazionale esercitata dal
nostro presidente Hugo Chávez. Oggi il Venezuela è rispettato in tutto il mondo
anche per la sua capacità di aiutare i popoli più bisognosi. Ci siamo resi
conto che la nostra ricchezza – il petrolio – ci è stata donata dal Creatore
per servire le nazioni più povere e non per sfruttare gli altri o per regalarla
agli imperi di tuo, diventandone i servi. Abbiamo ottimi rapporti con paesi
di diverse culture e ideologie che ci rispettano e che non ci sfruttano come ha
fatto un tempo l’impero nordamericano. Ho la certezza che la politica
internazionale finora seguita continuerà anche con il nuovo presidente Nicolas
Maduro, che era stato cancelliere del presidente Chávez».
Nei suoi interventi pubblici, il presidente Chávez faceva
spesso riferimento alla propria fede, con citazioni dai testi sacri e
considerando Gesù Cristo un rivoluzionario ante litteram. Eppure, la
Chiesa cattolica, soprattutto la gerarchia venezuelana, è sempre stata un
durissimo avversario del presidente, tanto da dare il suo supporto al golpe
dell’aprile 2002. Come spiega questo atteggiamento?
«Io ho sempre creduto nella fede di Hugo Chávez, ma più
per quello che faceva che per quello che diceva. Ancora una volta mi permetto
di parafrasare il Vangelo secondo Matteo: “Dai suoi frutti l’ho conosciuto”.
Hugo Chávez, come un profeta, ha detto alcune verità a qualche alto esponente
della chiesa venezuelana (a volte io non ero d’accordo, non su quello che
diceva, ma come lo diceva). Costoro non erano abituati a sentirsi dire in
faccia, da qualcuno a quei livelli, alcune verità e ciò non è mai stato
perdonato. Il comportamento del presidente era interpretato come una “mancanza
di rispetto”. So che, in molte occasioni e in diversi modi, Chávez ha cercato
una riconciliazione o almeno un dialogo con loro. Inutilmente, in quanto alcuni
di essi si sono sempre opposti, trincerandosi dietro una posizione radicale
contro di lui, accusato di aver offeso la loro dignità. A quanto ho capito, è
questa la radice di un conflitto mai risolto».
Al di là delle sue personali speranze, secondo lei senza
Chávez la rivoluzione bolivariana potrà continuare?
«In varie occasioni il presidente Hugo Chávez disse: “Io
sono soltanto una semplice paglia mossa da questo uragano chiamato Rivoluzione
bolivariana”. Lui si considerava un servitore del popolo tanto da dire:
“Io non sono più Chávez. Chávez è tutto un popolo che grida: ‘Siamo tutti
Chávez’”».
Questo è lo slogan gridato dalla sua gente nei giorni
della morte…
«Questo non è un semplice “slogan”. È una realtà
diventata evidente in quelle lunghe file davanti alla sua bara di migliaia di
ammiratori che andavano a testimoniare la propria riconoscenza e le proprie
convinzioni. Il mondo ne è stato testimone. Sono convinto che lo spirito di Chávez
continuerà ad accompagnarci così come quello di Simón Bolívar che il presidente
seppe magistralmente “resuscitare dalla sua tomba”, dove i potenti
ipocritamente andavano a “onorare la sua memoria” e ad assicurarsi che l’eroe
continuasse “a riposare in pace e ben morto”. Vivo in questo paese da ben 45
anni e posso dire che questa rivoluzione si è generata nel popolo venezuelano
molti anni fa. Molti profeti popolari avevano già alzato la loro voce di
protesta (tra cui il famoso cantante popolare Ali Primera). Hugo Rafael, con molta
saggezza, ha saputo raccogliere l’ardore rivoluzionario del popolo venezuelano
e trasformarlo in un “potere sostanziale” attraverso un’assemblea costituente
(che funzionò da agosto a novembre del 1999, ndr) che ha prodotto la
migliore Costituzione delle Americhe (ma io direi del mondo)».
Le costituzioni sono fondamentali, ma spesso non si
traducono in fatti. Come vede il futuro del Venezuela, padre?
«Il futuro sarà l’occasione per approfondire
ulteriormente la nostra idea conosciuta come “Socialismo del Secolo XXI”».
Padre, lei vuole farmi licenziare! In questo mondo
parlare di socialismo è quasi una bestemmia, ancora di più se detto da un prete
cattolico…
«Ma è un socialismo molto diverso dagli esempi dei secoli
passati! Il passato è passato. Il socialismo alla venezuelana è più ispirato al
Vangelo di Gesù di Nazareth e alla spiritualità degli aymara della Bolivia; più
alle idee ecologiste e bolivariane che alle ideologie europee dalle quali
abbiamo comunque attinto alcuni elementi importanti e strategici. Questa è una
strada non soltanto per il Venezuela, ma per quella grande patria che è
l’America e per gli altri popoli del mondo, che desiderano unirsi. La
rivoluzione di Chávez, Bolívar, Martí, San Martín, Lincoln, Martin Luther King,
Gandhi continuerà con altri grandi spiriti che – io ne sono certo – sempre ci
accompagneranno. Il futuro è nostro finché non avremo bandito dalla terra la
fame, l’ingiustizia, lo sfruttamento e la malvagità».
 Intanto, padre Pablo, nelle elezioni di domenica 14
Intanto, padre Pablo, nelle elezioni di domenica 14
aprile 2013 Nicolás Maduro ha vinto di stretta misura. Il nuovo presidente non
sembra avere né il carisma né la statura politica di Hugo Chávez.
«Non nego che quella del 14 aprile è stata una vittoria
amara. Mi sono venute in mente le parole di Gesù: “Io ti assicuro che oggi,
questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, tu mi avrai rinnegato
tre volte” (Mc 14,30). Chávez è stato tradito non tre, ma un milione di volte
(tanti sono i voti venuti a mancare, ndr). È stato un risultato doloroso
e triste, ma la rivoluzione non si ferma e la nostra democrazia ha vinto una
nuova battaglia. E tuttavia, se un milione di persone hanno tradito, sette
milioni e mezzo di venezuelani sono rimasti fedeli.
Quanto al carisma e alla statura di Maduro, il problema
non sussiste. Egli non deve inventare nulla dato che il presidente Chávez ha
lasciato il programma di governo per i prossimi anni (Piano della patria).
Il neo presidente dovrà soltanto metterlo in pratica, aiutato da una compagine
governativa di sicuro valore e dalla nostra democrazia partecipativa».
________________________
Henrique
Capriles, candidato dell’opposizione e governatore di Miranda, non ha
riconosciuto la vittoria di Maduro (50,78% contro 48,95%), fomentando un clima
di violenza che ha provocato morti e feriti. Confermando la propria serietà
(certificata dal Centro Carter), il Consiglio elettorale (Cne) ha accettato il
ricorso e ha ordinato il controllo dei voti espressi elettronicamente. È infine
interessante ricordare che, nel referendum del 2007, la proposta di riforma
costituzionale presentata da Chávez venne bocciata con il 50,7% di «no». Il
presidente riconobbe subito quella sconfitta, prima ed unica della sua storia
politica.
Paolo Moiola
Paolo Moiola



 L’autore – Marco Pontoni è caporedattore all’Ufficio stampa
L’autore – Marco Pontoni è caporedattore all’Ufficio stampa
 Michele De Michelis
Michele De Michelis Nel
Nel

.jpg) Dopo la morte di Hugo Chávez e le elezioni del 14 aprile.
Dopo la morte di Hugo Chávez e le elezioni del 14 aprile.  Padre Pablo, in Europa e in generale nel mondo
Padre Pablo, in Europa e in generale nel mondo

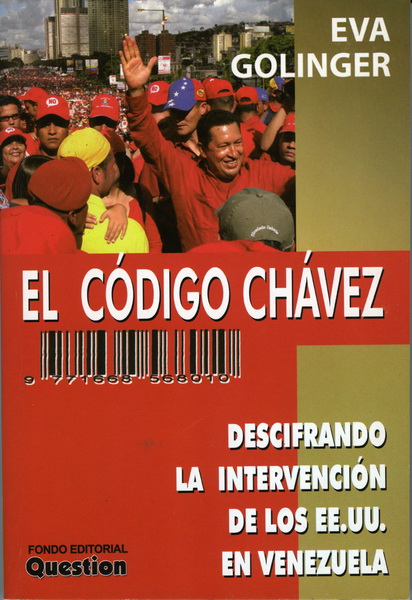
 Intanto, padre Pablo, nelle elezioni di domenica 14
Intanto, padre Pablo, nelle elezioni di domenica 14 Libertà di stampa a rischio
Libertà di stampa a rischio

 Media sotto tiro
Media sotto tiro


